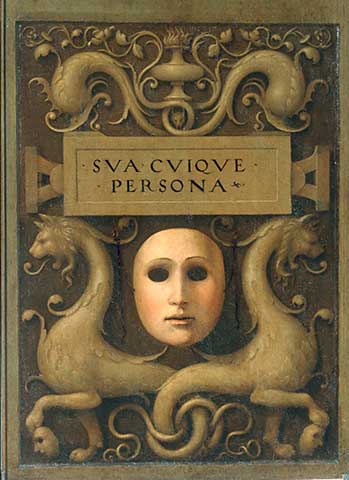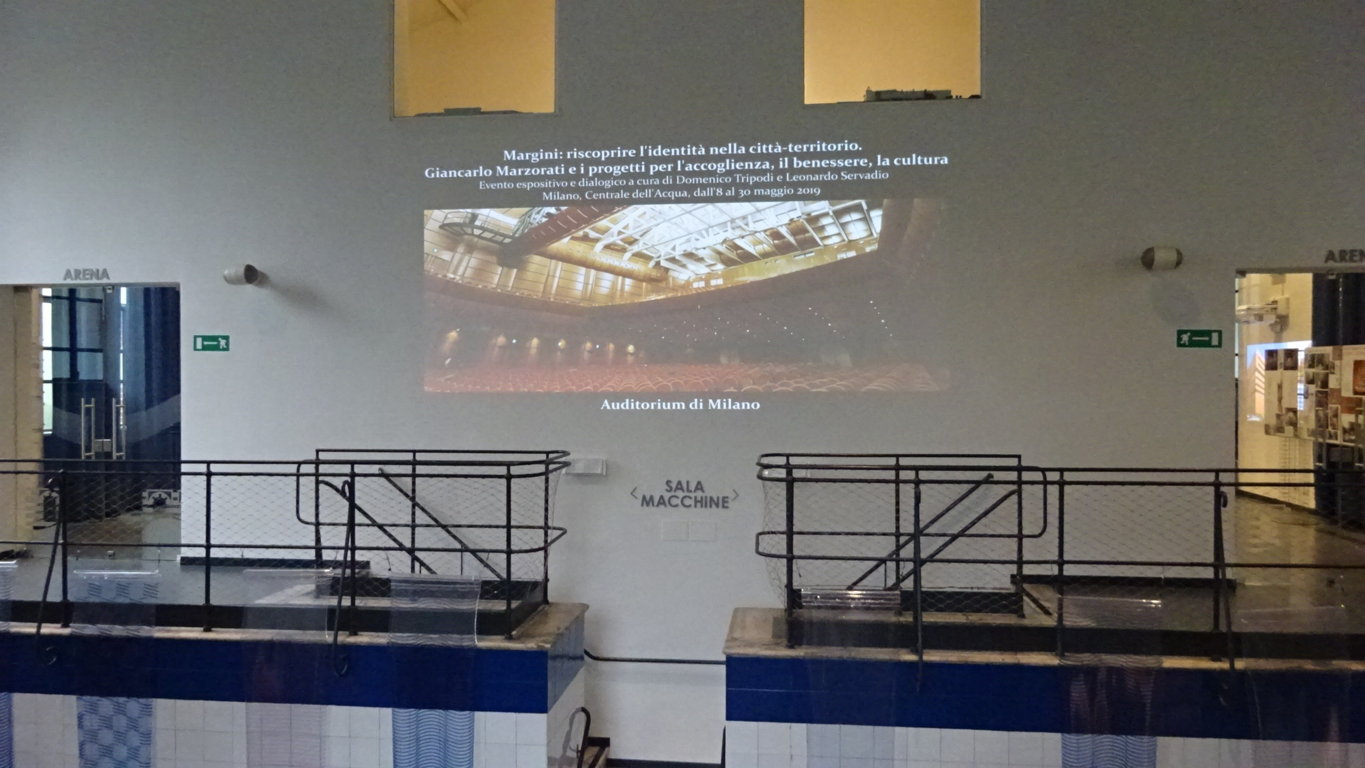MASCHERE, E … MASCHERINE
La storia della mascheratura, nelle sue più varie manifestazioni (e usi e significati), ed in particolare di quella del Medico della Peste
Parte Prima – Carnevale e Teatro
“Sua Cuique Persona” (A Ciascuno la Propria Personalità – Ridolfo Del Ghirlandaio, pittore fiorentino, 1510)
Il vecchio detto veneto “Le mascare val soeo in Carneval”, secondo il quale “Le maschere valgono solo a Carnevale”, come per tutte queste sagaci affermazioni della tradizione popolare che mai hanno un significato soltanto univoco, anche essa possiede una doppia valenza, a seconda di quanto si vuole affidare al loro contenuto, o nelle specifiche circostanze contingenti ed epocali per le quali essa si usa.
Indubbiamente per le grandiose feste carnevalesche, quel motto è – come si dice – perfettamente calzante, in quanto mai come a Carnevale il fulgore della mascheratura risulta tanto eclatante; ma nel percorso della storia la maschera ha assunto anche diversificate ragioni di esistenza e complesse attinenze d’uso che ne hanno segnato sviluppi ed evoluzioni piuttosto variegati, e perfino riscontri lontani e contrastanti, riconducenti ai loro specifici aspetti sociali e antropologici di periodi antichi e situazioni più attuali.
E sempre per questa odierna fase di pestifero riferimento al Covid, per il quale la Mascherina è diventata uno degli elementi riconoscitivi più precipui e semantici, mi pare opportuno verificare, sinteticamente, i più evidenti casi di maggiore emergenza, e pertinenza, di questo storico emblema di particolare abbigliamento facciale, nelle sue implicanti condizioni di utilizzo e di contenuti.
PER RICONOSCRE, PER OCCULTARE, PER AVVERTIRE
Se fondamentalmente, nelle sue manifestazioni socio-storiche, la Maschera ha sempre teso a nascondere la identità delle persone che la portavano, non sempre la mascheratura ha voluto determinare una situazione di nascondimento. E talvolta al contrario ha scelto di fornire espressamente il riconoscimento fisico delle persone cui essa veniva riferita, come per svolgere un ruolo per così dire neutrale di tipico avvertimento per la sua specifica funzione d’uso
Maschere di identificazione (attestazione riconoscitiva)
Le effigi fisiche riprese a stampo dai volti dei morti, di personaggi importantissimi o più comuni, porgono un tipico esempio di questa particolarità della maschera come elemento di connotazione – documentaria per i posteri – degli aspetti fisionomici dei defunti, e di conseguente identificazione fisica degli individui ritratti nelle loro particolarità specifiche del viso.
Il calco mortuario
Sono rimaste storicamente famose le eccezionali impronte facciali di grandi re ed imperatori, della antichità o recenti, come Agamennone e Tuthankamon o Napoleone [Figure 1-2 e 3], e di altri rinomati personaggi storici epocali e di più odierna attualità.
 Figure 1-3 – Tre esempi di maschere funerarie di importanti personaggi, antichi e recenti: la Maschera Funebre di Agamennone, plasmata da un ignoto artigiano acheo nel 1553-52 prima di Cristo [sopra]; la Effigie Funeraria di Tutankhamon anche essa di autore sconosciuto, eseguita nel 1323 avanti Cristo [sotto]; e la Maschera Mortuariadi Napoleone Bonaparte realizzata nel 1821 probabilmente dal medico e chirurgo militare inglese Archibald Arnott [in basso]. La prima, eseguita in lamina d’oro (minerale inalterabile) per durare in eterno, è stata ritrovata nel 1876 a Micene (nel Peloponneso in Grecia) dall’archeologo tedesco Heinrich Schliemann (il famoso scopritore della antica città di Troia) durante gli scavi nella tomba del re acheo; la seconda, modellata sul sarcofago del faraone egizio defunto, è stata scoperta dall’egittologo britannico Howard Carter nel 1922 nella sua tomba nella Valle dei Re presso Luxor in Egitto; e la terza, attuata in cera sùbito dopo la morte del generale e imperatore francese, dal dottore destinato alla cure del prigioniero sulla Isola di Sant’Elena (situata nel mezzo dell’Oceano Atlantico Meridionale, di fronte alla Namibia)
Figure 1-3 – Tre esempi di maschere funerarie di importanti personaggi, antichi e recenti: la Maschera Funebre di Agamennone, plasmata da un ignoto artigiano acheo nel 1553-52 prima di Cristo [sopra]; la Effigie Funeraria di Tutankhamon anche essa di autore sconosciuto, eseguita nel 1323 avanti Cristo [sotto]; e la Maschera Mortuariadi Napoleone Bonaparte realizzata nel 1821 probabilmente dal medico e chirurgo militare inglese Archibald Arnott [in basso]. La prima, eseguita in lamina d’oro (minerale inalterabile) per durare in eterno, è stata ritrovata nel 1876 a Micene (nel Peloponneso in Grecia) dall’archeologo tedesco Heinrich Schliemann (il famoso scopritore della antica città di Troia) durante gli scavi nella tomba del re acheo; la seconda, modellata sul sarcofago del faraone egizio defunto, è stata scoperta dall’egittologo britannico Howard Carter nel 1922 nella sua tomba nella Valle dei Re presso Luxor in Egitto; e la terza, attuata in cera sùbito dopo la morte del generale e imperatore francese, dal dottore destinato alla cure del prigioniero sulla Isola di Sant’Elena (situata nel mezzo dell’Oceano Atlantico Meridionale, di fronte alla Namibia)
 Figura 2
Figura 2
 Figura 3
Figura 3
Tra questi si possono ricordare, effettuando una sinteticissima escursione nelle attività e professioni, eccelsi statisti internazionali (come Oliviero Cromwell, Abramo Lincoln, Vladimir Iliic Ulianov detto Lenin) [Figure 4-6], stimati artisti, letterati e poeti, e musicisti (quali Dante Alighieri, John Keats, o Ludwig Van Beethoven) [Figure 7-9], grandi religiosi o scienziati (Martino Lutero, Isacco Newton) [Figure 10 e 11], ai quali tutti la riproduzione facciale in cera o gesso (e talvolta perfino in marmo, liquido poi solidificato) ha servito a lasciare un indelebile ricordo del loro aspetto reale, allo stesso modo iconico che altrimenti pittori o scultori e narratori hanno saputo, con minore autenticità oggettiva ma attraverso l’artificio delle loro arti, identicamente esporre.
 Figura 4
Figura 4
Figure 4-6 – Maschere Funerarie di alcuni famosi statisti, della storia passata e della modernità: il calco, eseguito postumo nel 1661, del Lord Protettore inglese Oliviero Cromwell (foto di Corrado Gavinelli del 1993, con raddrizzamento della immagine del 2021) [sopra]; la Maschera in Vita di Abramo Lincoln del 1865 eseguita dallo scultore statunitense ottocentesco Clark Mills [sotto]; ed il volto di Lenin (Vladimir Iliic Ulianov, capo del movimento e partito bolscevico russo) plasmato nel 1924 dallo scultore sovietico Sergej Merkurov [in basso]. La effigie cromwelliana venne ricavata tre anni dopo la morte dello statista britannico in occasione dell’anniversario della morte sul patibiolo del suo acerrimo avversario Re Carlo I di Inghilterra, nel rituale della cosiddetta esecuzione postuma, in cui la salma riesumata veniva – nuovamente – impiccata, tagliata, e squartata. Il corpo del morto venne gettato in una fossa comune a Tyburn, nella periferia londinese (luogo famigerato per le pubbliche esecuzioni capitali afflitte ai condannati provenienti dalla prigione di Newgate a Londra). Soltanto la testa venne salvata, ed infilata su un palo per rimanere esposta, macabramente rinsecchita, davanti alla Abbazia di Westminster, dove restò per ben 24 anni, fino al 1685. Adesso la maschera è conservata nel Castello di Warvick, nella parte meridionale della città di Coventry. La faccia del Presidente degli Stati Uniti invece è stata realizzata a Washington riprendendola dal vero, soltanto 2 mesi prima dell’omicidio del politico americano; e quindi riproduce le sue reali fattezze fisionomiche da vivo, nell’anno della sua morte. Infine, la testa dello statista bolscevico al capezzale del suo letto di morte è stata realizzata dallo scultore sovietico Merkurov, famoso per i suoi ritratti veristici di personaggi russi importanti, che durante la sua carriera ha realizzato quasi 300 maschere di tale genere
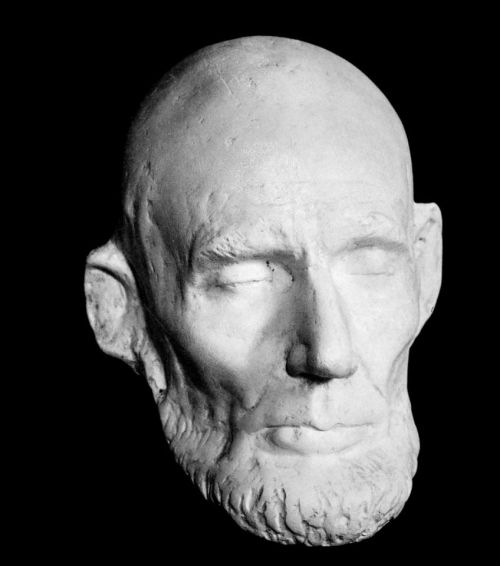 Figura 5
Figura 5
 Figura 6
Figura 6

Figure 7-9 – Tre immagini mortuarie di grandi personaggi della cultura letterario-artistica mondiale: del poeta e scrittore italiano Dante Alighieri, ritenuta del 1321 e ripresa dalla tomba ravennate del personaggio [sopra]; il volto, anche esso plasmato in gesso in vita nel 1816, del poeta inglese John Keats [sotto]; ed il viso del musicista tedesco Ludwig Van Beethoven, del 1827 [in basso]. La immagine dantesca non è – come per tradizione si tramanda – il calco autentico del personaggio, bensì una copia successiva eseguita nel 1483 dagli scultori bergamaschi Pietro e Tullio Lombardo. Le effigie keatsiana è stata riprodotta in gesso dal pittore storicista inglese Benjamin Robert Haydon 5 anni prima della morte della persona ritratta; mentre la maschera beethoveniana è proprio quella mortuaria, eseguita dall’artista tedesco Josef Dannhauer

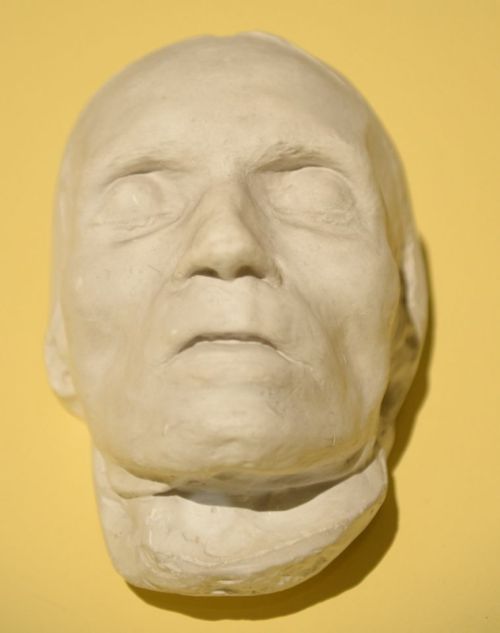 Figura 9
Figura 9
 Figura 10
Figura 10
Figure 10 e 11 – Le maschere funebri di un grande religioso (Martino Lutero) e di un eccelso scienziato (Isacco Newton): la prima in calco di cera eseguita dal pittore tedesco Lukas Furtenagel (allievo di Lucas Cranachi il Vecchio a Wittenberg, e poi attivo autonomamente a Halle) direttamente dal letto di morte del Padre della Riforma Protestante a Eisleben nel 1546 [sopra]; e l’altra (ripresa dalla Breve Storia del Popolo Inglese dello storico britannico John Richard Green pubblicato a Londra nel 1893) è una delle diverse copie velocemente preparate dopo la morte del fisico dall’artista fiammingo, di Anversa, Jan Michiel Rijsbrack (inglesizzato in Michael Rysbrack), che ne scolpì un esemplare in marmo da usare per la tomba newtoniana innalzata nella Abbazia di Westminster [sotto]. Divenuta di proprietà dello scultore Louis-François Roubiliac, virtuoso interprete del rococò anglo-francese, egli la usò per la Statua di Newton da lui scolpita nel 1755 nella Cappella del Collegio della Trinità a Cambridge in Inghilterra
 Figura 11
Figura 11
A ciascuno dunque la propria fisionomia, come ha suggerito secoli fa la suggestiva maschera ieratica che il pittore fiorentino rinascimentale Ridolfo Del Ghirlandaio ha dipinta nel 1510 [Figura 78]; che il calco riproduttivo non manca di restituire, sebbene spesso nell’ultimo ritratto senza vita.
Stampi diretti e loro elaborazioni plastiche
Una particolare specialista della riproduzione visuale dei personaggi importanti morti durante la propria esistenza, è stata la notissima artista ed impresaria francese della maschera funebre, la Signora Tussaud (Anna Maria Grosholtz) alsaziana strasburghese ma vissuta a Parigi prima, durante, e dopo la sconvolgente vicenda della Rivoluzione Francese; che per la sua eccezionale bravura nella riproduzione di calchi facciali umani, e la loro accurata ricostruzione scultorea indieme ai corpi degli individui loro appartenuti, ha saputo tramandare ai posteri le immagini reali di molti personaggi suoi contemporanei, dai monarchi francesi Luigi XVI e Maria Antonietta ai capi rivoluzionari quali Maximilien De Robespierre e Jean-Paul Marat fino a capaci condottieri tra cui Napoleone Bonaparte, ed altri protagonisti della sua epoca [Figure 12-14, e 15].

Figure 12-15 – La prodigiosa attività di restituzione fisionomica della cosiddetta Madama Tussaud (la artista e imprenditrice francese sette-ottocentesca Anna Maria Grosholtz), ricostruttrice in cera delle fattezze fisiche dei personaggi storici – e della propria epoca – più importanti. Nel suo ritratto esposto al proprio Museo di Londra, in una composizione che ha ricostruite le condizioni del suo lavoro nel periodo rivoluzionario francese quando la donna venne incaricata di rinvenire i corpi dei ghigliottinati famosi per riprodurne gli aspetti fisici in calchi di gesso [sopra]; mentre nelle altre immagini sono riportare la effigie autentica della Regina di Francia Maria Antonietta eseguita dalla Tussaud sul corpo della giustiziata, ripresa dopo la sua esecuzione sul patibolo nel 1793 [sotto]. E di queste, la ricomposizione, attuata nel medesimo anno, del busto del capo rivoluzionario Jean-Paul Marat ucciso (comparata al famoso dipinto coevo eseguito dal grande pittore francese Jacques-Louis David (A Marat, 1793) [in basso], è stata effettuata sùbito dopo l’assassinio brutale perpetrato dalla estremista girondina Carlotta Corday di Caen (la cui petizione, presentata al politico disteso nella vasca da bagno per una fastidiosa malattia epidermica, è ancòra nella mano esangue del defunto: e della quale il pittore ha riportato le prime righe dello scritto: “Del 13 Luglio / Maria Antonietta Carlotta / Corday al cittadino / Marat. / Con questa io sono qui / molto rattristata / per avere diritto / della vostra benevolenza”) [Figura 15]


 Figure 14 e 15
Figure 14 e 15
E mettendo in mostra le loro effigi riprodotte in una esposizione apposita, ha finito anche per – approfondendo tale suo talento compositivo – istituire uno dei più famosi musei delle cere al mondo, del proprio periodo ed anche successivo [Figura 16], straordinariamente replicato in varie nazioni della terra.
 Figura 16 – Una foto dell’inglese Edwin Josiah Poyser (Da Madama Tussaud, a Londra, del 1896) riproducente il primo dei musei delle cere tussaudiani aperto nella capitale britannica nel 1835 dalla artista-imprenditrice, che era emigrata in Inghilterra nel 1802
Figura 16 – Una foto dell’inglese Edwin Josiah Poyser (Da Madama Tussaud, a Londra, del 1896) riproducente il primo dei musei delle cere tussaudiani aperto nella capitale britannica nel 1835 dalla artista-imprenditrice, che era emigrata in Inghilterra nel 1802
Questo suo lavoro formidabilmente tenace, e capace, è stato reso possibile dalla pratica artistica dell’epoca, perfezionata dal secolo precedente ma già in uso da parte degli scultori in certi loro lavori di riproduzione fisionomica, che proprio nella tecnica specialistica dell’artigianato delle maschere (quelle per le persone con cui coprirsi il viso, per Carnevale o per motivi di riservatezza pubblica) aveva ritrovato veri esperti esecutori, con facili e veloci mezzi esecutivi.
Verso la creazione mascheraria più consueta
Soprattutto a Venezia, la corporazione degli artigiani maschereri, appartenenti alla Gilda dei Pittori, dal 1436 esercitava una produzione di maschere non soltanto ricavate da forme generiche plasmate manualmente, bensì anche ottenute da calchi dal vero. Seguendo una pratica che variatamente cambiava a seconda della estrosa modalità di ogni autore, ma che veniva seguìta con il medesimo sistema. E che ritroviamo, sempre nel Quattrocento, indicata nel primo manuale (scritto in volgare italiano, misto di toscano e veneto) di tecnica applicata sui procedimenti artistici, il Libro dell’Arte del pittore fiorentino Cennino Cennini: una sorta di trattato che si ritiene di passaggio dal Medioevo al Rinascimento, composto nel 1403-07, nel quale il suo esecutore spiega “come prendere una maschera dalla vita usando un cerchio di ferro, gesso di Parigi e piccoli tubi di ottone per respirare”.
Un criterio consolidato che ugualmente viene descritto da un ignoto artista-artigiano nel suo manoscritto in francese del 1564-66 riguardante una Raccolta di Ricette e Segreti concernenti l’Arte del Plasmatore, dell’Artigiano, e del Pittore contenente un metodo rapido per realizzare “Maschere improvvisate” (con la seguente prescrizione: “Modella della carta e mettila sulla faccia di qualcuno […]. Lascia che si asciughi e prendi il tuo stampo per dipingerlo”), per una specifica metodologia attuativa poi propagata, più avanti, dallo storico altrettanto di Firenze, Filippo Baldinucci, artista e compilatore storico, nel suo Vocabolario Toscano dell’Arte del Disegno, stampato nel 1681, nelle cui pagine egli segnala la fabbricazione di maschere con cartapesta (“pasta di carta imbevuta”).
L’arte della riproduzione fisionomica
E dopo, grazie alle nuove tecniche di plasmazione facciale dei calchi moderni (che adesso comprendono varie procedure pratiche e teoriche anche avanzate, come la Memetica e la Teoria dei Grafi), tanto per le figure mortuarie che hanno portato ad una più raffinata tecnica di nuova imbalsamazione [Figure 17 e 18]

Figure 17 e 18 – Due Tecnici Imbalsamatori mentre preparano una maschera mortuaria a New York nel 1908 (foto di autore sconosciuto) [sopra], ed il busto imbalsamato del grande condottiero politico cinese Mao Zedong nel suo feretro preparato sùbito dopo la propria morte, avvenuta nel 1976 (immagine della Agenzia Fotografica AP di New York) [sotto]

quanto per le sofisticate realizzazioni della plasmazione artistica maggiormente disciplinare [Figura 19] che non comportano pericolo alcuno nel riprodurre addirittura una persona umana intera (ed anche per le parti fisiche maggiormente delicate e di particolare fisionomicità) [Figure 20], il calco in gesso – o con resine speciali e materiali

Figure 19 e 20 – Édouard Joseph Dantan, Un Calco dal Vero, 1887. Prodigiosa immagine informativa del criterio di modellazione statuaria di una figura umana tramite impronta diretta con matrici in gesso, dipinta dal pittore accademico-realista parigino, noto per la numerosa acquisizione di sue opere da parte dello Stato francese [sopra]; e Autrice Anonima (studentessa di Scultura alla Accademia di Brera a Milano), Alessia, 2009-10 [sotto], studio di procedimento di realizzazione scultorea dal modello in argilla alla copia in gesso, per ottenere un calco a forma persa

tecnologicamente sicuri – ha sviluppato una interessante fabbricazione virtuosa di facce riprodotte (o comunque identicamente rielaborate), di cui uno dei tanti esempi artistici correnti sono le maschere facciali dell’artista toscano Luca Carfagna, “calchi in gesso dei volti di gente del luogo” di Capracotta sopra Isernia in Molise, eseguiti tra 2002 e 2004 [Figura 21].
 Figura 21 – Gruppi di maschere tratte da volti umani effettuati dall’artista toscano Luca Carfagna, appesi nel suo studio a Capracotta di Isernia nel Molise, in una foto del loro autore del 2003
Figura 21 – Gruppi di maschere tratte da volti umani effettuati dall’artista toscano Luca Carfagna, appesi nel suo studio a Capracotta di Isernia nel Molise, in una foto del loro autore del 2003
La produzione d’arte, soprattutto, ha ricercato, e particolarmente nella espressione contemporanea, interessanti e significative sculture e statue di sorprendente ripresa realistica delle figure corporee, che nelle pratiche plastiche della tendenza dell’Iperrealismo post-bellico del secondo Novecento (dagli Anni Settanta) ha ricevuto il proprio maggiore fenomeno di manifestazione e apparenza: e di cui le opere degli artisti statunitensi Duane Hanson (di Alexandria nel Minnesota, ma attivo a Miami) e John De Andrea (di Denver) sono i risultati rappresentativamente migliori, e di maggiore effetto visivo e fisico.
Il primo scultore è noto per i suoi procedimenti di perfetta copiatura identica delle persone da lui per così dire ritratte [Figure 22 e 23], che addirittura riproduce con calchi totali

Figure 22 e 23 – Confronto di impressione altamente veristica tra la opera compiuta di Autoritratto con Modella realizzata nel 1979 dallo scultore iperrealistico statunitense Duane Hanson [sopra], ed un momento della sua rifinitura in una immagine di quello stesso anno scattata da Jack Mitchell, fotografo americano di Key West, specializzato in ritratti di artisti, ballerini, attori, musicisti, e scrittori [sotto]

delle loro figure usando stampi di resina poliestere e fibra di vetro (poichè questi sistemi riprendono ogni parte dei corpi nei loro più minuscoli dettagli) ricalcati direttamente sui modelli viventi [Figura 24]. E dopo avere ottenuto queste sculture, Hanson le dipinge manualmente con colori realistici ad olio [Figura 25], completando ogni opera vestendola con indumenti

 Figure 24 e 25 – Il processo di modellazione plastica impiegato da Hanson per realizzare le sue strabilianti sculture estremamente veristiche: la preparazione del soggetto da ritrarre per ricavarne la effigie tramite uno stampo di resina poliestere e fibra di vetro (materiali che copiano perfettamente ogni dettaglio dei corpi ritratti) direttamente dai modelli viventi [sopra], ed il successivo completamento della statua voluta, tramite pittura con colori realistici [sotto]
Figure 24 e 25 – Il processo di modellazione plastica impiegato da Hanson per realizzare le sue strabilianti sculture estremamente veristiche: la preparazione del soggetto da ritrarre per ricavarne la effigie tramite uno stampo di resina poliestere e fibra di vetro (materiali che copiano perfettamente ogni dettaglio dei corpi ritratti) direttamente dai modelli viventi [sopra], ed il successivo completamento della statua voluta, tramite pittura con colori realistici [sotto]
autentici (ed in genere di proprietà degli stessi individui ritratti: perfino loro effetti personali importanti ed anche gioielli!), e ambientando quindi i suoi prodotti finiti con oggetti altrettanto reali [Figura 26], in una scenografia spaziale di verismo sorprendente ed effettivo (sebbene contestualmente spaesante).
 Figura 26 – Una statua hansoniana conclusa: il Medico Sanitario, del 1992-94. Ad ogni sua opera finita, l’artista produce una specifica sistemazione, perchè la risoluzione finale risulti più totalmente oggettiva, facendo indossare abiti autentici ed agghindature reali (perfino gioielli preziosi!) disponendola poi in una ambientazione con altrettanti oggetti veri
Figura 26 – Una statua hansoniana conclusa: il Medico Sanitario, del 1992-94. Ad ogni sua opera finita, l’artista produce una specifica sistemazione, perchè la risoluzione finale risulti più totalmente oggettiva, facendo indossare abiti autentici ed agghindature reali (perfino gioielli preziosi!) disponendola poi in una ambientazione con altrettanti oggetti veri
Il secondo artista invece opera con maggiore riferimento ai corpi delle persone, e preferibilmente donne, completamente nude o molto discinte, per accentuare il loro esclusivo verismo, nei minimi dettagli delle loro particolarità fisionomiche [Figura 27].
 Figura 27 – L’altro artista statunitense e pure iperrealistico, John De Andrea, che però si riferisce prevalentemente a ritratti in dimensioni reali di giovani donne nude, in un esemplare di sua scultura (Rêverie – Fantasticheria – del 2018; foto di Corrado Gavinelli di quell’anno)
Figura 27 – L’altro artista statunitense e pure iperrealistico, John De Andrea, che però si riferisce prevalentemente a ritratti in dimensioni reali di giovani donne nude, in un esemplare di sua scultura (Rêverie – Fantasticheria – del 2018; foto di Corrado Gavinelli di quell’anno)
Accompagnando a volte le sue statue realizzate, con la spropria stessa figura, scultureamente autoritratta, per conferire maggiore rapportablità veristica tra opera e autore [Figura 28] (ed inserendo così la sua persona, ambiguamente, nella scena dei propri prodotti, per così dirli estranei).
 Figura 28 – John De Andrea, Autoritratto con Scultura, 1980. Una delle opere de-andreane in cui egli si ritrae con una sua modella (foto di John Angelillo del 1995)
Figura 28 – John De Andrea, Autoritratto con Scultura, 1980. Una delle opere de-andreane in cui egli si ritrae con una sua modella (foto di John Angelillo del 1995)
Con tale sua ultima modalità modellare, De Andrea è giunto, in un suo lavoro particolare (la Allegoria da Courbet, del 1988, riformulata sul famoso dipinto del pittore francese del Realismo, Lo Studio del Pittore del 1855) [Figure 29 e 30], al problema più interiorizzato della maschera facciale, che viene otticamente a sovrapporsi sul viso dello scultore, allorchè lo spettatore dell’insieme tridimensionale si posiziona giustamente davanti al gruppo plastico [Figura 31].

Foto 29-31 – Una particolare opera de-andreana (la Allegoria da Courbet, del 1988) [sopra] nella quale il confronto figurativo tra autore e modella viene interpretato nella derivazione da una suggestione storica, ispirata al noto quadro del 1854-55 del pittore realistico francese rappresentante Lo Studio del Pittore (particolare del quadro, in una foto di Corrado Gavinelli del 2021) [sotto]. In cui però la enigmatica presenza della maschera in mano all’autore, nella sua percezione laterale coincidente con la sovrapposizione al suo viso, pone l’arcano dubbio che il volto occultato possa – paradossalmente – nascondere magari quello courbetiano! [in basso]


Una maschera pertanto anonima, che in una altra opera, più recente, dell’artista (Le Facce di Cinquanta Anni: una folta serie, fisionomicamente diversificata, di maschere individuali tratte da modelli umani vari dopo una lunga sequenza cronologica – perché, cominciata nel 1973, si è conclusa nel 2017 – nella loro globale esecuzione completa,) [Figura 32] rientra in uno tra i tanti aspetti di una esemplificante campionatura qualunque.
 Figura 32 – John De Andrea, Le Facce di Cinquanta Anni, 2017. Calchi di visi umani iniziati nel 1973 e compìti 44 anni dopo, riportati in forma di maschere facciali
Figura 32 – John De Andrea, Le Facce di Cinquanta Anni, 2017. Calchi di visi umani iniziati nel 1973 e compìti 44 anni dopo, riportati in forma di maschere facciali
Dalla Pop-Art
Non si deve tuttavia dimenticare che la vasta esperienza iperrealistica dei due scultori iperrealistici, tuttavia, e soprattutto quella hansoniana, è stata preceduta, un decennio prima, dagli esperimenti scultorei con calchi in gesso (inizialmente impostati sulla tecnica delle “garze ingessate, utilizzando se stesso come modello”) del pop-artista George Segal, anche egli nordamericano, ma di New York [Figure 33 e 34]: la cui produzione anzi meglio riconduce

 Figure 33 e 34 – Il ricorso allo stampo ottenuto su individui veri per ricavare sculture oggettive, è stato – antecedentemente agli Iperrealisti – iniziato con il pop-artista statunitense George Segal, che però ha preferito comporre sagome figurali non veristiche, ma approssimativamente oggettive (corpi fantomatici più che realistici). Nelle immagini, L’artista all’Opera nel suo Studio, in una foto di Donald Lokuta del 1984 [a sinistra], ed in un tipico lavoro articolato in dimensioni reali, Liberazione Omosessuale del 1979-80, installata nel 1992 nel Parco Christopher a New York [a destra]
Figure 33 e 34 – Il ricorso allo stampo ottenuto su individui veri per ricavare sculture oggettive, è stato – antecedentemente agli Iperrealisti – iniziato con il pop-artista statunitense George Segal, che però ha preferito comporre sagome figurali non veristiche, ma approssimativamente oggettive (corpi fantomatici più che realistici). Nelle immagini, L’artista all’Opera nel suo Studio, in una foto di Donald Lokuta del 1984 [a sinistra], ed in un tipico lavoro articolato in dimensioni reali, Liberazione Omosessuale del 1979-80, installata nel 1992 nel Parco Christopher a New York [a destra]
alla prassi scultorea delle forme gessosamente colate, provenienti dalla riproduzione corporea attuata sui cadaveri morti nella antica Pompei romana, durante la catastrofica eruzione distruttiva del Vesuvio successa nell’anno 79 dopo Cristo. E che per l’artista statunitense ha costituito un autentico riferimento di campionario umano e oggettuale per la riproposizione di ogni effigie reale [Figura 35], che nelle sue opere ha come metaforicamente fatto tornare a rivivere.
 Figura 35 – La suggestione statuaria, gessosa, dei corpi uccisi dalle esalazioni gassose della terribile eruzione vulcanica avvenuta a Pompei nel 79 dopo Cristo (nella esemplare immagine Còlti nel Sonno,79 dC, del fotografo milanese “di belle arti” Luigi Spina, del 2020). Una come le molte cui Segal ha fatto espresso riferimento per la plasmazione delle proprie sculture umane (si tratta di una scoperta recentissimamente ritrovata, nella pompeiana Villa Suburbana del Sauro Bardato a Civita Giuliana, di due corpi maschili intatti: un padrone, con ancòra il proprio mantello, ed il suo servo)
Figura 35 – La suggestione statuaria, gessosa, dei corpi uccisi dalle esalazioni gassose della terribile eruzione vulcanica avvenuta a Pompei nel 79 dopo Cristo (nella esemplare immagine Còlti nel Sonno,79 dC, del fotografo milanese “di belle arti” Luigi Spina, del 2020). Una come le molte cui Segal ha fatto espresso riferimento per la plasmazione delle proprie sculture umane (si tratta di una scoperta recentissimamente ritrovata, nella pompeiana Villa Suburbana del Sauro Bardato a Civita Giuliana, di due corpi maschili intatti: un padrone, con ancòra il proprio mantello, ed il suo servo)
La tecnica di ricostruzione oggettiva delle fisionomie personali dei Pompeiani sepolti dalla lava e dalle ceneri, è stata inventata dall’archeologo italiano Giuseppe Fiorelli, ricercatore pompeiano che nel 1856, sul sito degli scavi, ha pensato di applicare un suo semplice, ma efficace, sistema di rinvenimento tridimensionale dei volumi corporei giacenti sotto la coltre delle eruzioni (di cui porge un espresso riscontro iconografico la illustrazione dell’artista e grafico campano Umberto Cesino del 2012-13) [Figura 36] con il sistema della iniezione, nelle cavità lasciate sotto lo strato di ricoprimento consolidato, contenenti esseri organici consumati repentinamente dal calore della eruzione vulcanica, di una riempente miscela di gesso o cemento e acqua; la quale, rassodatasi a sua volta, formava la copia volumetrica esatta del soggetto sottostante, che poteva venire estratta dal suo involucro di contenimento.
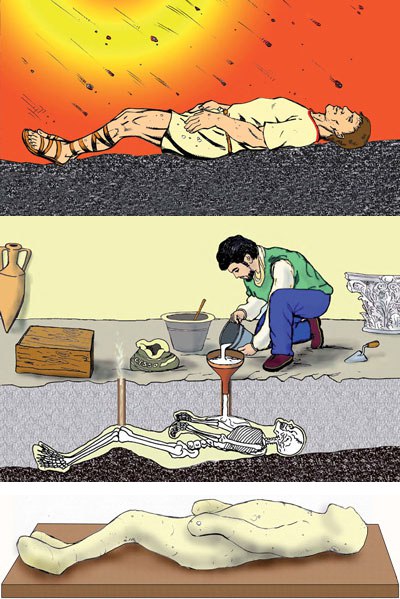 Figura 36
Figura 36
Figura 36 – Il metodo tecnico ideato nel 1856 da Giuseppe Fiorelli, archeologo ottocentesco del sito pompeiano, per ricavare le forme tridimensionale dai calchi vuoti sotto le ceneri vulcaniche di Pompei, nel disegno illustrativo del 2012-13 dell’artista e grafico campano Umberto Cesino, mostrante Le Fasi di Realizzazione di un Calco Pompeiano
Maschere per nascondere la vera identità (occultamento)
Nelle più stereotipate raffigurazioni di eroi e personaggi leggendari in pellicole cinematografiche o filmati televisivi, nonché di fumetti e racconti romanzati, la maschera per nascondere il viso ed eludere l’autentificazione della identità di chi la porta è sempre stata diffusa e imperante. Ma tra gli esemplari di mascheramento prototipico e storico rimangono quelli di Zorro, l’invincibile eroe californiano combattente contro la straniera occupazione del suo villaggio (allora solamente un messicano pueblo) di Los Angeles da parte degli Spagnoli, e dei famigerati, ed anche essi leggendari, fuorilegge del Far West, banditi o assaltatori di diligenze e treni trasportanti valori monetari, che usavano coprirsi semplicemente con i loro fazzoletti solitamente legati al collo.
Due espedienti di mascherature tra loro tuttavia grandemente differenti, per provenienza e cultura: che nel primo si avvale di una minima – e sufficiente – copertura dei soli occhi, e nella seconda circostanza utilizza normali pezzi di stoffa, alzati sul naso.
La Maschera di Zorro (e del suo tipo similare come quella di Diabolik, o di variante estroversa con copricapo come la portano Batman o la Donna Gatto), divenuta celeberrima per le varie interpretazioni, di cui la più popolare è stata quella filmica di Guy Williams (nome d’arte per Armand Joseph Catalano, modello di moda statunitense poi diventato attore cinematografico) del 1957 esibita per la serie televisiva sul leggendario personaggio mascherato prodotto dalla Corporazione Disney [Figura 37, e 38], il cui personaggio di celluloide è stato creato nel 1919 dallo scrittore newyorkese Johnston McCulley, ed era un bandito gentiluomo del periodo della occupazione spagnola della California (1769-1821) che per quella sua specifica epocalità indossava un ricoprimento facciale di tipico riferimento venezian-carnevalesco, o di traslato uso vanesio delle corti regali europee.
 Figura 37
Figura 37
Figure 37 e 38 – Il leggendario personaggio di bandito romantico e popolareZorro, difensore dei deboli dai soprusi autoritari, in un disegno del 1957 annunciante la serie televisiva sull’eroe mascherato prodotto dalla Disney, nella interpretazione di Guy Williams (nome d’arte per Armand Joseph Catalano, modello di moda statunitense poi diventato attore cinematografico) [sopra]. Il protagonista delle serie filmiche è stato creato nel 1919 dallo scrittore newyorkese Johnston McCulley, ed era un bandito gentiluomo di Los Angeles, all’epoca della occupazione spagnola della California (1769-1821); e che dunque indossava una semplice maschera ricoprente soltanto gli occhi (sul genere in uso anche nei fumetti di Phantom, L’Uomo Mascherato, ideati nel 1936 dallo sceneggiatore Lee Falk – ovvero Leon Harrison Gross – e disegnati dal grafico Ray Moore, entrambi statunitensi: nella immagine, in un manifesto del 1954) [sotto].
 Figura 38
Figura 38
Invece la bandana sul viso praticata dai fuorilegge statunitensi è, all’opposto, un più pratico e spontaneo espediente per nascondere la propria identità utilizzando un metodo immediato di occultamento, nientemeno che derivato dalla semplice abitudine contingente dei cow-boys per ripararsi dalla polvere o dal vento e dalle intemperie disturbanti durante il loro lavoro [Figure 39, e 40].

Figure 39 e 40 – Un dipinto del 1899 del pittore statunitense Andy Thomas (membro della Società di Artisti Skull, ente artistico fondato per “la rappresentazione del Vecchio West” degli USA) raffigurante La Rapina al Treno Wild Bunch presso Wilcox, in cui i banditi portano il mascheramento tipico dei cow-boys, il fazzoletto sopra il naso, normalmente usato per ripararsi dalla polvere e dal vento, e in questo caso impiegato per nascondere le loro fisionomie di delinquenti [sopra]; ed una foto storica del 1878 scattata da un autore ignoto al famigerato bandito di San Francisco William Whitney Brazelton, detto Brazen Bill: ovvero Guglielmino senza Faccia, perché era solito coprirsi il volto con un cappuccio di stoffa, aperto soltanto nelle tre fessure essenziali, degli occhi per vedere e della bocca per respirare), che alla sua epoca era stato definito il “più tremendo rapinatore solitario di diligenze” [sotto]
 Figura 40
Figura 40
Coperture del viso per attestare una informazione informativa (indicazione di ruolo)
Maschere nascondenti che però non sono realizzate, e usate, per uno specifico scopo di anonimato, ma per – al contrario – dichiarare una condizione precisa di riconoscimento, sociale o individuale, sono quindi, le coperture facciali denotanti un còmpito o un ruolo particolare, e spesso ufficiale, maggiormente in uso nella natichità e certe epoche storiche: di cui un esempio tipico proviene dalle mascherature applicate al viso dagli Sciamani; dietro le quali poco importava chi fosse il performatore delle azioni ritual-tribali, ma che davano invece sostanziale rilevanza al loro apparato visivo, ed espressivo, perché comunicava il ruolo precipuo della attività che l’attore designato comunitariamente compiva (e … ricopriva!) [Figura 41]. Con un analogo criterio informativo visivo che si può riferire in modo simile alla nota figura dei Mammuttones sardi, pervenuti fino ad oggi nella loro arcaica ancestralità isolana e diventati quindi elemento folclorico di una tradizione unica e spettacolare [Figura 42].
 Figura 41
Figura 41
Figure 41 e 42 – La Maschera arcaica quale segno di una civiltà ancestrale (nel Mamutone sardo, tipico del paese di Mamoiada presso Nuoro, nella foto Mammuthones Maschera della Sardegna di Chiara Senatore del 2017) [sotto] e di una provenienza ritual-sciamanica (un eccezionale reperto italiano di 2600 anni fa – la cosiddetta Maschera di Bronzo di Longano, località molisana vicino a Isernia – risalente al 545-542 avanti Cristo, ritenuta, secondo il suo restauratore Mario Pagano, Soprintendente ai Beni Archeologici della Regione Molise, “indossata in cerimonie rituali da personaggi di altissimo rango della comunità sannitica locale”) [sopra]

Non da meno, una segnalazione di tale genere anonimo per la persona che la indossa, ma caratteristica per il ruolo che essa indica, è la famigerata Maschera del Medico della Peste in auge dal Seicento (di cui tratterò nella prossima Seconda Parte di questo saggio) [Figura 43]; ed ulteriormente si presta, a tale genere di evidenziazione fisico-mansionale, sebbene
 Figura 43 – Esemplare eretto a Cabrières-d’Avignon per avvertire della presenza del cosiddetto Muro della Peste costruito nella Provenza francese sui monti del Vaucluse sopra Marsiglia per proteggere quella zona dal morbo pestifero del 1720-1722. E’ una delle steli lapidee segnalanti la vicina presenza della muraglia difensiva, e dunque del pericolo della epidemia al suo interno, la cui figura – riproducente la immagine del famoso Medico della Pestilenza primo-seicentesco – è un segnale di avviso riferito ad una condizione verso la quale prestare molta precauzione per il rischio di contagio oltrepassando il limite della barriera
Figura 43 – Esemplare eretto a Cabrières-d’Avignon per avvertire della presenza del cosiddetto Muro della Peste costruito nella Provenza francese sui monti del Vaucluse sopra Marsiglia per proteggere quella zona dal morbo pestifero del 1720-1722. E’ una delle steli lapidee segnalanti la vicina presenza della muraglia difensiva, e dunque del pericolo della epidemia al suo interno, la cui figura – riproducente la immagine del famoso Medico della Pestilenza primo-seicentesco – è un segnale di avviso riferito ad una condizione verso la quale prestare molta precauzione per il rischio di contagio oltrepassando il limite della barriera
su un versante di altra appartenenza per circostanzialità cultural-sociale, e comunemente usuale – anche il travestimento professionale (proveniente anche questa dal passato, ma rimasto, in altro modo, confermata nel presente perfino odierno) il nascondimento truccante delle Geishe giapponesi: nel cui svolgimento delle loro pratiche cerimoniali non è importante la identità soggettiva della persona che le effettua, e che sta dietro al pesante maquillage del volto, ma diventa determinante la specificazione della qualità del ruolo esercitato. Resa esplicita dalla estranea, e convenzionalmente espressiva, anonimia della percezione facciale, ricoperta (e alterata) dal trucco (che diversamente, e un tempo, era affidata ad una maschera autentica di derivazione teatrale), e dalla foggia tradizionale dello stesso abbigliamento rituale, portato dalla donna nel suo espletamento di servizio [Figure 44 e 45]
 Figura 44
Figura 44  Figura 45
Figura 45
Figure 44 e 45 – Una vecchia foto (di autore ignoto e del 1905-06) di Una Geisha di Kyoto nel suo tipico mascheramento del viso con un pesante trucco ricoprente [a sinistra], e l’analogo effetto percettivo ed occultante di una tradizionale Maschera del Giappone da teatro fotografata da Chiara Senatore nel 2017 [a destra]
A questi particolari mascheramenti si possono aggiungere – per quanto in maniera più espressamente riferita ad un costume radicatamente sociale, più dedicato per il condizionamento al credo religioso obbligato cui appartengono, segnato da un forte vincolo di consuetudine ancestrale – la pratica dell’occultamento del viso da parte delle donne nelle culture arabe e medio-orientali di fede musulmana, attuato tramite un velo ricoprente, in parte o interamente, con cui viene nascosto il volto per motivi di obbedienza etica ai dettami della fede [Figura 46, e 47-49].

Figure 46-49 – Il caratteristico nascondimento, mascherato e no, della tradizione musulmana per le donne di varie loro credenze e abitudini (Autore Ignoto delle Immagini getty, Tipi di Ricoprimenti Musulmani Femminili, 2017). In uno schema riassuntivo generale, con i vari sistemi di copertura facciale [sopra], e nelle differenti acconciature personali – e convenzionalmente sociali – delle vestimenta giovanili e muliebri [sotto e in basso]: dal libero volto scoperto del Hijab, in una foto anonima del 2017, alla copertura parziale con i soli occhi in vista – Triplo Sciador a Hyderabad, di autore ignoto e del 2018 – fino al totale coprimento del Burka (particolarmente usato in Afghanistan e Pakistan) in un ritratto fotografico di Juan Monino del 2017

 Fig. 48
Fig. 48  Fig. 49
Fig. 49
Una abitudine inveterata che – ripeto – non è propriamente adottata per celare la sottostante identità della persona che lo indossa, bensì costituisce un criterio protettivo sempre di riservatezza (o di originario sistema di protezione dagli agenti atmosferici – sole e vento, e quindi sabbia e polveri – come si ritrova nel caso degli avvolgenti tagelmust, le lunghe sciarpe-turbanti dei Tuareg, o dei Berberi, nordafricani) [Figura 50], o comporta un tipico sistema di scoraggiare un pratico (ed inequivocabilmente inattuabile per la sua impenetrabilità) allontanamento visivo dal desiderio fisico di attrazione degli uomini verso il genere femminile. Ma comunque sempre elemento chiaramente segnalatore di una situazione d’uso per un costume di contingenza concreta.
 Figura 50 – Autore Sconosciuto, Tuareg con Tagelmust, 2019. Le popolazioni nomadi del Sahara indossano questa fascia di copertura del viso (costituente in un prolungamento del turbante, liberamente rimovibile dalla bocca, all’occorrenza) che lascia scoperti soltanto gli occhi non per particolari credenze religiose ma per pratiche condizioni di riparo dai venti sferzanti del deserto e dal pulviscolo nocivo
Figura 50 – Autore Sconosciuto, Tuareg con Tagelmust, 2019. Le popolazioni nomadi del Sahara indossano questa fascia di copertura del viso (costituente in un prolungamento del turbante, liberamente rimovibile dalla bocca, all’occorrenza) che lascia scoperti soltanto gli occhi non per particolari credenze religiose ma per pratiche condizioni di riparo dai venti sferzanti del deserto e dal pulviscolo nocivo
Tale particolare indicazione esteriore di traslata entità identificatoria, appartiene comunque a tutti i messaggi fisici (e psicologici, e societarii) di convenzionale oggettualità esibita; come (per usare un esempio di estremo riferimento) si rivelano le mostrine di soldati o poliziotti per indicare il grado di condizione del rango ricoperto, e dichiaranti una condizione di ruolo specifico ed attitudinale indipendentemente dalle persone che le portano, oppure semplicimente una condizione di fatto di contingente urgenza quale diventano le maschere protettive degli atleti, indossate sul viso a causa di particolari traumi sportivi (e assolutamente non per nascondere i loro tratti fisici) [Figura 51].
 Figura 51 – La Maschera Protettiva indossata nel 2017 dal giocatore di Calcio spagnolo Sergio Ramos, difensore e capitano della squadra iberica del Real Madrid, dopo la frattura del naso durante una partita di campionato nazionale (in una foto della Agenzia di Stampa EFE di Madrid). Realizzata a stampo dalla Podoactiva (la ditta spagnola specializzata in podologia e sistemi motorii biomeccanici fondata nel 1994 dal dottore madrileno Vìctor Alfaro Sadafez, con sede nel Parco Tecnologico Walqa presso Cuarte nel territorio di Huesca, a settentrione di Saragozza) in materiale duro all’esterno, imbottito dentro con una sostanza morbida ad alta capacità di assorbimento dei colpi inferti, è stata ottenuta tramite l’apparato Younext, uno speciale scansionatore elettronico tridimensionale sofisticato, che ha ripreso dal vero le fattezze del volto del giocatore, utilizzandone quindi i dati per progettare digitalmente una maschera che si adattasse perfettamente alla sua fisionomia
Figura 51 – La Maschera Protettiva indossata nel 2017 dal giocatore di Calcio spagnolo Sergio Ramos, difensore e capitano della squadra iberica del Real Madrid, dopo la frattura del naso durante una partita di campionato nazionale (in una foto della Agenzia di Stampa EFE di Madrid). Realizzata a stampo dalla Podoactiva (la ditta spagnola specializzata in podologia e sistemi motorii biomeccanici fondata nel 1994 dal dottore madrileno Vìctor Alfaro Sadafez, con sede nel Parco Tecnologico Walqa presso Cuarte nel territorio di Huesca, a settentrione di Saragozza) in materiale duro all’esterno, imbottito dentro con una sostanza morbida ad alta capacità di assorbimento dei colpi inferti, è stata ottenuta tramite l’apparato Younext, uno speciale scansionatore elettronico tridimensionale sofisticato, che ha ripreso dal vero le fattezze del volto del giocatore, utilizzandone quindi i dati per progettare digitalmente una maschera che si adattasse perfettamente alla sua fisionomia
Un caso alquanto singolare: la Maschera di Ferro
Tra gli esempi più singolari, e fuori dal convenzionale schema di mascheramento individuale, che contemporaneamente rappresenta un fatto di chiaro occultamento della persona che la indossa ma anche un dato di esternata dichiarazione della sua qualità di riconoscibilità specifica ed inequivocabile nei confronti del personaggio storico cui esso è riferito, è la leggendaria (in parte) Maschera di Ferro originariamente incarcerata a Pinerolo (cittadina del Piemonte italiano sotto le Alpi Cozie, che a quel tempo – dal 1630 – era territorio di appartenenza francese) nella famigerata prigione del suo Castello cittadino (o meglio Cittadella) dal 1668 al 1698 (e poi trasferito alla Bastiglia di Parigi, dove è morto nel 1703).
Personaggio alla fine ignoto, nonostante le numerosissime ipotesi di identificazione mai assolutamente confermate (della cui vicenda ed identità mi sono molto interessato in parecchi articoli apparsi sul periodico pinerolese Vita), segregato nella prigione piemontese per motivi gravi di confinamento criminale o politico, che proprio per mai rivelare la propria identità era costretto (quando si doveva trovare al cospetto di persone non autorizzate, ma anche normalmente in carcere guardato a vista dai custodi) a coprirsi il volto con una maschera, che la tradizione romanzata – e filmica – indica essere fatta di solido metallo [Figura 52, 53-54, e 55-56].
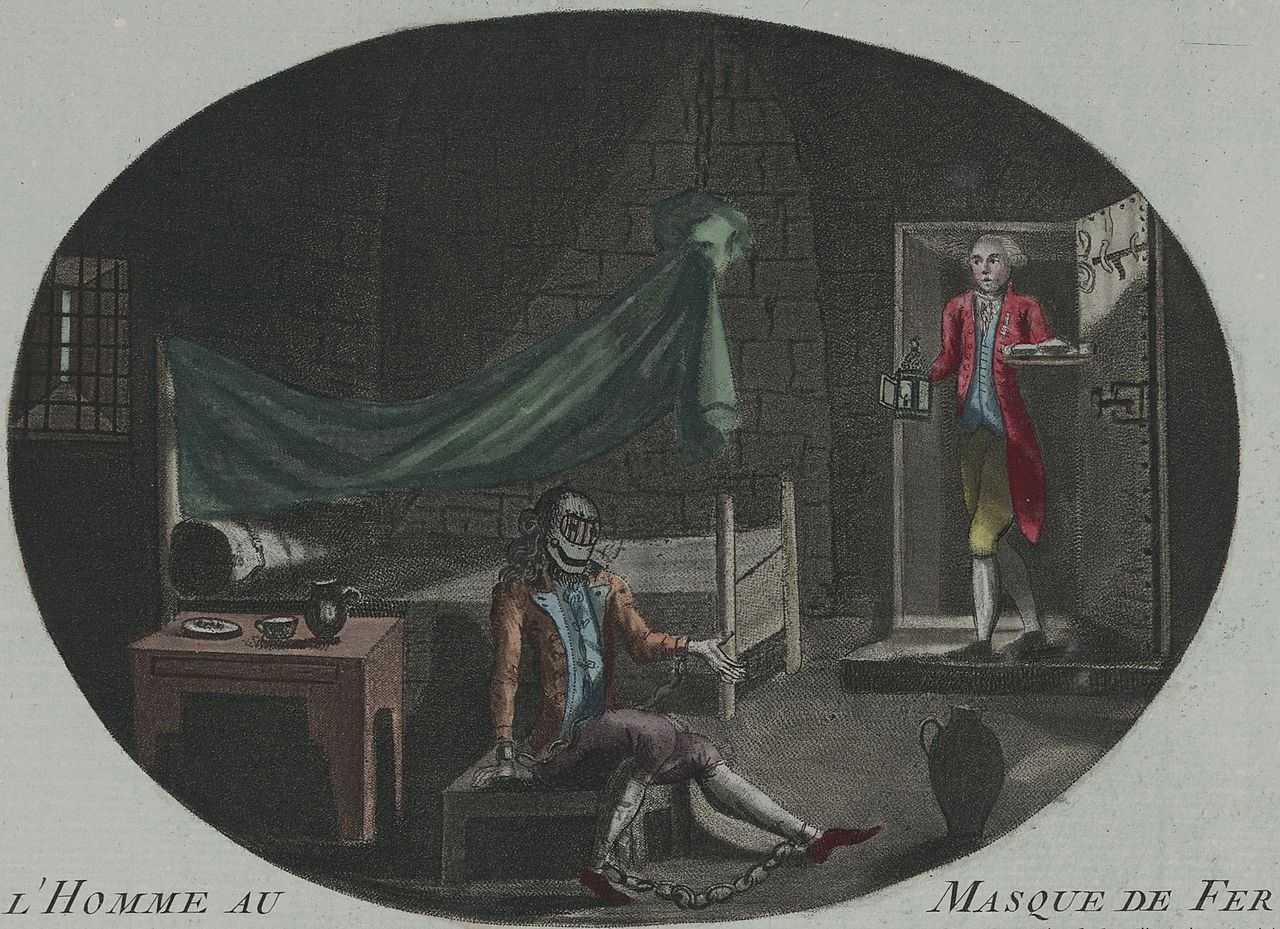 Figura 52 – Incisore Ignoto, L’Uomo dalla Maschera di Ferro, 1798. Da questo artista francese, che ritrae romanticamente la figura del prigioniero della Bastiglia di Parigi in una inventiva ricostruzione quando ormai il personaggio raffigurato era morto da 95 anni, il mascherato viene riconosciuto – tra i tanti possibili pretendenti alla identità del soggetto – in Luigi di Borbone Conte di Vermandois, figlio illegittimo di Luigi XIV, segregato a vita in carcere di sicurezza per evitare spiacevoli rivendicazioni di successione al trono di Francia
Figura 52 – Incisore Ignoto, L’Uomo dalla Maschera di Ferro, 1798. Da questo artista francese, che ritrae romanticamente la figura del prigioniero della Bastiglia di Parigi in una inventiva ricostruzione quando ormai il personaggio raffigurato era morto da 95 anni, il mascherato viene riconosciuto – tra i tanti possibili pretendenti alla identità del soggetto – in Luigi di Borbone Conte di Vermandois, figlio illegittimo di Luigi XIV, segregato a vita in carcere di sicurezza per evitare spiacevoli rivendicazioni di successione al trono di Francia
 Figura 53
Figura 53  Figura 54
Figura 54
Figure 53 e 54 – La più tradizionale versione della maschera ferrea indossata dal misterioso personaggio imprigionato a Pinerolo in Italia (località del Piemonte pre-montano sotto le Alpi Cozie) e quindi in Francia alla Bastiglia parigina, nella sceneggiatura (molto inventata narrativamente) del film La Maschera di Ferro del 1998 interpretato dal famoso attore italo-statunitense Leonardo Di Caprio [sopra], ed il suo più ricorrente – ma improbabile – modello originario, un esemplare cinquecentesco di strumento di tortura (Artigiano Sconosciuto, Maschera per Estorcere Confessioni, 1558-62) di derivazione inquisitoriale [sotto]
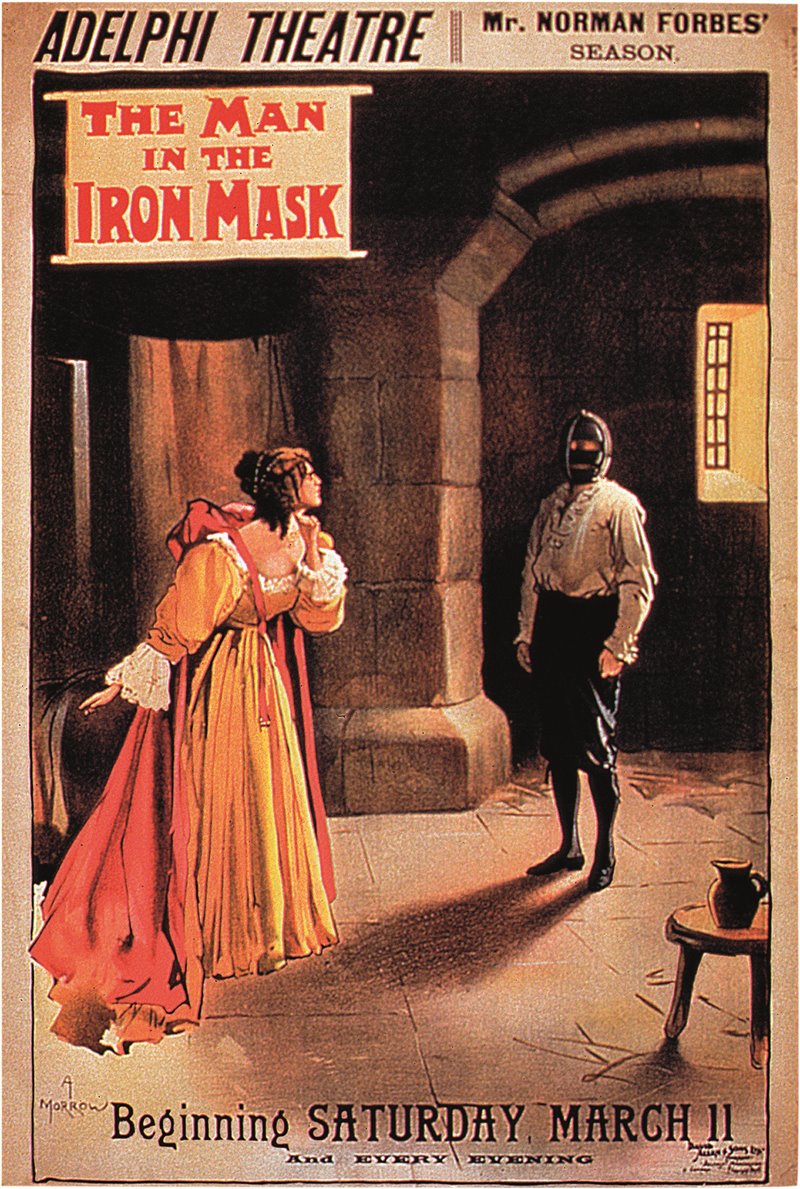
Figure 55 e 56 – La diffusissima fama suscitata dal romanzo del famoso scrittore francese Victor Hugo che per primo ha popolarmente divulgato la vicenda della Maschera di Ferro in un suo racconto dal titolo Il Visconte di Bragelonna uscito a puntate nel 1847 sul quotidiano francese Le Siècle e poi ristampato in libro completo dal 1848 al 1850: raffigurata in un manifesto teatrale – L’Uomo dalla Maschera di Ferro – disegnato dall’illustratore irlandese Albert Morrow per uno spettacolo del 1899 al Teatro Adelphi di Londra (rappresentato per 69 volte in 3 mesi) [sopra], e fumettisticamente riproposta in un fascicolo (il numero 232) del noto personaggio Tex Willer ideato dal fumettista italiano Giovanni Luigi Bonelli, disegnato (dal collega connazionale Aurelio Galleppini, che si firmava Galep) nel 1980 per la copertina dell’albo dal titolo, appunto, Tex – La Maschera di Ferro [sotto]
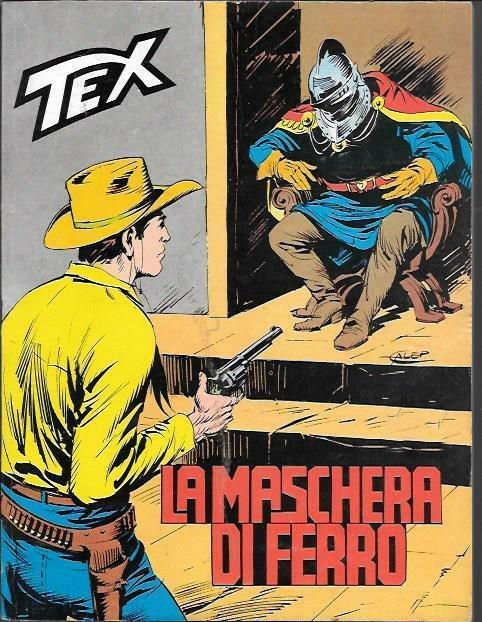 Figura 56
Figura 56
Una condizione tuttavia dubitabile, se non impossibile, questa, poiché una maschera ferrea, tenuta continuativamente ed a lungo sulla faccia avrebbe danneggiato seriamente il viso e la salute del suo indossatore, e potuto causare seri danni di asetticemia; che la cronaca storica rivela invece trattarsi di una più semplice, ed accettabile, visiera di stoffa, come testimonia non solamente la cronaca del trasferimento del detenuto mascherato alla Bastiglia di Parigi nella sua sosta intermedia fatta al Castello di Palteau ad Armeau (paesino della zona meridional-orientale di Fontainebleau), dove aveva la sua dimora padronale il capo-carceriere Benigno Dauvergne Signore di Saint-Mars, governatore della prigione pinerolese e poi di quella parigina, che seguiva ovunque il detenuto; ma che si ritrova ulteriormente confermata anche nella certificazione di morte dell’incarcerato nella prigione francese, stilato dal Luogotenente del Re e Vice-Governatore della Bastiglia, Etienne Du Junca, funzionario coscienzioso e preciso, che teneva un grosso registro sul quale annotava ogni giorno gli atti inerenti alle vicende di segregazione.
Ed entrambe queste specifiche attestazioni espongono, rispettivamente, un medesimo risultato assertivo: nel primo caso profferito dal nipote saint-marsiano, e suo erede, Guillaume Louis de Formanoir, che ha lasciato scritto, in una lettera del “19 VI 1768”, come “Nel 1698, il signore di Saint-Mars passando dal governatorato delle Isole Sainte-Marguerite a quello della Bastiglia […] si fermò con il suo prigioniero nella propria terra di Palteau. […] Quando […] attraversò il cortile, indossava sempre la sua maschera nera sul volto”, ed “i contadini rimarcarono che essa mostrava i denti e le labbra” del personaggio (non risultando dunque coperto in tutto il volto); mentre nella seconda descrizione, quella juncaiana, si legge chiaramente che “In questo stesso giorno, lunedì 19 novembre 1703, il prigioniero sconosciuto, sempre mascherato con un drappo di velluto nero”, era deceduto.
Ad ogni modo, la spietata prassi punitiva della mascheratura ferrea, per certi casi ancòra impiegata nel Sei-Settecento (e nell’Ottocento perfino), deriva dal consuetudinario criterio di incrudelimento delle pene che, in una epoca ancòra di sevizie di secolare provenienza medievale e precedente, applicata alle torture verso i condannati, considerava il tormento dei colpevoli (perfino per reati meno gravi o leggeri – quali la menzogna o perfino il pettegolezzo – colpe da incredibilmente castigare severamente), una attuazione necessaria da perseguire, anche soltanto come atto esemplare di avvertimento o mezzo di svergognamento pubblico [Figure 57 e 58].
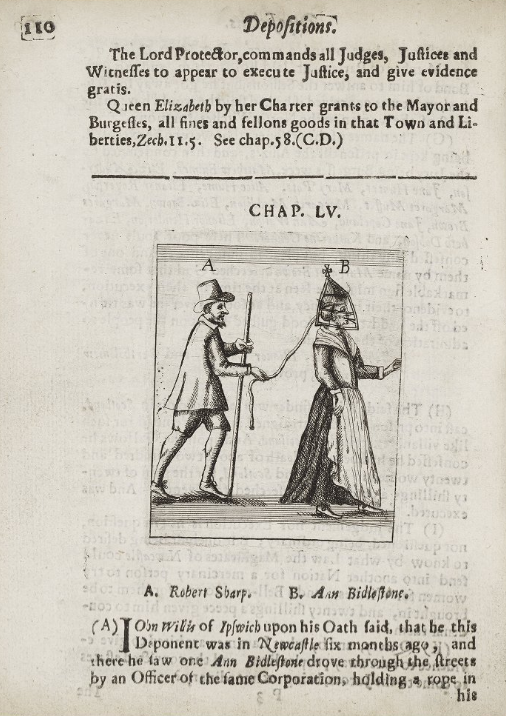 Figura 57
Figura 57
Figure 57 e 58 – La cosiddetta Briglia della Comare (una sorta di cappuccio ferreo a gabbia per infliggere punizioni pubbliche alle donne pettegole, inventata in Irlanda nel 1567, e sùbito diffusa in tutta la Scozia e la Inghilterra, e poi nella restante Europa) in una illustrazione dello stampatore londinese Peter Stent da lui pubblicata nel libro del “gentiluomo” inglese Ralph Gardiner, Una Lamentela Scoperta in Inghilterra in relazione al Commercio del Carbone del 1655 (in cui si legge che quello strumento era in uso durante il Protettorato britannico di Cromwell, e che il designato “Esecutore” giudiziario di questa pena, Robert Sharp, la ha applicata quell’anno “in Newcastle” nei confronti della condannata Anna Bidlestone, “condotta per le strade” della città “tenendola per una corda”) [sopra]; ed una sua versione più recente, la cosiddetta Mordacchia ottocentesca e del nord-america colonialmente inglese (in una litografia di autore e data sconosciuti), composta da un morso che bloccava la bocca e la lingua [sotto]
 Figura 58
Figura 58
Ne sono chiari esempi, ancòra in pieno progresso ottocentesco, le incredibili apparecchiature ferree applicate sulle teste (e facce) degli schiavi negri fuggiti e ricatturati, coperti di stravaganti involucri in ferro per punizione corporea (e per esplicito ammonimento verso eventuali altri tentativi simili) non soltanto infastidenti ma anche penosamente dolorosi [Figure 59-61].
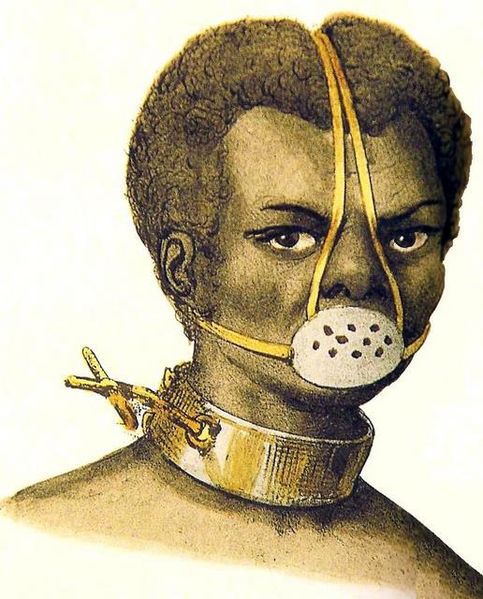 Figura 59
Figura 59
Figure 59-61 – Un significativo campionario dalla imbrigliatura boccale comprendente la intera maschera facciale, tutto di riferimento brasiliano e antillano (di Antigua) di epoca ottocentesca, impiegata nei sistemi di punizione inflitti agli schiavi scappati e nuovamente catturati, per indurli a non tentare altri atti di fuga: una cavezza ferrea (il Castigo per Schiavi) straordinariamente simile alla Briglia della Comare della America del Nord (si veda la Figura 58), eseguita dal litografo francese Nicolas-Eustache Maurin [sopra] riprendendo uno schizzo di appunti dal verolo dello scrittore francese Jacques Étienne Victor Arago e pubblicato nel suo libro Ricordi di un Cieco del 1839 riguardante i propri vari viaggi “intorno al mondo” (ed indicata dal suo autore come “Opera arricchita da sessanta disegni e note scientifiche”); quindi una xilografia (Ferrature per Schiavi) pubblicata sul testo Il Tiranno Penitenziale di Thomas Branagan (inizialmente un commerciante di schiavi dublinese convertitosi, nel suo trasferimento a Filadelfia nel Nordamerica e dopo avere aderito al Mormonismo, all’abolizionismo della schiavitù) stampato a New York nel 1807 (ed illustrato dal disegnatore statunitense Alexander Anderson) [sotto]; e quindi una ulteriore raffigurazione aragoina, anche essa nel precedentemente citato suo libro del 1839, mostrante un mascheramento completo del viso [in basso]
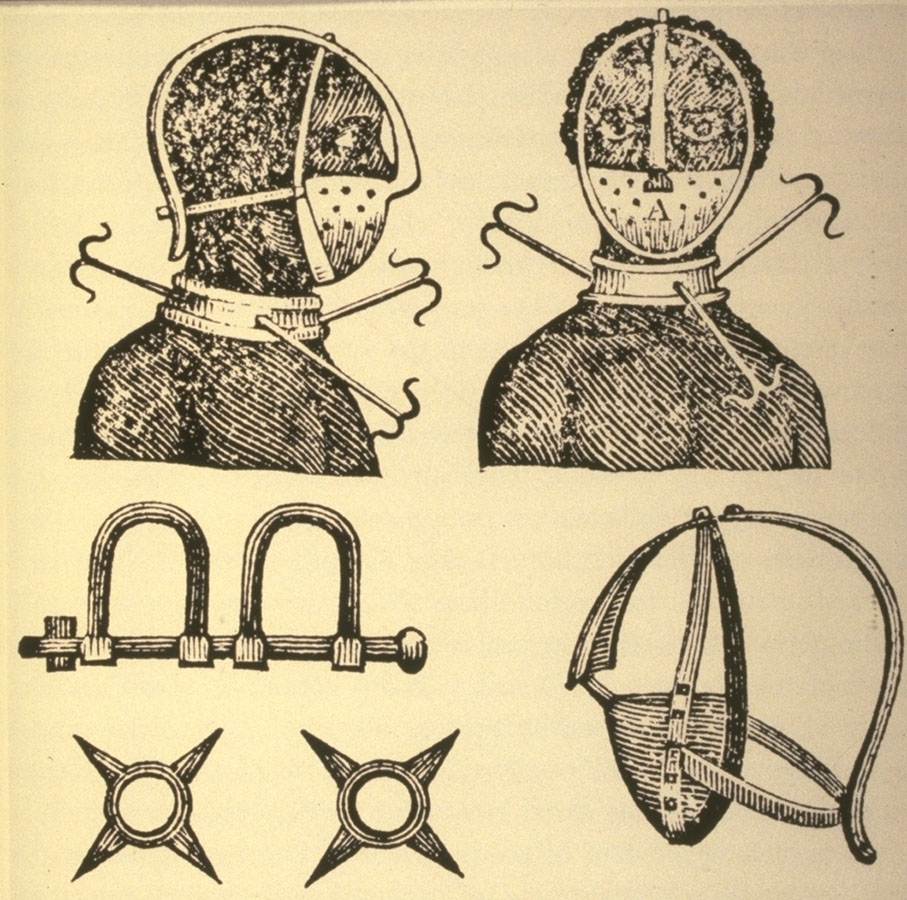
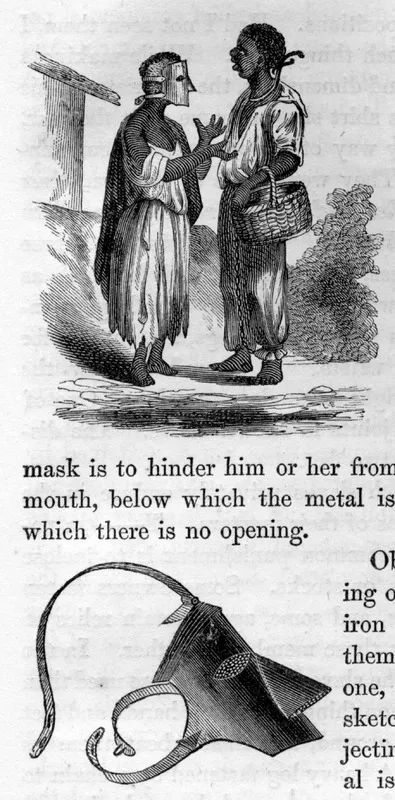 Figura 61
Figura 61
Come pure, sempre coeve al Prigioniero di Pinerolo, sono state le maschere di ferro per detenuti, di latta leggera o stagno, e perfino le celate metalliche (sorta di placcature leggere rivestenti tutto il viso) adottate dai boia in sostituzione del più consueto cappuccio a sacco usato nelle esecuzioni patibolari consuete [Figure 62 e 63].


Figure 62 e 63 – Due tipi di maschere metalliche di riferimento carcerario: una Celata Facciale seicentesca in latta usata per nascondere la identità di un prigioniero politico [a sinistra], e un ferreo Mascherone per Boia dal ghigno macabro indossato dai carnefici inglesi per la esecuzione di condannati a morte, soprattutto nel Sei-Settecento per gli incarcerati nella Torre di Londra [a destra]
Tutti elementi torturatorii che, arretrando nei secoli bui delle persecuzioni disumane, comprendono le più mostruose invenzioni di supplizio fisico e coercizione ideologica dal Cinquecento [Figura 54] al Medioevo [Figura 64], che hanno contrassegnato la malvagità umana dalla più lontana antichità, concentrandosi negli iniqui procedimenti della Inquisizione quattrocentesca (di cui si potrà vedere nella Parte Seconda di questo saggio).

Figura 64 – Un esemplare intatto di Maschera di Tortura Medievale, fatta indossare ai prigionieri per indurre disagio psicologico in modo da indurli a confessare
Tornando alla Maschera di Ferro di Pinerolo, e concludendone la vicenda mascheraria, l’espediente della visiera soffice di velluto (che poteva consistere in una effettiva maschera sugli occhi quale era in uso allora per altre circostanze abituali che indicherò tra poco; oppure in una sorta di banda calata pendente dal cappello; ma forse anche in una più tipica copertura parziale del viso, di cartapesta o di cuoio, come quelle tipiche del carnevale seicentesco) era già stato usato in Olanda per prigionieri di una certa importanza.
E comunque la maschera vellutata è entrata frequentemente in uso nel ceto superiore (nobiltà) e medio (borghesia benestante) dal primo Seicento, quale strumento – soprattutto per signore e dame di un certo ceto sociale più altolocato – di prudenziale riservatezza nelle uscite pubbliche o per mantenere l’anonimato durante i viaggi (come è stato infatti per l’Uomo con la Maschera di Ferro condotto a Parigi dal Saint-Mars), e addirittura per proteggere le loro pelli delicate –vezzosamente mantenute bianche e di pallore lunare – dai raggi solari troppo abbronzanti e perfino dal freddo pungente invernale [Figure 65 e 66].

Figure 65 e 66 – Maschere di Velluto in uso tra Seicento e Settecento per la moda del tempo o la comodità pratica delle dame dell’epoca: da indossare durante i viaggi per proteggere la pelle dal sole e mantenerla bianca senza incipriarla (una Maschera di Velluto da Protezione della Pelle in un acquarello di autore anonimo del 1647-48) [sopra] o ripararla dai rigori altrettanto nocivi del freddo (Abbigliamento Invernale di una Gentildonna Inglese nella incisione dell’artista olandese, operante in Gran Bretagna, Wenceslaus Hollar, del 1644) [sotto]
 Figura 66
Figura 66
La introduzione del velluto mascherario rimonta (come riporta il genealogista inglese Randall – o Randle – Holme nel suo trattato enciclopedico del 1688 sulla Accademia di Armeria, un “Repertorio di Araldica e Blasonatura” stampato a Chester, cittadina dell’entroterra liverpooliano rivolto al mare di Irlanda) a “due tipi di rivestimenti per il viso, alla moda, comunemente indossati: un tipo copriva solo la fronte, gli occhi e il naso, e attraverso i fori” oculari “era possibile guardare fuori; e il resto del viso era coperto da un panno per il mento” (e “questi tipi di maschere erano solitamente quadrati con una parte superiore piatta o arrotondata, ed erano generalmente fatti di velluto nero”), mentre “L’altro tipo, chiamato visiera, copriva tutto il volto, con fori per gli occhi, una custodia per il naso, e una fessura per la bocca, attraverso cui parlare; questo genere di maschera viene tolto e indossato in un istante, essendo tenuto solo con i denti per mezzo di una pallina rotonda fissata all’interno, contro la bocca”.
Ed anche se tale strumento occultante, o riparante, può sembrare assurdo e addirittura eccessivamente frivolo per una mentalità attuale come la nostra, a quella epoca era invece piuttosto praticato, e particolarmente dalla nobiltà (che difficilmente si mescolava con la plebe ed i ceti popolari) [Figura 67].
 Figura 67 – Jacques Callot, La Nobiltà. La Dama Macherata, 1620-1623. E’ una interessante litografia del grande disegnatore e incisore francese seicentesco, in cui è chiaramente indicato l’uso sociale ristretto della mascheratura femminile, riservata ai ceti nobiliari (e benestanti)
Figura 67 – Jacques Callot, La Nobiltà. La Dama Macherata, 1620-1623. E’ una interessante litografia del grande disegnatore e incisore francese seicentesco, in cui è chiaramente indicato l’uso sociale ristretto della mascheratura femminile, riservata ai ceti nobiliari (e benestanti)
Invece, nella sua foggia particolare di veletta che poteva venire calata sul viso o facilmente alzata e fissata al copricapo per lasciare libera la faccia, questo strumento femmineo venne comunemente chiamato fascia da naso (dalla dizione touret de nez in francese), poiché assomigliava molto alla yashmak utilizzata dalle donne turche per nascondere il loro volto in pubblico [Figura 68].
 Figura 68 – Abito di una Signorina che non si allontana tanto dalla sua residenza o si reca in visita alle vicine, portando soltanto un velo al posto della maschera, in una litografia a bulino del 1629-30 dell’incisore lorenese, oltrechè editore e mercante di stampe, Isaac Briot (ripresa da un disegno di Jean De Saint-Igny, pittore di Rouen). Questo genere di copertura velata degli occhi, derivato dallo yashmak turco utilizzata dalle donne del Bosforo per nascondere il proprio volto in pubblico, viene chiamato in Francia banda da naso (da touret de nez in francese), e quindi Turetto, copricapo gotico duecentesco portato dalle donne medievali (si veda la Figura 69)
Figura 68 – Abito di una Signorina che non si allontana tanto dalla sua residenza o si reca in visita alle vicine, portando soltanto un velo al posto della maschera, in una litografia a bulino del 1629-30 dell’incisore lorenese, oltrechè editore e mercante di stampe, Isaac Briot (ripresa da un disegno di Jean De Saint-Igny, pittore di Rouen). Questo genere di copertura velata degli occhi, derivato dallo yashmak turco utilizzata dalle donne del Bosforo per nascondere il proprio volto in pubblico, viene chiamato in Francia banda da naso (da touret de nez in francese), e quindi Turetto, copricapo gotico duecentesco portato dalle donne medievali (si veda la Figura 69)
Originariamente il Turetto era un copricapo medievale duecentesco portato dalla nobiltà gotica europea, composto di una cuffia piatta di stoffa alla base con calotta cupolare, tenuta da una fascia sotto il mento, la cui immagine propria si può vedere nella leggiadra figura dolcemente sorridente della Giovane Dama con la Berretta scolpita verso il 1375-80 da uno sconosciuto scalpellino tardo-gotico sulla porta della Sagrestia Antica della Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora della Assunzione a Rouffach in Alsazia [Figura 69]; una copertura originale che soltanto secoli più tardi venne provvista di veletta o sostituita da una visiera a tutta faccia (allo scopo, si ritiene, e come nel 2020 ha suggerito Ana Muraca – fondatrice e direttrice creativa della agenzia di moda Déjà Vue Team – “di nascondere lo stato pietoso della pelle delle donne dell’alta società, che […] facevano uso di creme, unguenti e cosmetici realizzati tante volte con delle sostanze nocive”).
 Figura 69 – Il caratteristico Turetto nella scultura, di scalpellino tardo-gotico sconosciuto, di Giovane Dama con la Berretta sulla porta della Sagrestia Antica della Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora della Assunzione a Rouffach in Alsazia, realizzata tra il 1775 ed il 1780. E’ un copricapo dalla base cilindrica bassa ed una calotta superiore a cupola, tenuto da un sottogola di sostegno, di stoffa leggera. La sua descrizione più definita è stata riportata, nel 2021, in un articolo di Gérard Michel, Professore di Lettere e Paleografo francese: il touret è “sorta di cuffia denotativa della nobiltà del XIIIesimo secolo, portata con una mentoniera detta anche barbetta, […] fascia di tessuto che avvolge i capelli e passa sotto il mento. Essa viene indossata abitualmente con la chioma intrecciata, o semplemente raccolta in un nodo sulla nuca tramite una reticella” che lascia libero il resto della capigliatura. Ma secondo alcuni, il Turetto da Naso, oltre ad avere la precipua funzione di apparato estetico, serviva, anche esso, come protezione della pelle nei periodi invernali ed estivi, ed anche per coprire il viso con una velatura pietosa in modo da nascondere la condizione a volte rovinata della pelle delle donne della alta società che praticavano uno sconsiderato uso di unguenti e cosmetici (realizzati spesso con sostanze dannose); le quali, seguendo la moda dell’epoca, abbondavano nella applicazione di creme di bellezza
Figura 69 – Il caratteristico Turetto nella scultura, di scalpellino tardo-gotico sconosciuto, di Giovane Dama con la Berretta sulla porta della Sagrestia Antica della Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora della Assunzione a Rouffach in Alsazia, realizzata tra il 1775 ed il 1780. E’ un copricapo dalla base cilindrica bassa ed una calotta superiore a cupola, tenuto da un sottogola di sostegno, di stoffa leggera. La sua descrizione più definita è stata riportata, nel 2021, in un articolo di Gérard Michel, Professore di Lettere e Paleografo francese: il touret è “sorta di cuffia denotativa della nobiltà del XIIIesimo secolo, portata con una mentoniera detta anche barbetta, […] fascia di tessuto che avvolge i capelli e passa sotto il mento. Essa viene indossata abitualmente con la chioma intrecciata, o semplemente raccolta in un nodo sulla nuca tramite una reticella” che lascia libero il resto della capigliatura. Ma secondo alcuni, il Turetto da Naso, oltre ad avere la precipua funzione di apparato estetico, serviva, anche esso, come protezione della pelle nei periodi invernali ed estivi, ed anche per coprire il viso con una velatura pietosa in modo da nascondere la condizione a volte rovinata della pelle delle donne della alta società che praticavano uno sconsiderato uso di unguenti e cosmetici (realizzati spesso con sostanze dannose); le quali, seguendo la moda dell’epoca, abbondavano nella applicazione di creme di bellezza
Ed è stato, questo ricoprimento caratteristico, un elemento iniziale di un oggetto vestiario che ha prodotto una usanza poi allargata a tutto il viso, di cui divenne celebre la copertura mascherata tonda (del tutto simile alla moretta veneziana, della quale mi occuperò in dettaglio più oltre) indossata da Margherita di Valois, la cosiddetta Regina di Navarra (ma anche di Francia, in quanto moglie di Enrico IV) [Figure 70, e 71].
 Figura 70 – Romeyn De Hooghe (o Romeijn De Hooch), Regina di Navarra, 1697-98. Disegno dell’importante artista (pittore, scultore, incisore e caricaturista) olandese barocco di Amsterdam (noto per le illustrazioni dei testi del famoso scrittore-poeta francese, celebre per le sue favole, Jean De La Fontaine), eseguito per il libro di Racconti e Novelle su Margherita di Valois pubblicato nel 1698 (che per altri può essere attribuito al connazionale fiammingo Jacques Harrewyn, o Jacobus Harrewijn), mostrante la tipica maschera (futura Moretta veneziana) da volto intero, in velluto o cartapesta (si vedano le Figure 71; e 85, 91, e 104)
Figura 70 – Romeyn De Hooghe (o Romeijn De Hooch), Regina di Navarra, 1697-98. Disegno dell’importante artista (pittore, scultore, incisore e caricaturista) olandese barocco di Amsterdam (noto per le illustrazioni dei testi del famoso scrittore-poeta francese, celebre per le sue favole, Jean De La Fontaine), eseguito per il libro di Racconti e Novelle su Margherita di Valois pubblicato nel 1698 (che per altri può essere attribuito al connazionale fiammingo Jacques Harrewyn, o Jacobus Harrewijn), mostrante la tipica maschera (futura Moretta veneziana) da volto intero, in velluto o cartapesta (si vedano le Figure 71; e 85, 91, e 104)
E con questi caratterizzanti nascondimenti femminili, il passaggio da una leggera maschera di stoffa, semplicemente copri-faccia, ad una pesante copertura di ferro, nella forma iconografica della immaginazione letteral-romanzata ha potuto diventare quasi scontatamente automatica [Figure 71 e 72].
 Figura 71
Figura 71
Figure 71 e 72 – Il passaggio iconografico dal vellutato copri-faccia morettiano delle dame benestanti al ferreo occultamento del Prigioniero di Pinerolo (e viceversa). In una immagine della artigiana-progettista Gaia Geri (Maschera Moretta del 2019-20) [sopra] e in una foto (di autore ignoto, del 2016) della Maschera di Ferro Imprigionata, ripresa durante le periodiche manifestazioni pubbliche cittadine pinerolesi riferite a quel personaggio [sotto]. Per la cronaca, la Geri è una professionista mascheraia milanese laureatasi in “Designer di prodotto” al Politecnico di Milano, e specializzata nella esecuzione rifinita, disegnata e realizzata su misura sempre a mano, di “maschere in cuoio professionali per il teatro, costruite secondo le tecniche originali in uso nel 1500”, attualmente collaboratrice nel Laboratorio dell’OCA (Officine Creative Ansaldo) della capitale lombarda

Per concludere, comunque, con una certa decisione su tale argomento piuttosto complesso e contrastante, riporto alcune indicazioni tecniche sulle maschere seicentesche più comuni e usate a quell’epoca, e che ne dànno una caratterizzante indicazione: principalmente, l’inventario del 1607 del falegname fiorentino Tommaso Guadagnini, che registra il possesso di “Una maschera di raso nero” (probabilmente di sua esecuzione), e quindi ancòra il testo enciclopedico sopra citato (La Accademia della Araldica) dell’erudito storiografo inglese Holme di Chester (indicato dal suo editore quale “Amabile Amico”), pubblicata nel 1688, in cui viene riportata la esistenza di “due tipi di rivestimenti per il viso alla moda comunemente indossati” allora: dei quali uno “copriva soltanto la fronte, gli occhi e il naso, possedendo fori per vedere e camminare”, e l’altro nascondeva tutto “il resto del viso […] con un panno fino al mento”.
Tali maschere tipiche, ricorda sempre la testimonianza holmeana precisandone le forme – che conviene opportunamente ricordare di nuovo – “erano solitamente riquadrate con una parte superiore piatta o arrotondata, e […] generalmente fatte di velluto nero”, mentre quelle a copertura totale (chiamate “a visiera”) celavano “il volto intero, con fori per gli occhi, una custodia per il naso e una fessura per la bocca, attraverso cui parlare”: un “esemplare di Maschera” che concede grande facilità di indossamento, poichè “si toglie e si mette in un attimo di tempo”).
IL CARNEVALE
La mascheratura ferrea, divenuta vellutata, appena sopra trattata, introduce inevitabilmente a quella che è la maschera per eccellenza, ovunque riconosciuta ed usata per la sua unica qualità di elemento nascondente ed intrigante, di isolamento personale o di seduzione e corteggiamento, nella propria qualità caratteristica di copertura della faccia (accompagnata spesso da un abbigliamento travestente in costume) utilizzata più costantemente durante la festività del Carnevale.
Di cui la più nota e seguìta manfestazione si svolge a Venezia ormai da secoli, e la cui storia contiene in pratica criteri e significati di quell’universale performazione festaiola, che ormai appartiene alla cultura, ed alla partecipazione, di tutta la umanità del globo terrestre.
La prima testimonianza dell’evento carnevalesco (che ha, è noto e l’ho accennato sopra, origini pagane provenienti dalla oscurità della storia, ed in particolare dai riti saturnali della antica epoca romana – durante i quali era possibile mascherarsi per potere così permettersi in incognito ogni sorta di esagerazione in altre occasioni non permesse – più formalmente istituite poi col primo Medioevo cristianizzato) nella tradizione veneziana risale ad un documento emesso dal Doge Vitale Falier nel 1094, nel quale sono riportati una serie di divertimenti pubblici popolari, dove la parola Carnevale (ovvero il permesso libertario di “mangiare carne”, e lasciare ogni restrizione convenzionale) viene citata per la prima volta.
Ma la carnevalità rimaneva sempre un festeggiamento clandestino, per la propria derivazione pagana, e soprattutto per le sfrenate caratteristiche di sfogo popolare che comportava nella sua liberalità ampiamente concessa. Che l’uso della maschera rendeva addirittura più anonimo, e lecito, e dunque partecipativo anche da parte di settori della società di ogni genere, che approfittavano di quell’occultamento opportuno per potersi comunemente divertire, senza venire riconosciuti (e particolarmente anche per le donne), e godere di quel periodo di licenza comportamentale per soddisfare il proprio divertimento insieme agli altri. E con tale sistema di nascondimento delle persone che portavano un mascheramento, l’unica forma di saluto che veniva profferita durante i contatti casuali con le persone ignote incontrate per strada, era esclusivamente – e significativamente, e scontatamente – “Buongiorno Signora Maschera”.
Nella situazione carnascialesca di esibizione pubblica piuttosto anche confusionale, il nascondimento divenne l’aspetto dominante, ed esclusivo (oltre ai conseguenti costumi), della scena urbana; e poi passò – dal Medioevo – alla dimensione privata, nei giorni di festeggiamento carnevalesco ufficialmente stabiliti: imponendosi quale principale – mi si consenta questa contraddizione verbale – riconoscimento nascosto di quel ricorrente avvenimento memorabile.
Che, come adesso, anche se in circostanze ben diverse di pericolosa pandemia, con la Mascherina ricoprente il volto, è divenuto l’unico emblema di ignota referenza personale.
La esperienza carnevalesca veneziana
Il primo documento ufficiale che dichiara il Carnevale di Venezia come festa pubblica è un editto del 1296, emanato dal Senato della Repubblica Serenissima che dichiarò festivo il giorno precedente la Quaresima.
Ma la importanza delle cerimonie carnevalesche svolte liberamente quale atto di festeggiamento pubblico ampiamente diffuso, e perfino sofisticato nella ricercatezza di abbigliamenti e mascherature, come si ritrova testimoniato nel riscontro dogale precedentemente citato del 1094, viene riferita già tempo prima, ed un trentennio dalla fine del Milletrecento; quando è data notizia della nuova e specialistica fabbricazione artigianale di maschere, specificamente costruite per l’evento del Carnevale, attestata a Venezia – documentatamente – dal 1271. Questa produzione di oggetti di copertura del viso, praticate da artigiani specialisti entro laboratori appositi, e sviluppata da particolari scuole esecutive con tecniche di produzione conseguenti, per la loro realizzazione più facile, meglio indossabile, variamente economica, e non per ultimo esteticamente particolare, comportava una attività che non soltanto richiese l’approntamento di espliciti materiali operativi (argilla, gesso e garza, cartapesta) ma anche una idonea realizzazione di strumenti per la lavorazione.
E dunque una particolare tecnicità esecutiva, che parecchie botteghe artigianali procedettero ad elaborare, privatamente, poiché quel mestiere venne riconosciuto ufficialmente come appartenente ad una corporazione effettiva soltanto molto più tardi, con uno Statuto del 10 aprile del 1436, che considerava i suoi professionisti congregati all’interno della Gilda delle Arti.
Moltissimi eventi particolari del festeggiamento carnevalesco, e diffusi in tutta la città ma anche in case private, si svilupparono poi, insieme alle istituzionali concessioni ed ai pubblici cortei: e particolarmente il loro sfoggio esteriorizzato si sviluppò sui palchi improvvisati dei teatranti di strada, nei caffè cittadini, e nei ridotti dei palazzi signorili. E la pratica abitudinaria della maschera si riversò anche negli spettacoli di scena, e particolarmente nella famosa Commedia dell’Arte, che vide proliferare le tipiche mascherature locali, regionalmente caratterizzate.
Nelle espressioni della arte figurativa
Tra tutte le descrizioni verbali, e le performazioni di piazza, niente tuttavia fornisce un resoconto storico come la iconografia repertoriale della espressione artistica riferita al Carnevale sviluppata nelle varie epoche di secolare mascheratura.
E particolarmente per le feste veneziane si posseggono numerosissimi dipinti e illustrazioni celebranti quell’evento straordinario: tutti ovviamente incentrati intorno agli anni di maggiore manifestazione carnascialesca rappresentata (Sei e Settecento) con qualche accenno a situazioni precedenti, e altri esempi – anche plurimi nonchè saltuari – dall’Ottocento in poi.
Dal Cinquecento (ancòra medievale)
Per il secolo XVIesimo della affermazione rinascimentale rimane tuttavia sempre esemplare il caotico, e sovraffollato di persone e azioni, quadro di Pietro Bruegel il Vecchio del 1559, mostrante – nella caratteristica maniera brulicante ed eterogenea che rende riconoscibile il proprio autore – i festeggiamenti popolari carnascialeschi di quel periodo: tuttavia ancòra di tipica connotazione medievale, e confusamente svolti in episodi diversissimi e però incentrati sulla Battaglia tra Carnevale e Quaresima [Figura 73]. Intorno al cui satirico combattimento si possono riconoscere, sebbene arbitrariamente forse (poiché a quell’epoca le maschere non venivano normalmente indossate), alcune goffe persone che, alla apparenza percettiva, potrebbero portare un ricoprimento del volto di genere deformante, coincidente (o interferente) con la loro naturale – e reale – maschera orrenda della propria reale fisionomia fisico-facciale [Figura 74].

Figure 73 e 74 – Pieter Bruegel il Vecchio, La Battaglia tra Carnevale e Quaresima, 1559. In questo dipinto interessante (ed importante, perché è una tra le prime delle realistiche – sebbene eseguita con forme satiricamente esasperate e grottesche – raffigurazioni del Carnevale post-medievale popolare e non più curtense) [sopra], non si riscontrano maschere effettive indossate dalle persone presenti nel quadro; se non nelle due vecchine riportate (nel dettaglio, fotografato da Corrado gavinelli nel 2021) [sotto] che all’apparenza appaiono come volti mascherari caricaturali

Questa raffigurazione rientra, come poco fa ho accennato, totalmente in quella tradizione caratteristicamente di genere medievalesca, spontanea ed improvvisata, senza particolare partecipazione con speciali costumi e maschere, dei divertimenti carnascialeschi più liberi e sfrenati ricorrenti ancòra nella fase storica post-gotica e pre-rinascimentale; ma appartiene anche a quella tendenza invece più (cautamente) moderna di tutta la cultura espressiva germanica che ha considerato, significativamente, i segni del mascheramento maggiormente vero nei volti stessi delle persone viventi (come esporrò più avanti) [Figura 75], drammaticamente deformati dalle avversità della esistenza quotidiana, e dalla loro sofferta (e sofferente) assunzione (ed esteriorizzazione) psicologica, e dalle sfortune – e crudeltà – dello sviluppo sociale.
 Figura 75 – James Ensor, Autoritratto con Maschere, 1899. Il confronto-contrasto tra la immagine veristica dell’artista autoripresosi tra la folla, e l’aspetto mostruoso delle persone caricaturali (maschere umane) che lo circondano, indica la tipica identità – in uso già dal Medioevo nell’arte figurativa europea centro-settentrionale – di rappresentare il volto umano come deformazione dei lineamenti fisici, avvicinantesi alla caratterizzazione deviata della effettiva mascheratura teatrale o fisionomica
Figura 75 – James Ensor, Autoritratto con Maschere, 1899. Il confronto-contrasto tra la immagine veristica dell’artista autoripresosi tra la folla, e l’aspetto mostruoso delle persone caricaturali (maschere umane) che lo circondano, indica la tipica identità – in uso già dal Medioevo nell’arte figurativa europea centro-settentrionale – di rappresentare il volto umano come deformazione dei lineamenti fisici, avvicinantesi alla caratterizzazione deviata della effettiva mascheratura teatrale o fisionomica
Oltre a tale accettabile dubbio di confusione oggettiva tra nascosto e apparente, le vere maschere si vedono apparire ed abbondare, per le feste carnevalesche, nel Seicento, e perfino in splendidi lavori di importanti artisti. Ma esempi sporadici di isolata mascheratura si ritrovano anche in precedenti opere, occasionali: nel 1532-33 una prima maschera da applicare al viso per nasconderlo si vede nel dipinto Venere e Amore del fiorentino Jacopo Carracci detto il Pontormo, eseguito da un disegno di Micelangelo Buonarroti; mentre ancòra prima, nel 1510, una ieratica maschera dal viso umano – A Ciascuno la Propria Personalità – di Ridolfo Del Ghirlandaio già riferita, conferma e allude alla futura ambiguità di quel copri-faccia, quale mezzo ignoto di soggettiva individuazione. Ed esse tutte stanno a confermare un ormai avviato processo di nascondimento rivolto alla decisa eliminazione di qualsiasi riscontrabile personalità individuale [Figure 76-77 (e 78)].
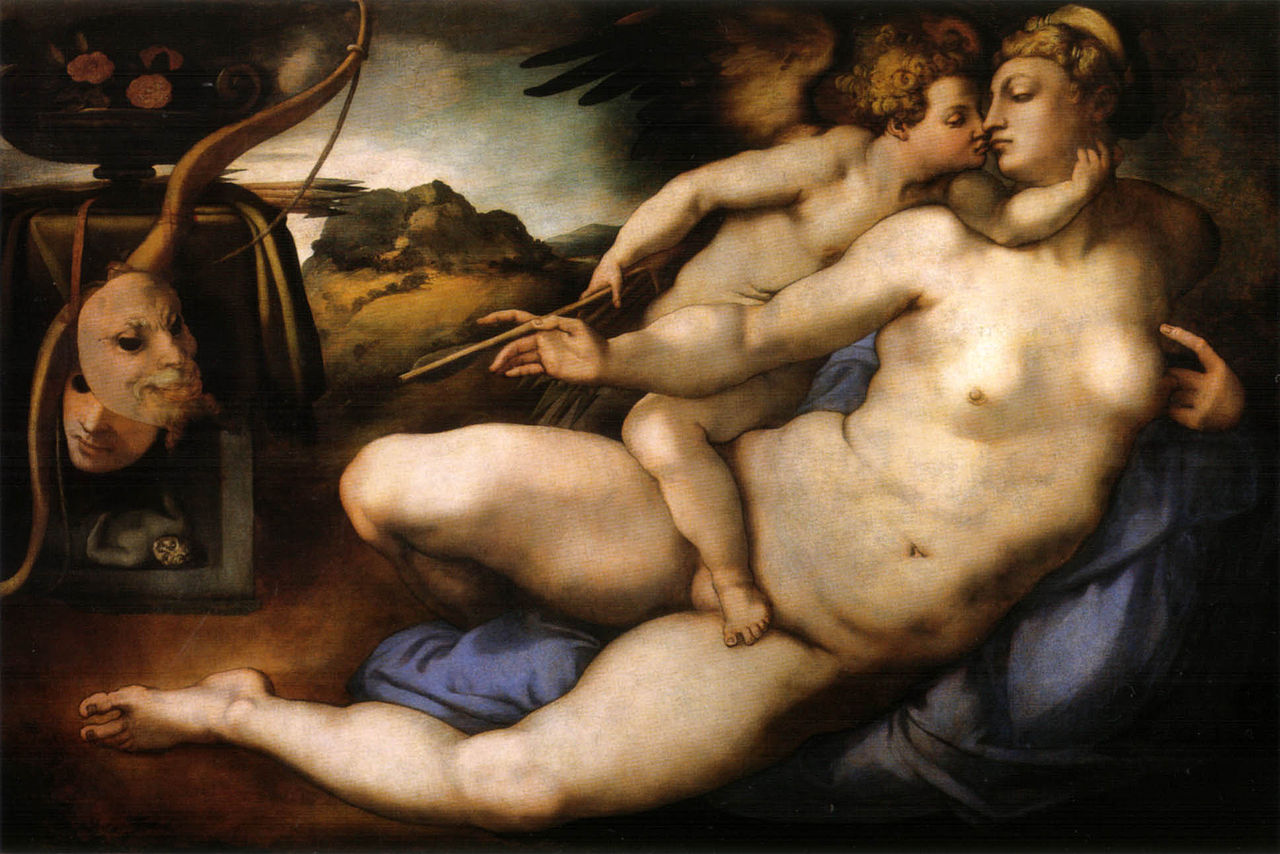
Figure 76 e 77 – Jacopo Carucci detto Pontormo (dal suo paese natale in Toscana, situato alla periferia di Empoli), Venere e Amore, 1532-33 [sopra] ed un Dettaglio del quadro con le maschere del teatro classico-antico [sotto]. Il dipinto è stato eseguito da un disegno di Michelangelo Buonarroti, prima della sua partenza per Roma avvenuta nel 1534

Col Seicento (pienamente effettivo)
La grande stagione della variegata arte mascherale, propriamente carnevalesca o derivata, comincia con il secondo decennio del Seicento, quando ormai il riconoscimento ufficiale del Carnevale è stato pomposamente stabilito, e sviluppato, dalle autorità veneziane soprattutto.
Ma in questa istitutiva convenzione, scontatamente accettata come normale conseguenza del mascheramento quale elemento di riferimento sostanziale – e di fondamentale appartenenza – agli eventi carnascialeschi, si può scorgere tuttavia un proprio ragionevole dubbio di considerazione e provenienza opposta: ovvero che la maschera, usualmente posta sul viso – come abbiamo visto nei casi precedentemente incontrati, per riservatezza, viaggi, vezzi di moda, o cura estetica del volto – sia stata automaticamente trasposta nelle feste di Carnevale come normale coprimento pratico, diventandone poi il più tipico oggetto di definizione oggettiva.
Si ritrovano varie conferme, e prove, di tale mia affermazione soprattutto nella iconografia epocale veneziana e più generale, anche estera, a cominciare dalla famigerata Allegoria della Simulazione dipinta nel 1642-43 da Lorenzo (e non Filippo, artista del Quattrocento con cui da molti viene incredibilmente confuso) Lippi, dove la tipica maschera di semplice fattura cinquecentesca sostituisce metaforicamente la realtà del volto umano [Figura 79].
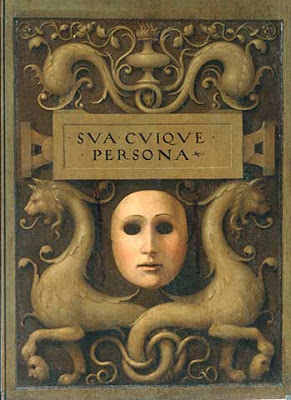 Figura 78 – Ridolfo Del Ghirlandaio, A Ciascuno la Propria Personalità, 1510. E’ la cosiddetta coperta (tavola lignea scorrevole, detta anche tirella, usata dall’inizio del Cinquecento per proteggere i ritratti: per conservarli meglio ma anche per non rovinarli durante una eventuale spedizione) che custodiva il coevo (e dello stesso autore) dipinto Donna Velata, un tempo attribuito a Leonardo da Vinci
Figura 78 – Ridolfo Del Ghirlandaio, A Ciascuno la Propria Personalità, 1510. E’ la cosiddetta coperta (tavola lignea scorrevole, detta anche tirella, usata dall’inizio del Cinquecento per proteggere i ritratti: per conservarli meglio ma anche per non rovinarli durante una eventuale spedizione) che custodiva il coevo (e dello stesso autore) dipinto Donna Velata, un tempo attribuito a Leonardo da Vinci
 Figura 79 – Lorenzo Lippi, La Allegoria_della_Simulazione, 1642-43. Anche con la maschera abbassata, il volto impenetrabile della donna nasconde il reale suo aspetto (e carattere, e pensiero). Questo genere di elementare coprifaccia, prima di uso privato e limitato, è divenuto l’emblema più connotativo del carnevalismo mondiale
Figura 79 – Lorenzo Lippi, La Allegoria_della_Simulazione, 1642-43. Anche con la maschera abbassata, il volto impenetrabile della donna nasconde il reale suo aspetto (e carattere, e pensiero). Questo genere di elementare coprifaccia, prima di uso privato e limitato, è divenuto l’emblema più connotativo del carnevalismo mondiale
Effetto di situazione tipizzante sviluppato anche, e principalmente, nelle rappresentazioni dei festeggiamenti delle cerimonie ufficiali (come mostra la calcografia del 1610 dell’incisore e stampatore veneziano Giacomo Franco riportante le celebrazioni in Piazza San Marco del Giovedì Grasso in presenza del Doge e dei funzionari cittadini, o ancòra il dipinto del 1778-79 del noto artista veneto Francesco Guardi, riguardante Il Doge che assiste alla festa del Carnevale in Piazzetta a Venezia), che mostrano tutti i partecipanti (dai personaggi istituzionali ai semplici curiosi presenti) privi di mascherature particolari (o almeno con pochi esemplari di ricoprimento del volto, non facilmente riconoscibili, e comunque occasionali) [Figure 80 e 81].

Figure 80 e 81 – Due tipiche opere pubblicitarie per l’epocalmente storico Carnevale neneziano: in una litografia del 1610 (Il Giovedì Grasso) di Giacomo Franco – incisore ed editore di libri e stampe già dall’ultimo ventennio del Cinquecento – mostrante le celebrazioni carnevalesche “in Piazza San-Marco” alla presenza delle massime autorità cittadine (non vi si notano maschere, ma normali costumi di abbigliamento comune, e però un palco per spettacoli con acrobati e saltimbanchi) [sopra], e nel più famoso quadro Il Doge assiste alla Festa del Giovedì Grasso in Piazzetta di Francesco Guardi del 1778-79 [sotto], in cui i festeggiamenti sono descritti con più realistica versione e magniloquente illustrazione (ma anche in tale caso con non percepibile presenza di maschere ed con un più fastoso baldacchino rococò)

E’ soltanto dall’inizio del Setttecento che si ritrova, nel quadro del 1732 del famoso pittore veneto Antonio Canal detto Canaletto, illustrante Il Bucintoro di ritorno al Molo il giorno dell’Ascensione, due isolati seguaci del corteo acquatico indossanti maschere coprenti i loro visi [Figure 82 e 83].

Figure 82 e 83 – Dipinto intero [sopra] e suo dettaglio con maschere [sotto] del Bucintoro di ritorno al Molo il giorno della Ascensione realizzato nel 1732 dal prodigioso pittore veneziano Antonio Canal detto il Canaletto, nel quale appare – in una delle sue prime esecuzioni figurative – la immagine di una mascheratura durante una cerimonia pubblica a Venezia
 Figura 83
Figura 83
Tornando però ad altri esempi di mascherature proprie, confezionate per l’uso corcostanziale di moda, festività private, o balli, oltre al già accennato repertorio produttivo del 1607, per quanto limitato, dichiarato dal mascheraio Guadagnini di Firenze, siamo in possesso di una significativa, ed anche eccellentemente disegnata, mezzatinta olandese del pittore e grafico fiammingo Maerten De Vos di Anversa, raffigurante La Vanità delle Donne con Maschere e Busti, genericamente datata “verso il 1600” ma a mio parere riferibile ancora a prima, al 1597-98, che evidenzia un paio di nobili (o soltanto benestanti) dame borghesi mentre si preparano per un evento mascherato importante, insieme con altri personaggi [Figura 84].
 Figura 84 – Una esplicita immagine (La Vanità delle Donne – Maschere e Busti), incisa nel 1597-98 da Maerten De Vos, pittore e grafico fiammingo di Anversa, mostrante il particolare interesse estetico per l’agghindatura mascherata in auge tra Cinquecento e Seicento. Alcuni storici dell’arte considerano questa raffigurazione, seguendo una interpretazione di derivazione moralistica medievale, come la rappresentazione dell’adescamento demoniaco, individuato nelle due persone al centro della stampa, considerate il Tentatore Mondano (l’uomo che taglia a misura i copri-faccia) e la Allegoria del Diavolo (il personaggio camuffato da bestia cornuta): in realtà si tratta di un semplice laboratorio mascheraio – o più precisamente una “piccola bottega”, come accenna la didascalia – con vari generi, e campionature dal vero, di materiali vestiarii e mascheranti
Figura 84 – Una esplicita immagine (La Vanità delle Donne – Maschere e Busti), incisa nel 1597-98 da Maerten De Vos, pittore e grafico fiammingo di Anversa, mostrante il particolare interesse estetico per l’agghindatura mascherata in auge tra Cinquecento e Seicento. Alcuni storici dell’arte considerano questa raffigurazione, seguendo una interpretazione di derivazione moralistica medievale, come la rappresentazione dell’adescamento demoniaco, individuato nelle due persone al centro della stampa, considerate il Tentatore Mondano (l’uomo che taglia a misura i copri-faccia) e la Allegoria del Diavolo (il personaggio camuffato da bestia cornuta): in realtà si tratta di un semplice laboratorio mascheraio – o più precisamente una “piccola bottega”, come accenna la didascalia – con vari generi, e campionature dal vero, di materiali vestiarii e mascheranti
Seguendo la didascalia della stampa, viene fatto un moralistico riferimento alla dannazione diabolica cui tale usanza femminile poteva condurre, che – seguendone le indicazioni – porta a concludere certi critici a vedere, nella figura mascherata con le corna, la rappresentazione fisica del Demonio tentatore: una considerazione che secondo me è da tenere in parziale considerazione, poiché nella scena esibita l’autore ha voluto innanzitutto mostrare gli aspetti specifici delle varie visiere facciali (del genere a moretta, particolarmente in uso dalla fine del Cinquecento) che una delle dame sta provando, assistita da una altra persona già mascherata (e intenta a tagliare le giuste misure da dimensionare sui volti), accanto alla quale un altro individuo, semplicemente, indossa una maschera animalescamente ibrida e cornuta, di spaventevole parvenza, ma spesso impiegata in feste da ballo private.
Questa stupenda immagine è anche forse una delle prime rappresentazioni di maschere dell’epoca, e del loro relativo uso consueto; che a bene osservare nei vasti repertori artistici dei vari pittori e illustratori settecenteschi, particolarmente veneziani, si ripresentano consuetudinariamente nella qualità di aspetto ricercato (e voluto) di manifestazione personale individualistica, e non per specifico utilizzo carnevalesco.
Per tutto il Settecento (ed in totale emblematicità di espressione)
A parte la isolata Moretta disegnata nel 1740 dal pittore veneto Felice Boscarati, che esplicitamente attesta la qualità specifica di quella tipica copertura tonda femminile [Figura 85], dalla seconda metà del secolo XVIII tutta la produzione di artisticità rivolta alle maschere dei più noti pittori, di genere e non soltanto, della cultura veneziana, comprendenti il Guardi già citato e Pietro Falca detto Longhi (che il commediografo Carlo Goldoni nel 1755 ha dichiarato “insigne”), e quindi Giovanni Domenico Tiepolo, è decisamente riferita non a episodi carnascialeschi bensì a tipiche situazioni private di mascherature in luoghi pubblici (marcatamente sale da gioco e luoghi per incontri speciali, o normalmente per strada o in piazza) da parte di cittadini a Venezia.
 Figura 85 – Felice Boscarati, Donna con la Moretta, 1740. Il dipinto del pittore veronese (ripreso da una vecchia fotografia del 1938 scattata dai celeberrimi Fratelli Alinari di Firenze) mostra la tipica maschera femminile più in voga nella moda carnevalesca di Venezia, nel suo caratteristico aspetto malizioso e seduttore
Figura 85 – Felice Boscarati, Donna con la Moretta, 1740. Il dipinto del pittore veronese (ripreso da una vecchia fotografia del 1938 scattata dai celeberrimi Fratelli Alinari di Firenze) mostra la tipica maschera femminile più in voga nella moda carnevalesca di Venezia, nel suo caratteristico aspetto malizioso e seduttore
Questi tre artisti si avvicendano, intersecandosi ed alternandosi in pochi anni con le loro opere – senza particolari confronti di opposizione o di rivalsa, ma in una indipendente contesa di immagini mirate di propria versatilità espressiva – in tipiche figurazioni con maschere: ad iniziare dall’emblematico Ridotto a Venezia longhiano del 1741-43 (dove un notevole assembramento di persone – anche di ceti apparentemente diversi a causa della particolare utenza del locale che era una bisca – si incontrano variamente mascherate) [Figure 86], seguìto da un altro paio di analoghe scene dello stesso autore (Il Ridotto del 1745-46, replicato, ma diversamente, in forma più matura e pastosa un quindicennio dopo nel Ridotto di Venezia del 1756-57) [Figure 87 e 88], cui si interpone un ulteriore simile soggetto

Figure 86-88 – Tre tipiche raffigurazioni del grande interprete delle maschere veneziane Pietro Falca detto Longhi, versatile pittore di Venezia e sagace illustratore della vita quotidiana della capitale veneta: Il Ridotto a Venezia, del 1743-45 [sopra]; Il Ridotto, del 1745-46 [sotto]; e Il Ridotto di Venezia, 1756-57 [in basso]. Il Ridotto in genere indicava la sala di sosta e di pausa, o anche di intrattenimento, di un teatro, dove il pubblico si raccoglie negli intervalli degli spettacoli e nelle attese dell’inizio delle performazioni; ma in passato questi locali erano dedicati al gioco d’azzardo, da altre parti vietato. E per renderne lecita la attività di gioco azzardato, particolarmente a Venezia era stato aperto uno speciale Ridotto nel Palazzo Dandolo del Quartiere San Moisé vicino a Piazza San Marco (prima casa da gioco autirizzata e statale dalla repubblica veneta), gestito direttamente dalle autorità cittadine per sopperire alle sale di contrabbando private e clandestine e per potere incassare proficui (e notevoli) introiti di denaro


sempre di Ridotto di Palazzo Dandolo a San Moisé del Guardi e del 1746-48 (a sua volta meticolosamente presentato nei vari personaggi frequentanti, e nell’ambiente caratteristico di un ampio salone affollato di gente accuratamente mascherata per non farsi riconoscere)[Figura 89], poi in maniera molto simile replicato un decennio più tardi in una Sala Grande del Ridotto a Palazzo Dandolo in San Moisè del 1755-60.
 Figura 89 – Francesco Guardi, Il Ridotto di Palazzo Dandolo a San Moisé, 1746-47
Figura 89 – Francesco Guardi, Il Ridotto di Palazzo Dandolo a San Moisé, 1746-47
E dopo questi quadri vengono altre opere longhiane (Il Cavadenti del 1749-50, il famosissimo Rinoceronte del 1751, Il Colloquio tra Baùte del 1756, e Il Ciarlatano dell’anno seguente) [Figure 90-93], entro la cui sequenza si frappone nuovamente un altro

Figure 90-93 – Altri differenti dipinti longhiani con altrettante figure mascherate, indossanti la loro consueta copertura del viso in pubblico: Il Cavadenti, del 1748-49 [sopra]; il famosissimo Rinoceronte del 1751 [sotto]; nonché [in basso] il Colloquio tra Baùte del 1756 e Il Ciarlatano del 1757
 Figura 91
Figura 91
 Figura 92
Figura 92

esemplare Guardi (Maschere al Caffè Florian, del 1754), documentante una diversa frequentazione tipica di persone mascherate – secondo una situazione che, si è capito, è divenuta ormai rituale nella Venezia di quel tempo – in tutti gli esercizi pubblici, importanti, della città (compresi i teatri, come riferirò tra poco) [94 e 95-96].
 Figura 94
Figura 94
Figure 94-96 – Pietro Longhi, Maschere al Caffè Florian, 1754. Il quadro [sopra] con i particolari degli avventori (in una foto di Corrado gavinelli del 2021) [sotto] e del cameriere servente [in basso]. Anche questo locale – ancòra oggi importante per la sua secolare continuità di servizio pubblico, e che purtroppo sembra debba chiudere per sempre, dopo 300 anni di esercizio compiuti nel 2020, a causa della persistente pandemia del Virus Corona – esiste dal 1720 quando l’imprenditore veneziano Floriano Francesconi lo aperse sulla Piazza San Marco con il nome “Alla Venezia Trionfante”; ma venne sùbito riconosciuto con il nome in dialetto veneto del suo proprietario e gestore, Floriàn; ed assunse una straordinaria fama a Venezia, venendo frequentato da illustri personaggi locali (il commediografo Carlo Goldoni, l’esteta per antonomasia Giacomo Girolamo Casanova, e gli stessi pittori Longhi, Canaletto, e Guardi), e quindi anche stranieri (come lo scrittore statunitense Ernest Hemingway) non soltanto di passaggio

 Figura 96
Figura 96
Ed è in questa fase di competizione stretta che, per così dire, entra in scena anche la versatile personalità ultra-barocca, e decisamente di maestoso rococò, di Giandomenico Tiepolo, con i suoi Minuetti e Maschere: opere versatili ed eterogenee che particolarmente si esprimono vivaci nei dipinti del 1745-48 (Scena di Carnevale) e del 1757 (Maschere del Carnevale di Venezia); con i quali però, e finalmente, viene espressamente glorificato il tripudio edonistico e lussurioso del festeggiamento carnevalesco, nei suoi svariati personaggi e interpreti opportunamente agghindati (ed occultati), tra cui perfino gli attori del teatro goldoniano [Figure 97 e 98]: in una versione tuttavia di inattesa – perché particolare, e piuttosto abbondante – verso le protagoniste femminili, sempre alla ribalta e in primo piano, e perfino a volto scoperto per esibire le loro qualità di seduzione pubblica, ad attestazione piena della gioia sfrenata concessa, e presa, nella licenziosità della festività urbana più permissiva (ma in ottemperaza anche al fatto contingente che tra i teatranti, allora, la presenza di donne attrici era piuttosto ricorrente ed ampia).

Figure 97 e 98 – Due opere carnevalesche di Giovanni Domenico Tiepolo, con tipiche maschere veneziane, appartenenti alla Commedia dell’Arte ma usate ormai nelle manifestazioni di strada: la Scena di Carnevale del 1745-48 [sopra] e le Maschere del Carnevale di Venezia del 1757 (con Pantalone e Colombina in primo piano che danzano il minuetto: in cui la donna è raffigurata senza maschera ed a viso scoperto, come anche a teatro questa attrice era più solita recitare) [sotto]
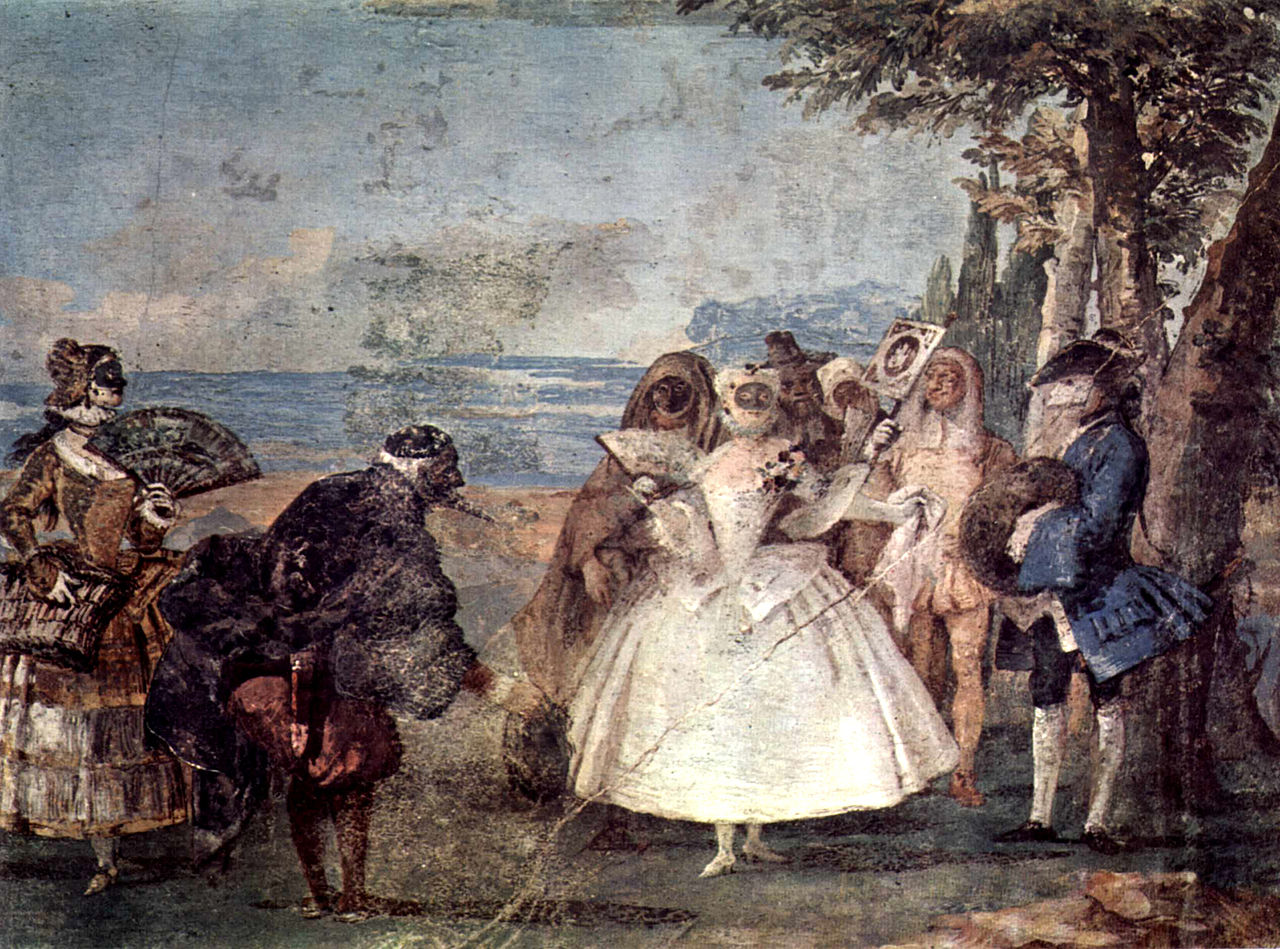
Dalla pittura, la grande popolarità delle maschere individuali coinvolge anche le opere della grafica aneddotica, che ancòra maggiormente diffonde quel genere così particolare – ma ormai comune – di indumento facciale, nelle sue modalità divenute quotidiane: come si evince dalla serie di incisioni didascaliche riffiguranti Le arti che vanno per via nella città di Venezia, del pittore e grafico veneto Gaetano Zompini, pubblicate tutte nella loro completezza con il 1785 ma alcune già stampate nel 1753 essendo state disegnate dal 1746 [Figure 99 e 100], oppure si ritrova nelle sempre immanchevoli illustrazioni vezzose di caratterizzanti artisti veneti (quale si propone idoneamente L’Improvvisante di Francesco Fedeli detto il Maggiotto, inciso da Nicolò Cavalli nel 1786) [Figura 101].
 Figura 99
Figura 99
Figure 99 e 100 – Gaetano Zompini,Le Arti che Vanno per Via nella Citta di Venezia, 1753. Due stampe con persone in maschera, ed i relativi servizi prestati da umili mercanti, talvolta improvvisati, di strada: L’Affittatore di Palchi Teatrali e Il Portatore di Lanterne (soprannominato il Còdega nel gergo veneto) [rispettivamente sopra e sotto]. Le acquaforti del pittore e incisore trevisano, eseguite dal 1746 al 1754, sono state pubblicate – tutte insieme – soltanto un trentennio più tardi, nel 1785

 Figura 101 – Una tipica raffigurazione veneziana (L’Improvvisante, del 1786) di maschere della carnevalità (e non necessariamente della Commedia dell’Arte) ma anche della diffusa moda di privata riservatezza occultante, eseguita dall’artista veneto Nicolò Cavalli, incisore, riprendendo un disegno del corregionale pittore veneziano Francesco Fedeli, detto il Maggiotto
Figura 101 – Una tipica raffigurazione veneziana (L’Improvvisante, del 1786) di maschere della carnevalità (e non necessariamente della Commedia dell’Arte) ma anche della diffusa moda di privata riservatezza occultante, eseguita dall’artista veneto Nicolò Cavalli, incisore, riprendendo un disegno del corregionale pittore veneziano Francesco Fedeli, detto il Maggiotto
Da costume diversivo di una società spensierata, tendente ad una maniera di falsità spettacolare che l’avvento della vicina rivoluzione anti-assolutistica avrebbe anche drasticamente ridotto, la mascheratura allegra viene trasformata in un elemento coprente da farsa raffigurativa: che le formalmente stravaganti calcografie delle Mascherate dell’architetto francese Ennemond Alexandre Petitot, sarcasticamente anticipano in un critico pasticcio grafico di eterogenea assemblatura assurda [Figura 102].
 Figura 102 – Benigno Bossi (da un disegno di Ennemond Alexandre Petitot), L’Autore delle Figure alla Greca, 1771. Con le Mascherate del noto architetto e artista francese che lavorò anche alla Corte di Parma al servizio del Duca Filippo di Borbone, composte con assurde figure in costume eclettico, non soltanto viene espressa una parodia del ripetitivo accademismo delle Scuole delle Belle Arti, ma denunciato anche il sintomo di decadenza esteriore delle mascherature nel frivolo mondo curtense del Settecento, anticipando il disagio social-culturale poi esploso un ventennio dopo con i cambiamenti della Rivoluzione Francese
Figura 102 – Benigno Bossi (da un disegno di Ennemond Alexandre Petitot), L’Autore delle Figure alla Greca, 1771. Con le Mascherate del noto architetto e artista francese che lavorò anche alla Corte di Parma al servizio del Duca Filippo di Borbone, composte con assurde figure in costume eclettico, non soltanto viene espressa una parodia del ripetitivo accademismo delle Scuole delle Belle Arti, ma denunciato anche il sintomo di decadenza esteriore delle mascherature nel frivolo mondo curtense del Settecento, anticipando il disagio social-culturale poi esploso un ventennio dopo con i cambiamenti della Rivoluzione Francese
Con la modernità, e le successive evoluzioni (ed estinzioni)
Ma se con la fine del Settecento cala anche la portentosa tradizione del carnevalismo veneziano, ugualmente gli eventi della festività carnasciale si propagano, variamente diversificati, ovunque fuori dalla sola città lagunare [Figura 103]; smorzandosi però nel loro
 Figura 103 – Antoine Jean Louis Baptiste Thomas, La festa dei Moccoletti, 1817. Opera mista in acquarello e tempera di questo pittore francese specializzatosi in scene popolaresche e soggetti di genere, nelle cui opere avevano una ampia rispondenza rappresentativa costumi regionali e maschere delle festività (come si può riscontrare in questa usanza di Roma, conseguente al carnevale ed alla sua giornata di chiusura del Martedì Grasso, secondo la quale i festanti cercavano di spegnere i lumi ai partecipanti rincorrendosi per la Via del Corso)
Figura 103 – Antoine Jean Louis Baptiste Thomas, La festa dei Moccoletti, 1817. Opera mista in acquarello e tempera di questo pittore francese specializzatosi in scene popolaresche e soggetti di genere, nelle cui opere avevano una ampia rispondenza rappresentativa costumi regionali e maschere delle festività (come si può riscontrare in questa usanza di Roma, conseguente al carnevale ed alla sua giornata di chiusura del Martedì Grasso, secondo la quale i festanti cercavano di spegnere i lumi ai partecipanti rincorrendosi per la Via del Corso)
entusiasmo vissuto e attivamente proseguito, e diventando un tipico soggetto di genere artistico come altri, non più particolarmente speciale. Di cui anche gli autori moderni si occupano, per ripresa formalistica di un passato nostalgico un tempo importante (come ha fatto Alberto Martini – artista e grafico italiano, divenuto poi pittore surrealista – con il suo acquarello Settecento Veneziano del 1904) o per riferimento pubblicistico verso un evento divenuto di attrazione ormai alquanto turistica (quale si vede evidenziato nel manifesto Venezia del 1924-25, del pittore e scenografo toscano Umberto Brunelleschi, altamente specializzatosi in soggetti mascherari) [Figure 104 e 105].

Figure 104 e 105 – Alberto Martini, Settecento Veneziano, 1904 [sopra], e Umberto Brunelleschi, Venezia, 1924-25 [sotto]. In queste epocalmente commemorative opere (la prima a china acquerellata, e l’altra a tempera e matita) la maschera veneziana è diventata ormai, con la affermata fase industrial-moderna, una memoria della storia del costume, e non più un vivo elemento della vita quotidiana o festaiola

Oppure si ritrova diversamente deviato verso un interesse particolarissimo del mondo delle maschere, quello del circo e del funambolismo, come più specificamente tratterò tra poco parzialmente (ma con maggiore completezza nella Parte Seconda di questo mio saggio) per i lavori su questa tematica affrontati dai protagonisti della nuova Arte di Avanguardia del Novecento.
Ma per concludere la trattazione storico-epocale, cronologica, dell’argomento mascherario più recente, tra i pittori convenzionali, ancòra affezionati alla tematica storica del carnevalismo mascherato, e particolarmente nei confronti della manifestazione prettamente veneziana, si ritrovano il napolitano Vincenzo La Bella (autore di diversi quadri su tale genere: Una Sera del Carnevale di Venezia, del 1911; Carnevale a Piazza san Marco, del 1915; o Ballo di Carnevale, 1939) [Figure 106-108] …

Figure 106-108 – Vincenzo La Bella, pittore napolitano e bozzettista, autore di diversi quadri di genere mascherario, tra cui Una Sera del Carnevale di Venezia del 1911 [sopra], Carnevale a Piazza san Marco del 1915 [sotto] e Ballo di Carnevale del 1939 [in basso]


ed il parigino François Flameng (che ha lasciato enfatiche espressioni altamente illustrative di quell’evento, quali il vedutisticamente sontuoso Carnevale a Venezia del 1918-19 e la più tonalmente intimizzata Festa Veneziana del 1920) [Figure 109 e 110].

Figure 109 e 110 – Un altro caratteristico interprete artistico del carnevalismo tradizionale: il pittore francese Francois Flameng, in due sue opere tipiche: Il Carnevale a Venezia del 1918-19 [sopra] e Festa Veneziana del 1920 [sotto]

A questi lavori si intromettono anche autori della più avanzata modernità progressista (tra cui lo spagnolo Joan Mirò, con Carnevale di Arlecchino del 1925, ed il russo Marc Chagall con Carnevale Notturno del 1963), in opere di carattere però non determinanti o particolarmente influenti nell’insieme della carriera già precisa e formata dei loro esecutori [Figure 111 e 112].

Figure 111 e 112 – Un paio di dipinti di artisti appartenenti alle Avanguardie pittoriche del Novecento (un movimento di estrema modernità i cui partecipanti si sono tuttavia ampiamente interessati a soggetti tradizionalistici con maschere, ma scarsamente agli eventi propriamente carnevaleschi) espressamente riferiti alle festività carnasciali: il Carnevale di Arlecchino, dello spagnolo Joan Mirò, del 1925 [sopra], e il Carnevale Notturno, del russo Marc Chagall, del 1963 [sotto]

E nel secondo dopoguerra mondiale, sempre di più si affievolisce l’interesse carnevalesco negli artisti, proseguito soltanto da alcuni di loro con lavori più sostenutamente riferiti (ad esempio dalla pittrice italiana – realista e futurista – Marisa Mori, autrice di vari soggetti: Le Due Maschere nel 1931, i visi schematici di La Divisione Meccanica della Folla del 1933, e la fantomatica Maschera Rosa del 1952-53) [Figure 113-115],

Figure 113-115 – La consunzione figurativa del tema mascherario storico, nei lavori della pittrice italiana Marisa Mori: nel realistico Studio per le Due Maschere del 1931 [sopra], nella secondo-futurista Divisione Meccanica della Folla del 1933 [sotto], e nel più tardo, fantomaticamente neo-realista, Maschera Rosa del 1952-53) [in basso]

 Figura 115
Figura 115
oppure quale tematica nostalgica che altri diversamente affrontano in maniera ormai evocativa e formalisticamente generalizzata (come è captabile nelle Mascherine di Carlo Iacomucci del 2020, emblemi di un teatrino di ridotta – ed evanescente – importanza e realtà) [Figura 116].
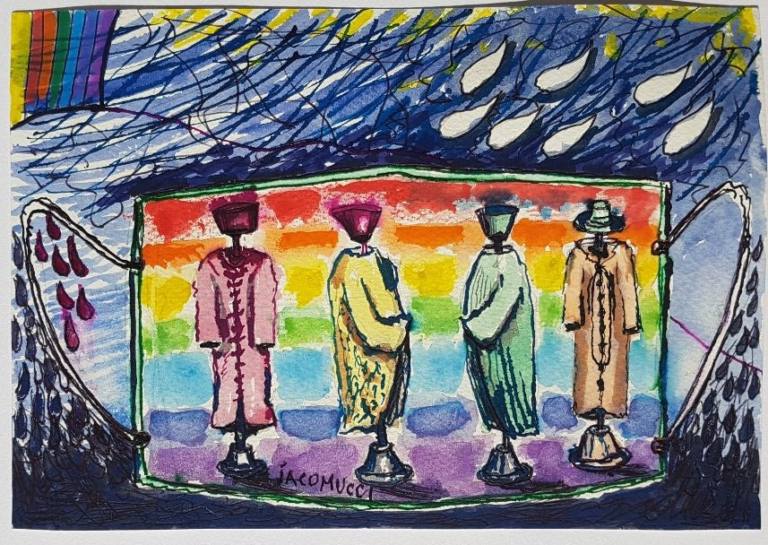 Figura 116 – La sparizione oggettiva della maschera quale elemento di tradizione figurativa, nel teatrino schematico (per altro significativamente intitolato in diminutivo: Mascherine) realizzato nel 2020 dall’artista, e soprattutto incisore, urbinate Carlo Iacomucci
Figura 116 – La sparizione oggettiva della maschera quale elemento di tradizione figurativa, nel teatrino schematico (per altro significativamente intitolato in diminutivo: Mascherine) realizzato nel 2020 dall’artista, e soprattutto incisore, urbinate Carlo Iacomucci
Lavori di ultima ricorrenza mascherale nell’arte, che lasciano così definitivamente lo spazio operativo alla ampia confezione degli esperti artigiani della fabbricazione di maschere; tra i cui interpreti odierni e capaci della vecchia tradizione veneziana dei Maestri mascareri ha in Sergio Boldrin (e suo fratello Massimo) di Venezia gli ultimi esponenti più impegnati e conseguenti [Figura 117]; e nel – da non molto deceduto, nel 2016, e suicida – scultore Donato Sartori di Abano Terme presso Padova (denominato “l’artista delle maschere”), il maggiore rappresentante espressivo delle acconciature visuali da impiegare nelle opere di teatro [Figure 118].

Figure 117 e 118 – Due prodigiosi produttori professionistici italiani di maschere artigianali storiche ed attuali: il veneziano Maestro mascherario Sergio Boldrin (gestore, insieme al fratello Massimo, della Bottega dei Mascareri a Venezia nelle due sedi di Calle dei Saoneri ed a Rialto) con il designer francese Philippe Tabet suo recente collaboratore progettuale (in una fotografia di Laila Pozzo del 2018) [sopra] e “l’artista delle maschere” Donato Sartori, scultore padovano di Abano Terme, il maggiore interprete espressivo delle coperture visuali da impiegare nelle opere teatrali (in una sua immagine del 2016) [sotto]

Moretta e Baùtta
Non si tratta, per queste due tipiche parole venete, di due nomi strani di personaggi di scena, ma proprio delal denominazione tipica delle due maschere più note e utilizzate del Carnevale veneziano, storiche e della espansa utenza del camuffamento facciale nelle più recenti festività carnascialesche. Che, per finire con un didascalico riferimento all’aspetto più significativo dei caratteristici copri-volto già accennatamente incontrati in precedenza, di sicuro riescono tipologicamente – e morfologicamente – a distinguersi, tra gli ormai molteplici, e anche bizzarri, mascheramenti utilizzati nelle festività del carnevalismo più eterogeneo, quali modelli altamente singolari, ed anche esteticamente di ampia rappresentatività.
La prima, la già diverse volte in precedenza citata Moretta, dal suo essenziale e puro contorno ovale, grazioso o femmineo, resta sempre di vasta usanza personale ed internazionale nel proprio impiego preferenziale da parte delle donne [Figure 85 e 104], che sapeva garbatamente coprire la intera faccia con un disegno regolare e di forma ellittica tipicamente barocca; e l’altra, la Baùtta, prettamente veneziana ed indossata indifferentemente da tutti, e non solo gli uomini, per la sua particolarmente comoda possibilità di applicabilità facciale e gestione pratica [Figura 119], poiché la sua accentuata prominenza nella parte inferiore della bocca e del mento consentiva al portatore la facile opportunità di cibarsi e abbeverarsi senza dovere essere tolta [Figure 92 e 99].
 Figura 119 – Manifesto illustrativo della famosa maschera (prevalentemente maschile, ma sovente indossata anche dalle donne) della Bautta, disegnata da un grafico sconosciuto dello Studio The Venetian Infographics nel 2020 (ridattamento tecnico di Corrado Gavinelli del 2021)
Figura 119 – Manifesto illustrativo della famosa maschera (prevalentemente maschile, ma sovente indossata anche dalle donne) della Bautta, disegnata da un grafico sconosciuto dello Studio The Venetian Infographics nel 2020 (ridattamento tecnico di Corrado Gavinelli del 2021)
Originariamente bianca (e per ciò chiamata Larva), la copritura bauttana si metteva sotto un caratteristico tricorno settecentesco nero, e con un mantello scuro (denominato Tabarro) avvolgente l’intero corpo, dalle spalle alle caviglie. Adoperata comunemente – come abbiamo visto nelle precedenti raffigurazioni artistiche – nel vestiario quotidiano di uscita pubblica delle persone, questo nascondimento facciale si diffuse nelle mascherate di Carnevale ma in particolare anche nei teatri dopo la proibizione per le donne di mostrarsi in pubblico a viso scoperto, una sanzione a Venezia introdotta nel 1776 e durata fino al 1797, anno in cui tutti i generi di occultamento vennero proibiti), ed in genere negli eventi di feste e balli allorchè gli utenti desideravano rimanere nel più totale anonimato.
NELLA COMMEDIA DELL’ARTE
La popolarità generale e la rinomanza festaiola del Carnevale Veneziano ne hanno fatto un evento internazionale seguitissimo e frequentato da persone di tutto il mondo, che già dalla epoca frivola del Settecento rococò divenne una manifestazione di partecipata attrazione generale a carattere perfino turistico, seguìta da centinaia di persone giungenti a Venezia dalla più varie località, soprattutto europee, per consumare una festività ormai di pura attrazione pubblica e divertimento collettivo, proseguita fino ai giorni nostri.
Ed alla maggiore popolarizzazione della maschera verso quei ceti che meno formalmente seguivano gli eventi carnascialeschi nei tipici travestimenti mascherati più consueti di circostanza istitutiva, contribuì notevolmente l’attività teatrale dell’epoca, particolarmente dal Seicento: e soprattutto con gli spettacoli improvvisati nelle piazze cittadine su baldacchini rialzati [Figura 120], e inevitabilmente con le vivaci e comiche rappresentazioni del Teatro dell’Arte, nato proprio a Venezia in corrispondenza (anche satirica) con le mascherate garbate e perfino cicisbee delle corti monarchiche, e dei ceti nobiliar-borghesi, trasferita edonisticamente nella carnevalità maggiormente abituale.
 Figura 120 – Ignoto Tardo-Seicentesco, Carnevale in Piazza San Marco, 1697-1701. Il dipinto evidenzia espressamente il tipico teatrino di piazza durante le feste carnevalesche, da cui è provenuta poi la tradizione stabile-itinerante della Commedia dell’Arte
Figura 120 – Ignoto Tardo-Seicentesco, Carnevale in Piazza San Marco, 1697-1701. Il dipinto evidenzia espressamente il tipico teatrino di piazza durante le feste carnevalesche, da cui è provenuta poi la tradizione stabile-itinerante della Commedia dell’Arte
Spettacoli di piazza e di interno
E’ verso la metà del Cinquecento che, seguendo il grande sviluppo e la richiesta performativa di questo genere artistico teatrale prevalentemente svolto, in precedenza, nel chiuso delle corti signorili (di cui un esempio interessante sono le scenografie sorprendenti di Leonardo Da Vinci nel suo periodo teatrale svolto al Ducato di Milano presso Ludovico Maria Sforza detto il Moro tra il 1482 ed il 1494; ma anche dopo, nel primo ventennio cinquecentesco altrove e in Francia, come esporrò più avanti), in cui attori e acrobati indossavano leggere maschere ricoprenti i volti (come ha egregiamente mostrato, nella ricostruzione della festa alla corte sforzesca il recente filmato televisivo Leonardo girato nel 2019-20 dal regista e drammaturgo Stephen – Steve – Thompson con il produttore statunitense Frank Spotnitz, nella sceneggiatura del romano Domenico Sica e nei costumi del cagliaritano Alessandro Lai), a Venezia, e non soltanto, aprirono numerosi piccoli teatri, rivolti anche ad un pubblico popolare (amplificando in pratica, con persone vere e non manichini, l’esperienza più semplice dei burattinai). E con l’inizio del secolo successivo, la crescita della quantità e della capacità di rappresentazione delle compagnie teatrali – formate ormai da artisti professionisti che lavoravano, itinerantemente, anche fuori dalle città – si svilupparono autentiche attività produttive collegate all’àmbito del teatro, perfezionanti le arti sceniche e l’artigianato dei costumi e delle maschere per esse necessari.
Le mascherature, soprattutto, si specializzarono, e divennero elementi tipici della teatralità, diverse ed indipendenti da quelli del Carnevale (anche se poi, col tempo, divennero pure esse parte sostanziale degli eventi carnevaleschi) e con un numero limitato di soggetti (in corrispondenza al circoscritto sistema quantitativo di attori che potevano agire sulla scena alquanto ristretta dei palchi).
Ed insieme, si affermarono parecchi e ingegnosi autori teatrali, interpreti di esecuzioni sempre più elaborate e raffinate, che portarono … alla ribalta vari spettacoli per tutti.
Eppure, la organizzazione, con affermazione e rinomanza, della Commedia dell’Arte – che nasce proprio a Venezia già dal Cinquecento e si definisce nel 1750 ad opera del famoso drammaturgo e librettista veneziano Carlo Goldoni – richiese alquanto tempo per attuarsi, e si formò istitutivamente quando questo suo rinomato fautore introdusse stabilmente all’interno del proprio repertorio non tanto la teatralità comica (che già esisteva anche prima) quanto il Canovaccio, quella sorta di testo scenografico (che diventò poi il tipico Copione) soltanto indicativo dello sviluppo della trama, che si sostituiva al precedente criterio improvvisante di recita sui palcoscenici.
La sociale importanza degli spettacoli goldoniani, nei quali la Maschera (che in tale caso non rappresenta soltanto la copertura del viso ma comprende la intera figura, in costume, del protagonista che l’attore indossa e interpreta) diventa il principale, ricorrente e dominante, elemento di connotazione dei soggetti artistici nella rappresentazione, con i suoi espliciti e unici aspetti esteriori e caratteriali, ciascuno riferiti a particolari identità dell’indole umana e ad individui di tipico riferimento regionale o localistico.
Ma per dare una condizione storica meglio precisata di questa evoluzione teatrale, occorre riportarsi – sinteticamente – alle provenienze e origini della teatralità commedial-artistica.
Dal Cinquecento
Partendo dal precedentemente accennato, esemplare e significativo (poiché riporta un palco teatrale durante il Carnevale in Piazza San Marco a Venezia), quadro tardo-seicentesco (eseguito tra il 1697 ed il 1701) di artista ignoto [Figura 120], si può bene vedere non soltanto l’occasionale (non totalmente improvvisato, perché doveva seguire le condizioni di un facile smontaggio e ricostruzione nella consueta attività itinerante dei teatranti) luogo di scena tipico della Commedia dell’Arte arcaica, approntato su una semplice pedana quasi precariamente sostenuta da un alto traliccio che permettesse la visione degli spettacoli anche da relativamente lontano ed al di sopra della folla accalcata [Figura 121], ma contarne anche i ridottissimi interpreti sul palcoscenico (originariamente proprio 2 di numero, con qualche rimpiazzo dietro le quinte), riconducenti alla duplice qualità originaria essenziale del teatro classico, della tragedia e della commedia greco-romana [Figura 122 (e 124)].
 Figura 121 – Particolare del palco teatrale nel dipinto del Carnevale in Piazza San Marco del 1697-1701 (si veda la Figura 120), con i commedianti mentre recitano ed il loro pubblico accalcato, sottostante (foto di Corrado Gavinelli del 2021)
Figura 121 – Particolare del palco teatrale nel dipinto del Carnevale in Piazza San Marco del 1697-1701 (si veda la Figura 120), con i commedianti mentre recitano ed il loro pubblico accalcato, sottostante (foto di Corrado Gavinelli del 2021)
Un abbinamento di minima composizione ed elementare che comprendeva recitazione e musica, serietà e ridicolaggine, e costituita da un attore di prosa declamante (vestito come un normale signore dell’epoca) ed una comparsa comica e suonante (con indosso un caratteristico costume di maschera regionale) [Figura 123].
 Figura 122 (foto di Corrado Gavinelli del 2021)
Figura 122 (foto di Corrado Gavinelli del 2021)
Figure 122 e 123 – Confronto epocale tra il caratteristico teatro improvvisato per le feste pubbliche nel Seicento (nel dettaglio dei commedianti nel solito Carnevale in Piazza San Marco del 1697-1701) [sopra]e il palchetto elementare degli attori itineranti – chiamati ancòra Ciarlatani – del Cinquecento (in una stampa di incisore anonimo del 1568, riferita – con dizione italiana volgare – ai Ceratani) [sotto]

Tale ipostatizzata raffigurazione riporta direttamente alla simile, ma precedente di un secolo, stampa cinquecentesca (di altrettanto autore sconosciuto, ma di data precisata: il 1568), che singolarmente mostra un duetto di Ciarlatani (come venivano allora chiamati questi attori da strada) ugualmente tragico-comico, in un paio di musici in equilibrio quasi instabile su un palchetto ancòra più precario appoggiato su due cavalletti ripiegabili [Figura 124],

Figura 124 – La derivazione antica della coppia di attori di teatro cinque-seicenteschi nella arcaica rappresentazione scenica della classicità romana, come la si vede nell’affresco della Tragedia con il Messaggero ritrovata a Pompei nella Villa dei Dioscuri, dipinta tra il 63-64 e il 68
in una impostazione scenica rimasta pressocchè invariata nel proseguimento dei secoli per tutte le compagnie itineranti, e svolgenti i loro spettacoli alll’aperto (come chiaramente si può osservare negli splendidi dipinti, rispettivamente del 1657 e del 1793-94, dell’olandese – forse di origini franco-ugonotte – Karel Dujardin (I Ciarlatani Italiani, o anche Zanni, Scaramuccia, e la Ruffiana, oppure Commedianti di Strada con Zanni e il Capitano) e del più rinomato autore spagnolo Francisco De Goya (I Comici Ambulanti) [Figure 125 e 126].

Figure 125 e 126 – La secolare invarianza scenica della rappresentazione teatrale itinerante elementare, con il vecchio duetto recitante di attore e musico (I Ciarlatani Italiani; intitolato anche Zanni, Scaramuccia e la Ruffiana, o Commedianti di Strada con Zanni e il Capitano), dipinto nel 1657 da Karel Dujardin, pittore amsterdamino della cosiddetta Età d’Oro Olandese [sopra], e con un più infoltito gruppo di protagonisti di eterogenea consistenza performativa (I Comici Ambulanti del 1793-94) del grande pittore spagnolo Francisco De Goya [sotto]. E’ particolarmente interessante la composita opera goyesca di gusto parzialmente ancòra tardo-rococò rappresentante già una compagnia di attori itineranti della Commedia dell’Arte in un luogo di campagna, segnalata da un cartello con la scritta “Aleg. Men” ai piedi del palco, che si riferisce alla scena della Allegoria Menandrea della satira classico-antica del drammaturgo Menandro, commediografo greco attivo tra il 321 ed il 291. Sul tipico palco sollevato, al cospetto di un pubblico occasionale, si esibiscono un Arlecchino giocoliere, un Pierrot dal ruolo buffo, e Colombina, insieme a un Aristocratico da Operetta azzimato, e un insolito Pulcinella nano e ubriaco; mentre attraverso il drappeggio che fa da sfondo appare una deforme maschera nasuta, molto probabilmente di Pantalone, in attesa di entrare in scena

Le rappresentazioni al coperto
Diversamente dagli spettacoli di piazza e di contrada, rivolti alla gente di ogni ceto sociale che poteva liberamente vederli, e forse anche cronologicamente prima, la teatralità istituzionale, particolarmente mascherata, si sviluppò – dal Rinascimento – all’interno di ambienti chiusi e protetti (inizialmente saloni di residenze signorili e poi luoghi teatrali specializzati e tipologicamente composti con architetture apposite), rivolti alla sola utenza di personalità politiche importanti ed influenti (grandi monarchi, e capi di Stato ducali, oppure facoltosi signori) ed alle loro Corti.
Tale limitata partecipazione selezionata influì notevolmente sul genere e sulla qualità delle rappresentazioni, che inizialmente per spettacoli in costume – ed eventualmente con maschere – riguardarono, fondamentalmente, il solo ballo. Ma in breve tempo coinvolse anche, nel repertorio teatrale, le più popolari esibizioni della Commedia dell’Arte, che sebbene non esplicitamente richieste dagli scenografi di re e persone benestanti, vennero espressamente offerte dalle compagnie di attori appositamente istituitesi per i loro spettacoli a chi li richiedeva, e particolarmente alle sedi cortigiane.
Opere teatrali effettive erano già ricorrenti in tutti gli àmbiti curtensi, europei; ed in Italia una particolare predilezione per questi intrattenimenti nobiliari si sviluppò, in una sorta di concorrenza culturale indiretta, tra i potenti mecenati dell’epoca (i Visconti a Milano, i Gonzaga a Mantova, gli Este a Ferrara, i Bentivoglio a Bologna, i Montefeltro a Urbino, i Medici a Firenze); dei quali il fiorentino Duca cittadino Lorenzo il Magnifico fu il massimo sostenitore (ed anche occasionale interprete, in quanto egli stesso autore di una sacra Rappresentazione di San Giovanni e Paolo che fece recitare da giovani attori delle corporazioni d’arte fiorentine), come per altro conferma anche il noto suo ritratto eseguito dal pittore (nonché architetto e storico-teorico della Rinascenza) toscano Giorgio Vasari nel 1533-34, in cui accanto al magnificato personaggio appaiono ben tre maschere di genere antico (ed appunto classico, secondo la caratteristica tendenza della rinascita dei tempi greco-romani) [Figure 127, e 128-129].
 Figura 127 – La riproposizione rinascimentale della maschera storica, rinvenuta dalla classicità del teatro greco e romano: nel ritratto del Duca e Signore di Firenze Lorenzo De Medici detto il Magnifico eseguito dal pittore ed architetto Giorgio Vasari nel 1533-34 per elogiare le virtù di quel defunto mecenate delle arti, evidenziandone le condizioni con scritte esaltative (nella parte alta del quadro, una maschera cosiddetta bella che si confronta e riflette nel viso del personaggio ritratto, con il motto “Il Vaso di Tutte le Virtù”; più sotto, un mascherone mostruoso con le parole “La Virtù Sottomette i Vizi”; ed in basso il mascheramento animalesco con la sentenza rivelante: “Come i Miei Avi Fecero con Me, Anche Io con la Mia Virtù Illuminerò il Cammino dei Miei Successori”
Figura 127 – La riproposizione rinascimentale della maschera storica, rinvenuta dalla classicità del teatro greco e romano: nel ritratto del Duca e Signore di Firenze Lorenzo De Medici detto il Magnifico eseguito dal pittore ed architetto Giorgio Vasari nel 1533-34 per elogiare le virtù di quel defunto mecenate delle arti, evidenziandone le condizioni con scritte esaltative (nella parte alta del quadro, una maschera cosiddetta bella che si confronta e riflette nel viso del personaggio ritratto, con il motto “Il Vaso di Tutte le Virtù”; più sotto, un mascherone mostruoso con le parole “La Virtù Sottomette i Vizi”; ed in basso il mascheramento animalesco con la sentenza rivelante: “Come i Miei Avi Fecero con Me, Anche Io con la Mia Virtù Illuminerò il Cammino dei Miei Successori”
 Figura 128
Figura 128
Figure 128 e 129 – Due raffigurazioni di situazioni mascherarie teatrali della epoca classica romana, entrambe di artisti sconosciuti: l’assorto Attore e Maschera, affrescato nel 69-71 su una parete della Casa del Poeta Tragico a Pompei [sopra], adesso conservato nel Museo Archeologico Nazionale a Napoli, che potrebbe apparire (nella disposizione delle figure e nella loro concentrazione mentale) come la immagine di modello classicistico per il dipinto vasariano di Lorenzo il Magnifico (si veda la Figura 127); e il mosaico alle Terme Deciane di Roma riportante Le Due Maschere, comica e tragica, del teatro latino, eseguito nel 251 dopo Cristo (adesso sistemato nei Musei Capitolini della capitale italiana) [sotto]

E non è, dunque, certamente un caso se dalla metà del Cinquecento sui palcoscenici di corte apparvero sempre più frequentemente anche attori comici, e mascherati: gli stessi che abitualmente si esibivano negli spazi urbani all’aperto, e che poi – chiamati da diversi committenti o per loro iniziativa propositiva – decisero di esibirsi anche in appositi locali al chiuso.
I Commedianti dell’Arte, non più ciarlatani ma autentici attori professionisti, indipendentemente dalla loro definitiva importanza ricevuta con il Goldoni nel Settecento, avevano una loro originaria tradizione negli anni della piena affermazione della Rinascita culturale cinquecentesca.
E stando a quanto afferma un anonimo articolo del 2014 pubblicato sul sito telematico delle Edizioni ErreCi dirette dal bolognese Carmelo Adolfo Rinaldi (“giornalista, scrittore, sociologo ed esperto di pubblicità”), sostanzialmente “Si può anche dire che la storia documentata della Commedia dell’arte iniziò nel 1545, quando a Padova una compagnia di comici sottoscrisse il primo contratto professionale conservato, con il quale gli attori si assumevano l’impegno di viaggiare, dietro compenso, per rappresentare spettacoli”.
Anche la iconografia dell’epoca documenta tempestivamente, e con eloquenza figurativa, l’avvento e la attività di questi teatranti organizzati, ed anche tecnicamente capaci, che inoltre – diversamente dalle grandiose e costosissime sceno-coreografie dei teatri signorili – si accontentavano della sola performazione attoriale e strumentale senza scenari sfarzosi e con elementari allestimenti di semplici fondali asettici.
Del 1750 è infatti una interessante litografia a colori inglese, di autore ignoto, illustrante “un gruppo di festaioli” intenti a Prepararsi per una Mascherata “circa il 1560” [Figura 130],

Figura 130 – Artista Inglese Ignoto, Preparazione per una Mascherata, 1754: la scena riporta le maschere della Commedia dell’Arte come si presentavano a metà del Seicento (“Circa 1650″, come è scritto nella presentazione della immagine), in un connubio di costumi d’epoca e di autonomi mascheramenti parziali (di cui si riconoscono un monaco ed una suora in un inconsueto saluto galante)
come dichiara la spiegazione della immagine; che, sebbene indicata inesattamente nel suo titolo generico di “mascherata”, riguarda invece una tipica scena teatrale di commedia dell’arte, con maschere popolari e attori in azione, di cui l’aggiunta a matita nella parte superiore – una battuta del dialogo scenico – conferma la effettiva consistenza (“E con sguardo pudico Ella Disse: Prego, mio Signore: Voi mi Conoscete Bene”). Ma indipendentemente da tutto, si tratta di una interessante raffigurazione iconologica particolare di gruppo festante, in quanto non soltanto quella illustrazione riporta la composizione alle forma più tipica delle rappresentazioni medievali pluri-mascherate delle Feste dei Folli (di cui esporrò tra poco), ma ne sembra anche addirittura una proseguita continuazione, trasportata sul palcoscenico teatrale di genere ammodernizzato, in una danza festaiola vivace ed allegra (si vedano le Figure 187 e 189).
E ad ogni modo, in una presentazione del tutto differente dalla composta ed aggraziata scena di ballo tipicamente cinquecentesca che si svolgeva solitamente all’epoca, in tutte le Corti europee [Figura 131].
 Figura 131 – Un esempio di danza rinascimentale curtense, nel quadro – attribuito a Hyeronimus Franken il Vecchio, pittore fiammingo di soggetti storici e di genere – riguardante il Ballo di Nozze del Duca di Joyeuse (il Visconte Anne – non inganni il nome femminile dato a quel nobiluomo – che era il favorito del Re di Francia Enrico III) realizzato nel 1581-82
Figura 131 – Un esempio di danza rinascimentale curtense, nel quadro – attribuito a Hyeronimus Franken il Vecchio, pittore fiammingo di soggetti storici e di genere – riguardante il Ballo di Nozze del Duca di Joyeuse (il Visconte Anne – non inganni il nome femminile dato a quel nobiluomo – che era il favorito del Re di Francia Enrico III) realizzato nel 1581-82
Inoltre, alla ipotesi – per la stampa britannica della Preparazione alla Mascherata – di una situazione da Commedia dell’Arte, non può sfuggire la sua estrema somiglianza di impostazione con la non poco successiva raffigurazione del 1589 di Hieronymus Francken il Vecchio, pittore fiammingo di soggetti storici e di genere, che ritrae La Compagnia dei Comici Gelosi (uno dei primi ed affermati insiemi professionali di teatranti cinquecenteschi, la cui denominazione deriva da come essi venivano allora giudicati: “Virtù, fama ed honor ne fèr gelosi”), con in evidenza la rinomata loro primadonna, Isabella Canali sposata Andreini (attiva tra gli attori gelosiani dal 1580), e considerata – già allora – “una delle interpreti più celebri del teatro d’Occidente” [Figura 132].
 Figura 132 – Una delle prime raffigurazioni delle Maschere della Commedia dell’Arte nel dipinto del 1582 anche questo del Franken, La Compagnia dei Comici Gelosi (uno degli iniziali ed affermati gruppi professionali di teatranti cinquecenteschi italiani) con in evidenza la rinomata loro primadonna, Isabella Canali sposata Andreini già allora considerata “una delle interpreti più celebri del teatro d’Occidente”
Figura 132 – Una delle prime raffigurazioni delle Maschere della Commedia dell’Arte nel dipinto del 1582 anche questo del Franken, La Compagnia dei Comici Gelosi (uno degli iniziali ed affermati gruppi professionali di teatranti cinquecenteschi italiani) con in evidenza la rinomata loro primadonna, Isabella Canali sposata Andreini già allora considerata “una delle interpreti più celebri del teatro d’Occidente”
Sulla – poco sopra – accennata scenografia dei Commedianti dell’Arte (che ancòra agli inizi del Seicento era riproposta con i tradizionali palchi alti sospesi su tralicci palificati, come rivela la incisione nel 1622 dell’impareggiabile grafico francese Jacques Callot, mostrante i tradizionali Balli di Sfessania della Campania italiana, considerata la forma più vecchia – cinquecentesca – della tarantella partenopea, assimilata e utilizzata poi dagli attori della Commedia dell’Arte come segmenti comici dei loro spettacoli) [Figure 133 e 134],

Figure 133 e 134 – Due delle straordinarie incisioni dei Balli di Sfessania (la forma più vecchia – cinquecentesca – della Tarantella partenopea, assimilata poi dagli attori della Commedia dell’Arte come porzione comica dei loro spettacoli) eseguite dall’impareggiabile grafico francese Jacques Callot, e disegnate dal 1621 al 1622: il solito tipico Palco Teatrale dei commedianti, con semplice pedana, su cui si esibivano gli attori [sopra], e un esempio della variegata quantità di maschere popolari e locali della tradizione partenopea [sotto]
 Figura 134
Figura 134
varie iconografie primo-seicentesche testimoniano che sostanzialmente i fondali di rappresentazione teatrale della Commedia dell’Arte – diversamente da quelli più compositi dell’istitutivo scenografismo rinascimentale allestiti in edifici stabili, di cui le finte prospettive sceniche palladiane sono un egregiamente rappresentativo esempio, epocale e disciplinare, nella loro maestosità di riproduzione architettonica – [Figura 135]
 Figura 135 – Il palcoscenico istituzionale fisso, con quinte architettoniche di sapore classico antico, ideato per l’esercizio stabile in interni di edifici al chiuso dall’architetto veneto Andrea Palladio, nel tipo esemplare del Teatro Olimpico a Vicenza, realizzato nel 1579/80-85 con una caratteristica falsa (illusionistica) prospettiva architettonica profonda (immagine del 2010 della rinomata fotografa tedesca Candida Höfer)
Figura 135 – Il palcoscenico istituzionale fisso, con quinte architettoniche di sapore classico antico, ideato per l’esercizio stabile in interni di edifici al chiuso dall’architetto veneto Andrea Palladio, nel tipo esemplare del Teatro Olimpico a Vicenza, realizzato nel 1579/80-85 con una caratteristica falsa (illusionistica) prospettiva architettonica profonda (immagine del 2010 della rinomata fotografa tedesca Candida Höfer)
erano tipologicamente più semplificati (come si vede particolarmente nella stampa del 1633-34 del grande incisore francese barocco, Abraham Bosse raffigurante gli Attori del Palazzo di Borgogna, a Parigi, che è stato il primo teatro pubblico indipendente, non di corte regale o signorile) e perfino schematizzati (quale si rivela lo scenario di fondo disegnato nel frontespizio del libretto del 1641 per la “Comedia Ridicola” Li Buffoni scritta dalla romana Margherita Costa, famosa autrice e cortigiana, nonché cantante e attrice) [Figure 136 e 137 (e 138)].

Figure 136 e 137 – Due esempi di scena teatrale fissa seicentesca: nella stampa dell’incisore francese, tipicamente barocco, Abraham Bosse del 1633-34 raffigurante gli Attori al Palazzo di Borgogna, il locale di Parigi che è stato il primo teatro pubblico indipendente, non di corte regale o signorile) [sopra], e nel Frontespizio del testo – considerato uno dei primi Canovacci scritti – Li Buffoni, “Comedia Ridicola” pubblicata nel 1641, e scritta dalla romana Margherita Costa, famosa autrice e cortigiana, nonché cantante e attrice (foto di Corrado Gavinelli del 2021) [sotto]
 Figura 137
Figura 137
Un genere di scenografia stereotipica continuata come tale anche dopo nelle più sofisticate manifestazioni teatrali europee, sul tipo prosecutivo delle tavole prospettiche alquanto rinomate dell’architetto e artista bolognese Sebastiano Serlio (autore di impareggiabili disegni di Tutte le Opere di Architettura et Perspectiva, un trattato teorico-pratico pubblicato in sette volumi dal 1537 al 1545) [Figura 138], anche se diversamente elaborate, ma restanti nel medesimo schema compositivo del Rinascimento (come si può rilevare dal noto quadro del pittore italiano Antonio Verrio del 1670, mostrante Le Italiche Delizie delle Umane Sorti, altrimenti conosciuto quale Buffoni Francesi e Italiani, in cui è anche ritratto, alla estrema sinistra, nientemeno che il grande drammaturgo Jean-Baptiste Poquelin, detto Molière, nella veste di attore) [Figura 139].
 Figura 138
Figura 138
Figure 138 e 139 – La permanenza compositiva della scenografia prospettica introdotta dal Palladio nei teatri stabili, in un disegno illustrativo dell’architetto bolognese Sebastiano Serlio (la Scena Comica del 1543-44, pubblicata nel Secondo Libro del suo Trattato di Architettura) [sopra], ed in un dipinto dell’artista italiano Antonio Verrio (Le Italiche Delizie delle Umane Sorti, noto anche come Burloni Francesi e Italiani, del 1670: nel quale, alla estrema sinistra, è raffigurato il grande drammaturgo Jean-Baptiste Poquelin detto Molière, quale attore nel ruolo di Arnolfo, o – per altri – di Sganarello) [sotto]. La scena serliesca, colloca, nel fondale prospettico, vecchie case di stile gotico, che erano tipiche dei quartieri artigiani e commerciali di genere quattrocentesco pre-rinascimentale. Al palcoscenico gli attori salgono da scalette antistanti (e non – come avverrà dopo – entrando dalle quinte), e recitano soltanto davanti alla scena, poiché arretrando mostrerebbero l’inganno ottico dell’effetto prospettico, che rivelerebbe la limitata altezza, fisicamente minore, degli edifici posteriori. Più tardi, l’accorgimento scenico tridimensionale visivamente dimensionato con altri accorgimenti spazial-geometrici, consentirà ai teatranti di entrare in scena dai fianchi del palco e di recitare nella profondità dell’ambiente scenico, definendo una percezione illusoriamente reale (nella cui composizione globale vengono eliminate anche le vecchie e antistanti scalette di proscenio, sostituite dall’invaso della orchestra)

Perché altrimenti i tradizionali Buffoni, che venivano chiamati anche Burloni, o Farsisti (dal francese Farseurs, attori di farsa) e anche quelli della compagnia teatrale della commediografa Costa sopra citata che li interpretavano sulle scene itineranti, recitavano in più scarni e dimessi ambienti spaziali, costituiti da palchi normali o banali stanze vuote [Figura 140].
 Figura 140 – Ignoto Veneto, Li Buffoni (o anche Maschere della Commedia dell’Arte Italiana), 1666
Figura 140 – Ignoto Veneto, Li Buffoni (o anche Maschere della Commedia dell’Arte Italiana), 1666
La Teatralità di Corte: Balletti e loro Maschere
Parallelamente ai teatranti indipendenti delle compagnie della commedia dell’arte, nelle Corti dei Re e dei Signori e Nobili seicenteschi, agivano attori di altro genere al servizio diretto dei loro munifici committenti. Che in particolare, nei sontuosi e regolati spettacoli musicali voluti e sostenuti dal Re Sole, Luigi XIV di Francia, per il proprio divertimento e il piacere dei suoi cortigiani esclusivamente, svilupparono il singolare Balletto-Teatro, una sorta di sintesi coreografica tra le discipline distinte di danza, recitazione, e sceneggiatura in costume (anche mascherata) inventata dall’italiano Giovanni Battista Lulli (francesizzato in Jean-Baptiste Lully), ballerino e compositore musicale barocco divenuto tra i musicisti più apprezzati di corte, che nel 1669, sottrattosi alle troppo intrusive imposizioni del suo monarca (il quale già da giovane, e non ancòra incoronato, partecipava personalmente alle recite per lui inscenate, ed aveva deciso quell’anno di lasciare il suo ruolo di attore), creò una sua autonoma rappresentazione poli-performativa, combinata con il drammaturgo Molière per l’esplicito scopo di maggiormente intrattenere, tra meraviglie e sorprese, e lazzi e frizzi, il sovrano e la sua Corte in roboanti spettacoli variegati [Figura 141].

Figura 141 – Illustrazione di autore francese conosciuto, convenzionalmente intitolata Musica del Re Sole, del 1670; che in realtà è la raffigurazione del singolare Balletto-Teatro per Luigi XIV, sorta di sintesi coreografica tra le discipline distinte di danza, recitazione, e sceneggiatura in costume (anche mascherata) inventata nel 1669 dall’italiano Giovanni Battista Lulli (francesizzato in Jean-Baptiste Lully), ballerino e compositore musicale barocco divenuto tra i musicisti più apprezzati di corte di Luigi XIV di Francia, ed attuata con il drammaturgo Molière
Alla Corte del Re Sole
Questa evoluzione coreografica era comunque provenuta dalla precedente, sebbene più rigida, tradizione del ballo curtense, e cortese, introdotto sempre dal sovrano francese Luigi XIV, che – dopo la sua eclatante interpretazione giovanile – a 14 anni – di Apollo dio del Sole nel Balletto della Notte del 1653 – [Figura 142] volle sigillare tale necessità di rimarcare
 Figura 142 – Illustrazione di Henry De Gissey (progettista coreografico francese divenuto poi Disegnatore della Camera del Re e del Gabinetto dei Progetti di Piacere Regali) per il bozzetto di costume disegnato da Giacomo Torelli (celebre artista italiano barocco al servizio della corte monarchica francese come scenografo e meccanico) a riguardo della figura di Apollo Dio del Sole nel Balletto della Notte del 1653, eclatante spettacolo teatrale scritto dal francese Isaac De Benserade (autore di teatro e poeta, divenuto poi Maestro di Ballo di Luigi XIV e in sèguito Sovrintendente dei Balletti del Re) e musicato dal sopra citato compositore Lully (che curò anche le coreografie). Il ruolo apollineo venne interpretato dallo stesso futuro Re Sole, allora 14enne
Figura 142 – Illustrazione di Henry De Gissey (progettista coreografico francese divenuto poi Disegnatore della Camera del Re e del Gabinetto dei Progetti di Piacere Regali) per il bozzetto di costume disegnato da Giacomo Torelli (celebre artista italiano barocco al servizio della corte monarchica francese come scenografo e meccanico) a riguardo della figura di Apollo Dio del Sole nel Balletto della Notte del 1653, eclatante spettacolo teatrale scritto dal francese Isaac De Benserade (autore di teatro e poeta, divenuto poi Maestro di Ballo di Luigi XIV e in sèguito Sovrintendente dei Balletti del Re) e musicato dal sopra citato compositore Lully (che curò anche le coreografie). Il ruolo apollineo venne interpretato dallo stesso futuro Re Sole, allora 14enne
quello spettacolarismo artistico sensazionale, istituendo nel 1661 la prestigiosa Accademia Regia della Danza; cui fece seguire, nel 1672, la Scuola Nazionale di Ballo. E fu proprio il primo Direttore di quella prestigiosa Académie, Louis Beauchamps (talentuoso danzatore e coreografo nato proprio a Versailles), a codificare le cinque posizioni dei piedi e l’uso dei passi arretranti, movimento ancòra oggi basilare nella danza classica moderna (ed a lasciare un metodo tutto suo di spartiti coreografici, graficamente tracciati con inconfondibile gusto barocco in immagini straordinarie suscitanti perfino forme umane ed oggetti; che il suo collega altrettanto francese Raoul Auger Feuillet, maestro di danza e coreografo, nel 1698-99 ha ridisegnato per pubblicarli nella vistosa Raccolta di Danze di Louis-Guillaume Pécour, Addetto ai Repertori di Piacere del Re e Compositore di Balletti Regali alla Accademia di Musica di Parigi, uscita nel 1700) [143 e 144].

Figure 143 e 144 – Due raffigurazioni degli eccezionali disegni coreografici concepiti dal danzatore e coreografo francese Louis Beauchamps (che fu il primo Direttore della prestigiosa Accademia Regia della Danza voluta dal Re Sole e istituita nel 1661), estroso inventore di nuovi balli e relativi movimenti (tra cui famosissimi sono la codificazione delle cinque posizioni dei piedi e l’uso dei passi arretranti, ancòra oggi basilari nella danza classica moderna): la prima [sopra], in una illustrazione del 1733-34 (la Passacaglia) del maestro calligrafo ed incisore inglese George Bickman il Vecchio (riportante un genere di passo danzato, la Passacaille, da Pasacalle in spagnolo, dalla nazione dove è stata inventata) su disegno di Kellom Tomlinson (Maestro di Danza Britannico e autore di un libro sulla Arte della Danza Spiegata del 1735); e la seconda [sotto] in una tavola di descrizione grafica dei suoi tracciati per spartiti coreografici (La Maritata), riprodotti dal suo collega altrettanto francese Raoul Auger Feuillet, maestro di danza e coreografo, e pubblicati nel 1700 nella vistosa Raccolta di Danze di Louis-Guillaume Pécour, l’Addetto ai Repertori di Piacere del Re e Compositore di Balletti Regali alla Accademia di Musica di Parigi. E’ importante notare come il titolo originario e completo di questo testo sia “Coreografia o l’Arte di De-Scrivere la Danza”, in cui l’accentuazione verso la scrittura rimarca un evidente riferimento al senso grafico della calligrafia con cui queste raffigurazioni musical-danzanti venivano leggiadramente presentate
 Figura 144
Figura 144
Nel considerevole contesto artistico-ingenoso, musical-danzante, formatosi alla corte del Re Sole, l’assemblaggio teatrale attuato dal Lully non soltanto è tipico della Corte di Francia, e del tutto unico e particolare, ma è stato da modello per lo sviluppo delle performazioni di ballo e musica in ogni altro reame assolutistico del rococò europeo; ed in pratica ha continuato – con maggiore magnificenza coreografica, adattandola alle condizioni epocali – quella analoga teatralità poli-composita affrontata un secolo prima da Leonardo da Vinci nel Ducato degli Sforza a Milano, e che il grande artista italiano ha riproposto (e trasferito) alla cultura francese nel suo periodo di finale soggiorno alla corte di Re Francesco I.
Il teatro di Leonardo da Vinci
Numerosi, e differenziati, nella immagine e negli anni, disegni e modelli teatrali sono stati realizzati dal genio vincesco nelle due sue più importanti porzioni della propria esistenza: quella media, della maturità, a Milano (nel 1482-94 per gli Sforza, e per altri casati nel 1494-96; nonché nel 1502-03, 1505-08, e 1511-12 per gli occupanti francesi, e altri committenti indipendenti) e quella finale, di persona anziana (e in Francia, dal 1516 al 1519).
Lavorando alla corte milanese, la sua bravura nella tecnica teatrale (di cui il proprio contemporaneo Paolo Giovio scrive, nella breve biografia sul Maestro fiorentino composta nel 1528, come quell’artista fosse “meraviglioso creatore e arbitro di ogni eleganza e soprattutto dei dilettevoli spettacoli teatrali”), si rivelò mirabolante ed eccelsa per gli incredibili illusionismi di scena ed i costumi coreografici.
A cominciare dall’esuberante ed indimenticabile apparato tecnico-scenico approntato per la Festa del Paradiso nel 1490 (che Leonardo aveva però già progettato due anni prima, dal 1488) su commissione di Ludovico il Moro in occasione della celebrazione delle nozze di Isabella d’Aragona con Gian Galeazzo Maria Sforza, nipote del duca milanese: il cui scalpore rappresentativo, davvero teatrale (poiché combinato in una congerie variegata di sorprendenti apparizioni sceniche e balli ammirevoli) venne elogiato ed immortalato dal suo compartecipe propositivo Bernardo Bellincioni, il poeta di corte autore dei dialoghi della recita, che nel proprio testo di Rime pubblicato nel 1493 (dove per altro il nome del Da Vinci viene ricordato a stampa per la prima volta) descrive l’evento quale “Rappresentazione chiamata Paradiso che fece fare il signor Ludovico in lode della Duchessa di Milano, e così chiamasi, perché vi era fabbricato con […] grande ingegno ed arte di Maestro Leonardo da Vinci fiorentino il Paradiso con tutte le sfere, pianeti che giravano” [Figure 145], in un maestoso effetto di luci nel buio della sala, che dovevano essere apparse davvero entusiasmanti per gli spettatori di corte [Figura 146].
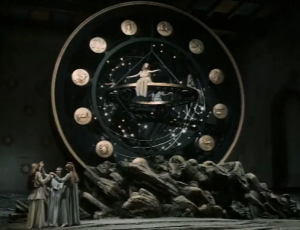 Figura 145
Figura 145
Figure 145 e 146 – La grandiosa ricostruzione della Festa del Paradiso attuata (per il filmato televisivo del 1971 prodotto dalla RAI su La vita di Leonardo da Vinci) da Renato Castellani, sceneggiatore e regista dell’opera [sopra], e la più recente (del 2019) riedizione (Le Nozze di Leonardo) al Teatro Verdi di Trieste [sotto], realizzata con evanescenti effetti visivi ottenuti con tecniche tridimensionali virtuali dallo scenografo udinese Federico Cautero
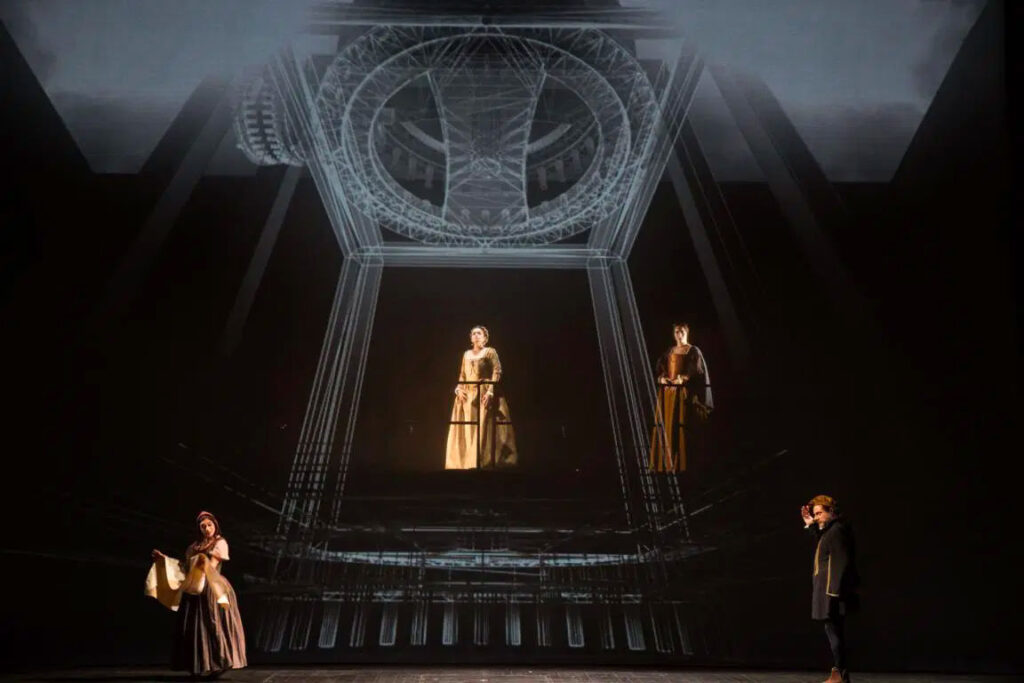
Una scenografia per quell’epoca impressionante, attuata con enorme impiego di macchinari semoventi, che assegnò al suo inventore una vasta fama di praticante teatrale complessivo ed eccelso [Figure 147 e 148], tanto da venire poi – ovvero sùbito – richiesto a lavorare per loro allestimenti scenografici da altri nobili casati milanesi.

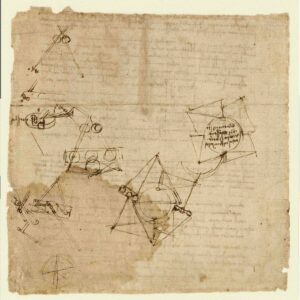
Figure 147 e 148 – Renucio Boscolo, Ricostruzione dell’Impianto Scenico del Paradiso, 2014 [a sinistra]; e Leonardo Da Vinci, Schizzi per l’Apparato Movimentatore dei Pianeti nella Festa del Paradiso, 1488 [a destra]. Il sistema di movimento scenografico per lo spettacolo nuziale sforzesco era composto da un mirabile apparecchio, con fondale semi-ovale (entro cui si svolgevano le azioni sceniche) ed un palco circolare, entrambi girevoli [sopra]: i cui dinamismi dipendevano da congegni meccanici a perno rotanti collegati ad aste snodate e ruote dentate. Nel disegno leonardesco si notano marchingegni articolati sul genere di bielle e manovelle reciprocamente vincolate per ottenere movimenti eterogenei in ogni direzione spaziale
La Festa-Rappresentazione viene allestita a Milano “nel Castello di Porta Giovia” (ovvero l’odierna fortezza sforzesca, allora dimora ducale) e nella cosiddetta Stanza Verde, l’ambiente che diventerà la famosa Sala delle Asse, affrescata nel soffitto sempre ad opera vinciana nel 1498, dimensionandola come una impressionante copertura vegetale assoluta, e quale già di per sé formidabile apparato di scenografismo naturalistico composto da pareti foderate di legno, dal cui rivestimento è derivato il nome del locale) [Figure 149 e 150].

Figure 149 e 150 – Un suggestivo confronto formale leonardesco tra le curvature composite del soffitto della Sala delle Asse (così chiamata per il rivestimento in listoni verticali di legno, sagomati ad altezze alternate come merli dentellati di fortificazione muraria) [sopra: rielaborazione tecnico-grafica di Corrado Gavinelli del 2021] realizzato da Leonardo Da Vinci nel Castello Sforzesco milanese nel 1498, e le linee di avvolgimento spaziale causato da proiettili sparati dalle artiglierie, disegnati dall’artista fiorentino nello Studio di Bombardamento con Traiettoria per la Caduta delle Bombe oltre le Mura di una Fortezza nel 1503-04 (documento contenuto nel Codice Atlantico) [sotto]
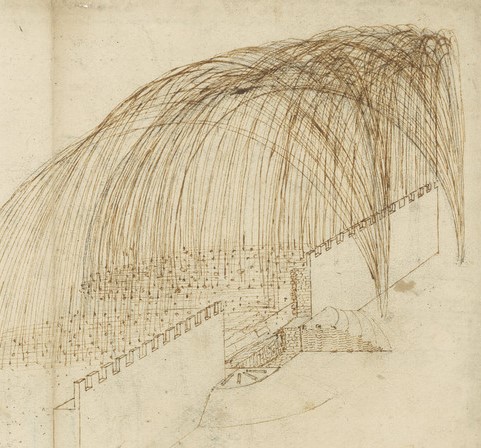 Figura 150
Figura 150
In questo apparato dallo svolgimento emblematico, in cui le nozze erano una metafora dei rivolgimenti dell’universo e delle delizie paradisiache piuttosto che una normale – per quanto pomposa – cerimonia come doveva addirsi ad un matrimonio così importante, sottostantemente Leonardo celebrò il tipico sposalizio profano (come si diceva allora: ovvero laico nella concezione odierna) delle nozze alchemiche, le cui raffigurazioni erano tuttavia di entità differente e in genere impostate su uno spaccato cavernicolo di una alta montagna, lungo la quale si sviluppavano a gradoni le specificità esoteriche del rito alchimistico [Figura 151]: una visione compositiva che, secondo alcuni interpreti della storiografia teatrale vinciana, più espressamente il suo autore utilizzò per il proprio teatro basandola su varie suggestioni storico-mitiche cabalistiche, riguardanti la più vasta ricerca della pietra filosofale (di cui tratterò tra poco).
 Figura 151 – Il riferimento iconografico più citato per l’aspetto leonardesco delle nozze alchemiche rinvenibile nella Festa del Paradiso, la Terza Tavola (“3. Mittel: Coniunction”, ovvero In mezzo sta la Congiunzione) del libro sulla Cabala (Specchio Di Arte E Natura) scritto in tedesco e pubblicato dallo stampatore tirolese (ma con bottega ad Augusta in Germania) Stephan Michelspacher nel 1615, raffigurante la Montagna Alchemica Ovvero Monte degli Adepti contenente la Pietra Filosofale, illustrata dall’incisore tedesco, anche egli augustano, Raphael Custos (o Custodis, come si firmava latinamente), che si rivela però di evidente incongruenza cronologica, essendo uscito dopo la performazione teatrale leonardiana
Figura 151 – Il riferimento iconografico più citato per l’aspetto leonardesco delle nozze alchemiche rinvenibile nella Festa del Paradiso, la Terza Tavola (“3. Mittel: Coniunction”, ovvero In mezzo sta la Congiunzione) del libro sulla Cabala (Specchio Di Arte E Natura) scritto in tedesco e pubblicato dallo stampatore tirolese (ma con bottega ad Augusta in Germania) Stephan Michelspacher nel 1615, raffigurante la Montagna Alchemica Ovvero Monte degli Adepti contenente la Pietra Filosofale, illustrata dall’incisore tedesco, anche egli augustano, Raphael Custos (o Custodis, come si firmava latinamente), che si rivela però di evidente incongruenza cronologica, essendo uscito dopo la performazione teatrale leonardiana
Ma che a mio parere – sebbene lontanamente plausibili come fatti di conoscenza gnoseologica del tempo cui Leonardo ha fatto certamente riferimento nelle sue investigazioni conoscitive – nella fattispecie di quella attinenza concettual-figurativa contengono un disguido di fondo (che specificherò più avanti), e che invece si possono maggiormente improntare agli interessi del Vinci per gli aspetti di carattere geologico e naturalistico (ampiamente descritti i certi suoi disegni e in varie pitture).
Perché, nella realtà dei fatti, l’eventuale modello di riferimento per il Paradiso leonardesco è stato indubbiamente la scenografia approntata dal famoso architetto fiorentino Filippo Brunelleschi (l’autore impareggiabile della cupola del Duomo di Firenze), che nel 1439 aveva allestito nel capoluogo toscano, in Piazza San Felice, un grandioso impianto illusionistico meccanico e girevole per lo spettacolo teatrale della Annunziata, con la scena mobile che si sviluppava in verticale, cui Leonardo aveva personalmente assistito nella sua replica del 1471 [Figura 152].
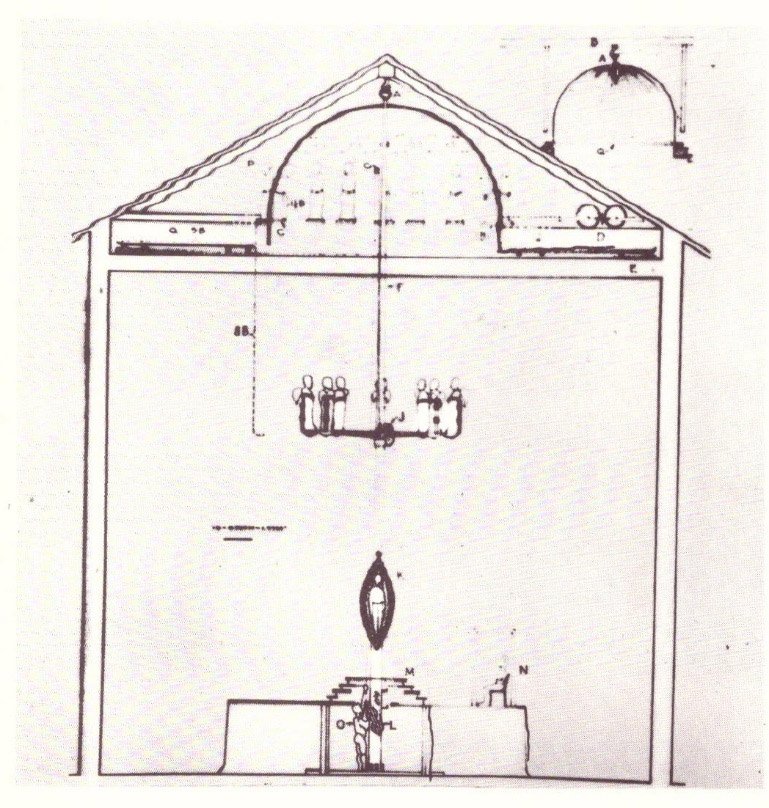 Figura 152 – Filippo Brunelleschi, Scenografia per la Annunziata, 1438. Lo spaccato trasversale del grandioso impianto scenico, disegnato dal famoso architetto fiorentino (autore impareggiabile della cupola del Duomo di Firenze), mostra l’apparato dell’allestimento realizzato nel 1439 per il capoluogo toscano in Piazza di San Felice con effetti illusionistici meccanici e girevoli, e una scena mobile che si sviluppava in verticale. E’ stato uno spettacolo poi ripetuto varie volte, e nella replica del 1471 Leonardo vi aveva personalmente assistito (traendone lo spunto per le sue opere più mirabili di teatro)
Figura 152 – Filippo Brunelleschi, Scenografia per la Annunziata, 1438. Lo spaccato trasversale del grandioso impianto scenico, disegnato dal famoso architetto fiorentino (autore impareggiabile della cupola del Duomo di Firenze), mostra l’apparato dell’allestimento realizzato nel 1439 per il capoluogo toscano in Piazza di San Felice con effetti illusionistici meccanici e girevoli, e una scena mobile che si sviluppava in verticale. E’ stato uno spettacolo poi ripetuto varie volte, e nella replica del 1471 Leonardo vi aveva personalmente assistito (traendone lo spunto per le sue opere più mirabili di teatro)
Eppure, la immagine più citata delle Nozze Alchemiche alla quale Leonardo avrebbe fatto riferimento, la Terza Tavola (“3. Mittel: Coniunction”, ovvero “In mezzo sta la Congiunzione”) del libro sulla Cabala scritto in tedesco, pubblicata dallo stampatore tirolese Stephan Michelspacher nel 1654 (illustrata dall’incisore tedesco, Raphael Custos – o Custodis, come si firmava latinamente – e raffigurante la Montagna Alchemica Ovvero Monte degli Adepti contenente la Pietra Filosofale [Figura 151], risulta non molto attinente alla tematica paradisiaca della rappresentazione fatta dall’artista fiorentino, e soprattutto si rivela anche cronologicamente impropria perché troppo in là negli anni (sebbene la prima edizione del libro risalga al 1615).
Tuttavia, in quella illustrazione si può notare un interessante riferimento iconografico, relativo alla coppia nella sala templare al centro della raffigurazione, alla fine della gradinata del processo alchemico, che mostra proprio l’assetto ieratico, frontale, delle nozze filosofali, in cui gli sposi sacri si scambiano l’emblema pentagonale dei rami della sorte, incrociati con il rametto verticale in mezzo portato dallo Spirito Santo [Figura 153].
 Figura 153 – Dettaglio del Tempio Coniugale nel disegno del Custos per la Cabala del Michelspacher (si veda la Figura 151), dove si compie il percorso petro-filosofale ed avvengono le nozze alchemiche, con i due coniugi petro-filosofali, Re e Regina, portanti i loro emblemi riconoscitivi (lo scettro e il rosario vegetale) che, incrociantisi nelle loro nozze esoteriche, comporranno il Rosacroce (si veda la Figura 154; e 155-156)
Figura 153 – Dettaglio del Tempio Coniugale nel disegno del Custos per la Cabala del Michelspacher (si veda la Figura 151), dove si compie il percorso petro-filosofale ed avvengono le nozze alchemiche, con i due coniugi petro-filosofali, Re e Regina, portanti i loro emblemi riconoscitivi (lo scettro e il rosario vegetale) che, incrociantisi nelle loro nozze esoteriche, comporranno il Rosacroce (si veda la Figura 154; e 155-156)

Figura 154 – Il Rosacroce delle Nozze Alchemiche raffigurato da un ignoto artista tedesco nel manoscritto del Rosario dei Filosofi pubblicato a Francorforte nel 1550
Un tipico segno della congiunzione alchimistica la cui immagine originaria deve venire fatta risalire a secoli prima. E se non ancòra (per motivi di date) a quelle altre magnifiche illustrazioni di autori sconosciuti, come la immagine (disegnata da un ignoto artista anch’esso tedesco, più sciolta anche nella naturale impostazione iconografica della rappresentazione esoterica presentata in costumi d’epoca) riguardante il Rosario dei Filosofi del 1550 (edizione di Francoforte) o la analoga miniatura del 1536 eseguita da Miniatore Tedesco Ignoto per il testo Splendor Solis (Lo Splendore del Sole) composto nel 1532-35 da Salomon Trismosin , il maestro alchemico di Paracelso, scritto in tedesco antico misto a latino maccheronico e descrivente la “trasmutazione in oro dai metalli di base” [Figure 154 e 155], almeno dobbiamo rapportarla alla figura della iniziale trascrizione amanuense quattrocentesca del Rosarium Philosophorum: manoscritto francese attribuito erroneamente all’autore primo-trecentesco Arnoldo di Villanova ma in realtà opera di un trascrittore anonimo del Quattrocento (risalibile ameno al 1473-75), poi copiata da plurimi esecutori tra il 1476 ed il 1484, e proveniente da un più antico modello figurale eseguito nel 1343-45 da ignoto – anche esso – autore nella prima sua stesura a mano (sottotitolata Preziosissimo Dono di Dio) [Figura 156].
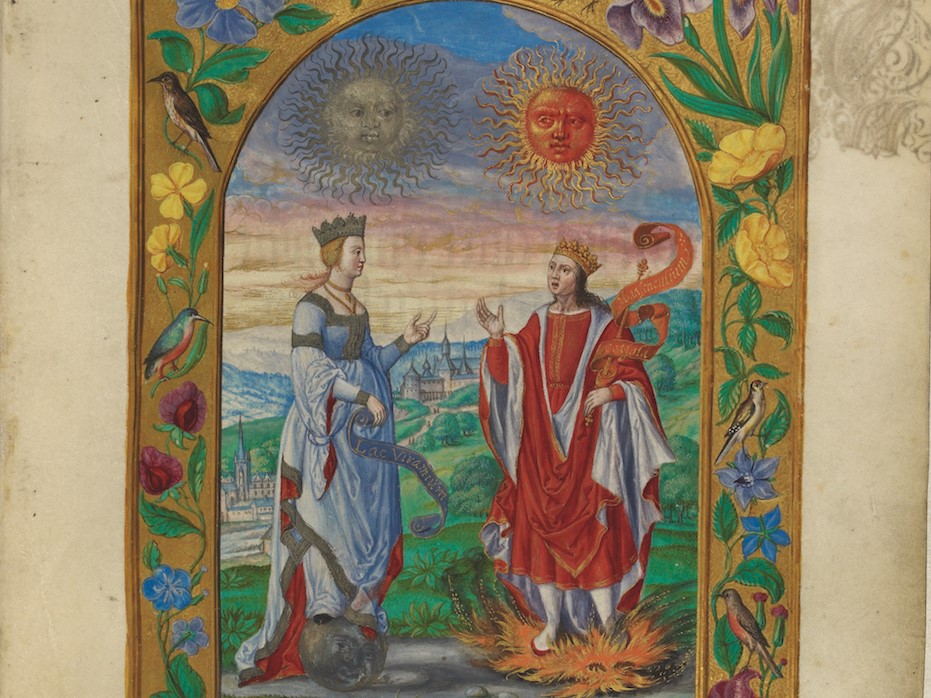
Figure 155-156 – Altre due immagini storiche del compimento finale del percorso petro-filosofale secondo il Rosario dei Filosofi: le nozze di Regina Lunare e Re Solare in una illustrazione cinquecentesca di Miniatore Tedesco Ignoto eseguita nel 1536 per il testo Splendore del Sole di Salomon Trismosin composto tra 1532 e 1535 [sopra], e lo loro originaria – trecentesca – rappresentazione ieratica di Alchimia di Re e Regina (disegnata nel 1343-45 da Artista Sconosciuto), nella quale viene riportato il connubio regale nel pentagramma floreale completato dalla discendente presenza del Santo Spirito, che sigilla sacralmente il congiungimento nuziale
 Figura 156
Figura 156
La scrittura della parte più consistente di tale codice, appartiene al copista italiano Giovanni Di Bartolomeo De Lachellis, di Fontaneto sul torrente Agogna in Piemonte, che duplicò il testo originario a Vienne in Francia dal 1476 al 1477, e le cui illustrazioni a colori furono eseguite in quegli stessi anni da un miniatore sconosciuto.
E questo manoscritto è stato uno dei trattati di alchimia più letti e variamente riprodotti, e per altro steso in una data alquanto vicina al periodo vinciano. Ed è proprio forse tale più vecchia riproduzione editoriale, in cui le illustrazioni originarie della congiunzione alchemica (nozze sacre) del Re Sole e della Regina Luna rimangono sempre omologamente riprodotte nelle proposizioni successive, che può essere al Vinci pervenuta, e utilizzata per la propria rielaborazione scenica nel Paradiso.
L’interesse esoterico per le esperienze e le teorie alchemiche che può avere contaminato la curiosità gnoseologica di Leonardo – il quale in genere era un indagatore più scientifico che misterico, ma indubbiamente interessato, come ha per certi aspetti mostrato nei suoi lavori, a questi argomenti di antica tradizione esoterico-conoscitiva – era comunque una curiosità caratteristica di quella misteriosa epoca di trapasso dal Medioevo al Rinascimento cui ha partecipato l’artista; e può essere comunque rapportato anche alla leggenda mitologica, non accertabile però documentariamente, secondo cui il Vinci appartenesse a quella congrega segreta e limitata della massoneria antica rappresentata dal Priorato di Sion, che perseguiva l’etica comportamentale dei Rosacroce (altra società segreta, misterica e segreta e però cristiana, tendente alla perfezione morale e spirituale), e di cui viene riportato che fosse addirittura il dodicesimo loro Grande Maestro, designato dal 1510 al 1519 (fino a quando morì: ed il cui predecessore, per la cronaca, sarebbe stato l’altrettanto grande artista fiorentino Sandro Botticelli).
Ma per concludere questa erratica, eppure sollecitante escursione letterario-iconografica nella misteriosità di Leonardo, non so se si debba considerare una strana coincidenza, ma il cosiddetto Nodo Leonardesco, tanto presente nei suoi lavori grafici e pittorici (talmente da venire considerato una sorta di marchio personale d’autore, o addirittura una firma figurata, poiché il suo stesso autore chiamava quei suoi ghirigori “vincoli”, dal suo cognome Vinci o, secondo altra interpretazione, quale esortazione per vincere) [Figure 157 e 158], e la cui figura circonvoluta campeggia nello stemma stesso della società rosacrocense [Figura 159].

Figure 157-159 – I nodi contorti (ma ordinatamente organizati) dei rami nel soffitto della Sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano, dipinto nel 1498 da Leonardo, nel Confronto tra i Restauri del 1901 e 1956 (in una fotografia di Cecilia Frosinini del 2014) [sopra] ed in un suo dettaglio ravvicinato [sotto] dopo il rinvenimento dell’affresco originale eseguito al laser dalla restauratrice vicentina Anna Brunetto nel 2017-19 (in una foto di Nodi Vinceschi di Corrado Gavinelli del 2020); ed il riferimento allo stemma araldico della setta segreto-esoterica del Priorato di Sion (foto di ignoto e senza data, ma almeno del 1959 ad imitazione di una presunta pergamena del 1099), di cui il Vinci fu il 12esimo Grande Maestro [in basso]
 Figura 158
Figura 158

Invece, ritornando alla carriera teatrale di Leonardo, sul genere della montagna alchemica sezionata, o della grotta scavata in un pendìo, il genio vinciano si impegnò espressamente, qualche anno dopo, nel 1506-07; quando altrettanto sensazionalmente progettò, rappresentandola nel 1508 sempre a Milano, con la sua solita magnificenza scenografica, la Fabula di Orfeo, che successivamente venne titolata Tragedia Orfeica: uno spettacolo scritto in volgare da Agnolo (Angelo) Ambrogini, detto Poliziano (dal nome latino del suo paese d’origine, Monte Pulciano), che era stato già esibito a Mantova nel 1480 alla corte dei Gonzaga.
La versione leonardesca dell’Orfeo – che apparteneva ad una concezione scenica chiamata “Teatro dell’Universo”, un sistema di scenografia studiato con criteri di trasportabilità e flessibilità componibili nell’intento di esibire spettacoli eterogenei in varie città del mondo, era stata approntata per il nobile francese Carlo Di Amboise Signore di Chaumont, allora Governatore di Milano per il Re di Francia Luigi XII; per il quale il Vinci aveva progettato, e fatto costruire, una villa suburbana fuori di Porta Orientale (la odierna zona oltre i caselli daziati ottocenteschi di Porta Venezia che va lungo il Corso Buenos Aires) con la esplicita – ed evidente, considerando la grandiosa sistemazione tipologica complessiva dei suoi spazi – destinazione a luogo di feste e ricevimenti, e quindi anche per spettacoli teatrali di godimento del proprietario e per l’allettamento dei suoi invitati.
Diversi schizzi e disegni tecnici per quella opera sono stati eseguiti da Leonardo, mostranti l’aspetto scenico esteriore del Monte degli Inferi, ricavato dalla immagine di una catena montuosa reale, e del criterio di sorprendente apertura della montagna per l’ingresso orfeico e del dio Plutone [Figure 160 e 161], ottenuto con apparati tecnici e meccanici neppure troppo elaborati all’apparenza grafica, ma di una incredibile ingegnosità articolatoria e perfetta efficacia funzionale (e spettacolarità sensazionale).
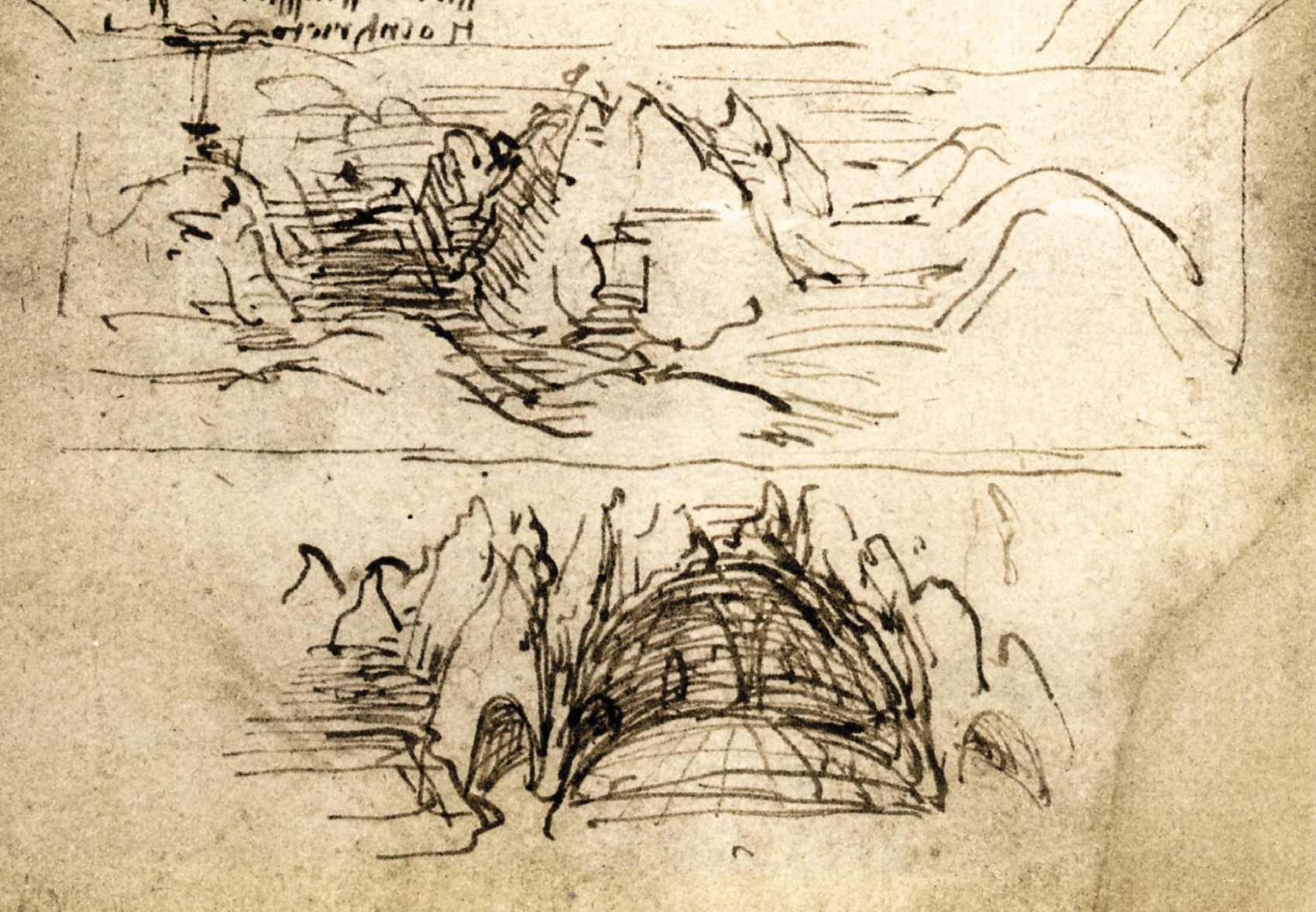
Figure 160 e 161 – Due particolari dei disegni di Studio per La Montagna che si Apre eseguiti da Leonardo nel 1506-07 per la Favola di Orfeo (rappresentata nel 1508 a Milano), evidenzianti (nel primo) le posizioni sceniche dell’apparato prima e dopo la sua apertura [sopra], nonché mostranti (nel secondo) la modalità di sostegno dell’attore sui pali emergenti dal palco [sotto] (si veda la Figura 162)

E per questa rappresentazione scenica esiste anche un disegno leonardesco alquanto significativo, che raffigura un palco mobile costituito da un traliccio ligneo rettangolare entro cui sono nascosti gli apparati di movimento, impostati su due sole aste verticali facenti da perni per aprire meccanicamente in due parti la montagna [Figure 162 e 163 (da confrontare con la Figura 160)].
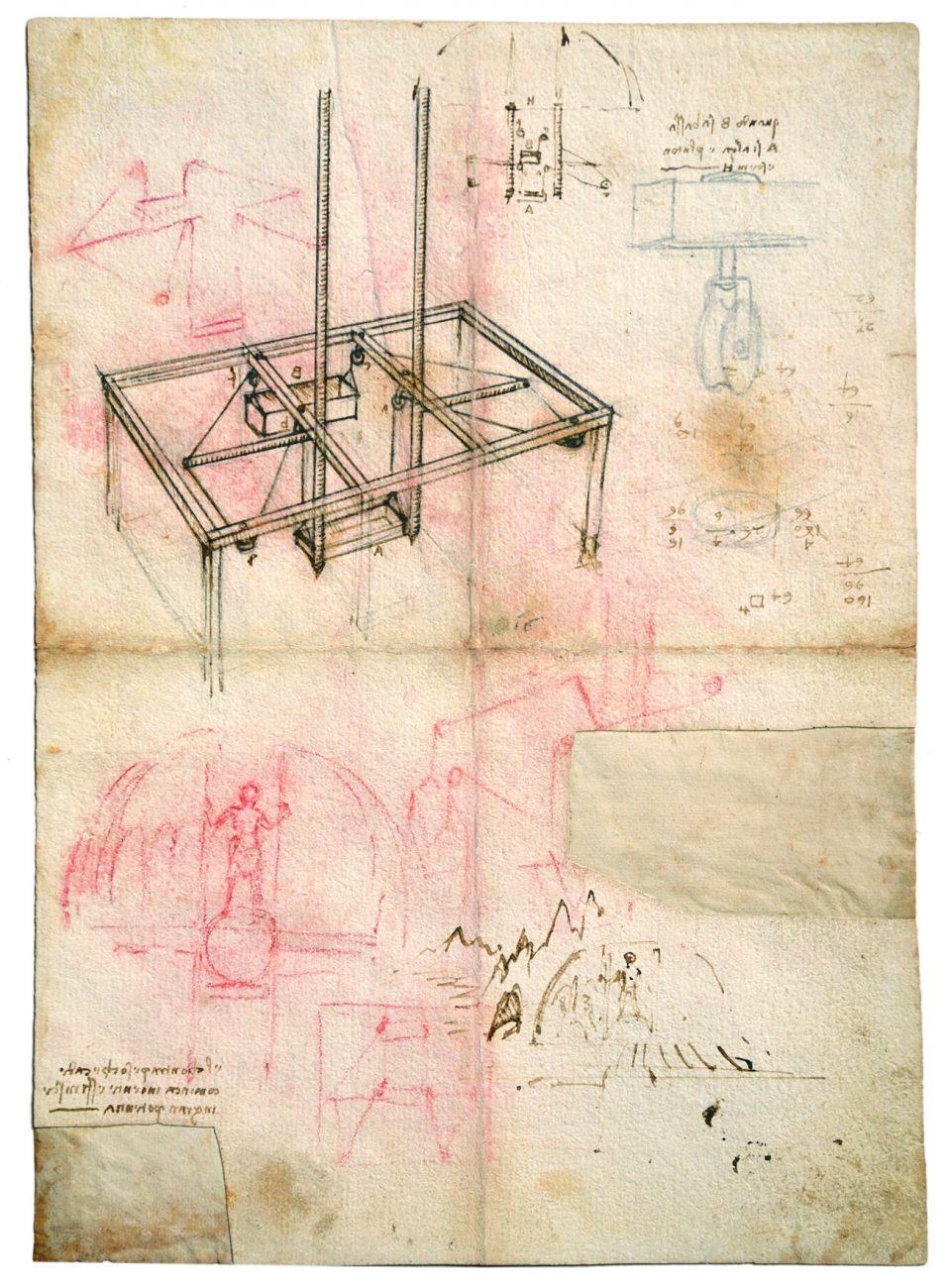 Figura 162 – Il meccanismo di salita del Palco-Scenico per la Comparsa di Plutone, disegnato nel 1507 dal Da Vinci (e intitolato Foglio del Teatro dal suo scopritore, nel 1999, Carlo Pedretti, storico dell’arte italiano ed uno dei maggiori esperti leonardeschi). Sulla pagina del disegno, nelle scritte riportate dall’artista, in alto a destra si legge che “Quando B s’abassa A si alza e Pluton esce in H”, mentre in basso a sinistra viene commentato il movimento come “El contrappeso che cade comincia in niente e finisce in grande potenzia”
Figura 162 – Il meccanismo di salita del Palco-Scenico per la Comparsa di Plutone, disegnato nel 1507 dal Da Vinci (e intitolato Foglio del Teatro dal suo scopritore, nel 1999, Carlo Pedretti, storico dell’arte italiano ed uno dei maggiori esperti leonardeschi). Sulla pagina del disegno, nelle scritte riportate dall’artista, in alto a destra si legge che “Quando B s’abassa A si alza e Pluton esce in H”, mentre in basso a sinistra viene commentato il movimento come “El contrappeso che cade comincia in niente e finisce in grande potenzia”
 Figura 163
Figura 163
Figura 163 – Elaboratore Ignoto, Scenografia Teatrale per Orfeo, 2011. Modello ricostruttivo tridimensionalmente virtuale eseguito dalla Università delle Arti di Londra, indicante il completo sistema di azione e movimento delle parti dinamiche della Montagna orfeico/plutonico-infernale
Precipuamente poi, in questa scenografia orfeica si possono rilevare gli aspetti più evidenti del riferimento degli interessi vinciani per la composizione rocciosa orografica e la geografia alpina, che si esprimono per genericità formale come per precisione topografica, e decidono anche il loro allontanamento da suggestioni alchemiche precedentemente perseguite, nonché il distaccante abbondono della ultima restante soggezione verso lavori già realizzati da altri autori.
Con accortezze proprie che dimostrano una decisa diversità operativa, tendente alla innovazione autonoma nelle proprie scenografie.
Nel dettaglio del disegno di Studio per la Montagna che si Apre del 1506-07 [Figura 164], si può riscontrare soltanto una diretta relazione formale con le miniature di alture montane (Monte De Cortexiani e Monte Delli Ebrei) disegnate nel 1479 dal toscano Leonardo Di Giovanni Tolosani Da Colle, Cancelliere di Firenze (e apparse anche sul manoscritto Aurora_Nascente di Nicola_D’Antonio_Degli_Agli, scrittore e alchimista fiorentino nonché vescovo e teologo, compilato tra il 1478 ed il 1480) riportante una scena delle manifestazioni festive allestite a Pesaro nel 1475 in “Ordine de le noze de lo Illustrissimo Signor Misir Costantio Sfortia de Aragonia: et de la illustrissima Madona Camilia de Aragonia sua consorte” [Figure 165-166]: una incredibilmente sontuosa rappresentazione effettuata durante il pranzo nuziale dei due nobili signori nel castello cittadino, e che per inciso è stata un evento precursore dell’Orfeo vincesco (e qualcuno dice anche del Paradiso).

Figure 164-166 – Confronto formale tra il dettaglio della Montagna che si Apre (nella sua condizione ancòra chiusa e con la sola porta di ingresso accennata nel proprio perimetro rettangolare) disegnata dal Da Vinci (si veda la Figura 160) per il suo Orfeo [sopra], e le due miniature (il Monte degli Ebrei e il Monte dei Cortigiani) [sotto e in basso] eseguite nel 1479 da Leonardo Di Giovanni Tolosani Da Colle per il manoscritto descrivente le Nozze di Costanzo Sforza, Signore di Gradara e di Pesaro, con Camilla Marzano di Aragona, nipote del Re Ferdinando di Napoli, compilato tra il 1478 ed il 1480 da Nicola D’Antonio Degli Agli, scrittore e alchimista), mostranti due scene delle manifestazioni festive allestite nel 1475 nel castello pesarese per lo sfarzoso matrimonio sforzesco sopra indicato (la ultima immagine – alla Figura 166 – è stata graficamente risistemata da Corrado Gavinelli nel 2021).
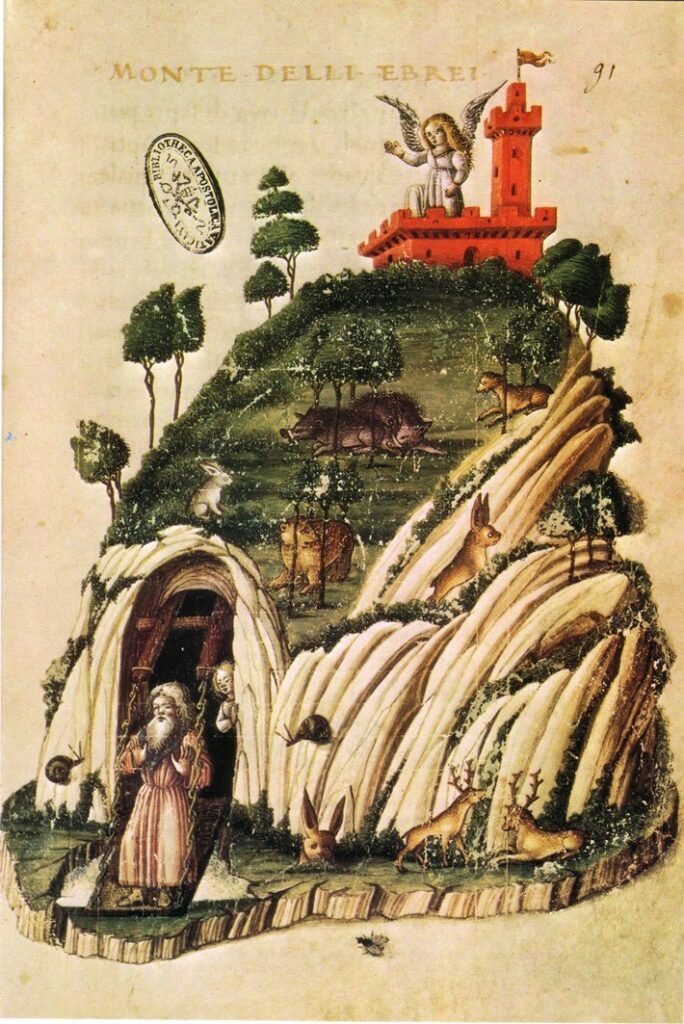

Ma del portentoso ideatore, ed esecutore, di tali stupefacenti e ricche scenografie, anche alimentari, purtroppo non è pervenuto il nome, nonostante le più che precise ed abbondanti descrizioni di quell’evento riportate nel manoscritto citato del 1480 dall’attento “umanista pesarese del sec. XV” (come lo ha definito Alfredo Saviotti, storico italiano di adesione crociana, sugli ‘Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa’ nel 1888) Pandolfo Collenuccio, storico e poeta nonché diplomatico presso varie corti italiane, e soprattutto a Pesaro, dove fu giurista e Vicario Generale dello sposo, Costanzo I Sforza. Tuttavia, gli esperti della Biblioteca Apostolica Vaticana di Roma (riprendendo una vecchia recensione dei Codici Urbinati Latini del 1912 compilata dal sacerdote Cosimo Stornajolo, storico romano vaticanista) conducono quelle scenografie (comprese i disegni di macchinari moventi e perfino le preparazioni figurali delle straordinarie confezioni cibarie elargite spettacolarmente ai commensali, ad analoghe raffigurazioni di “Baccio Baldini, artista fiorentino”, esecutore coevo di “una serie di incisioni, note come Pianeti Finiguerra […] sequenza di personificazioni planetarie, su carri trainati da animali allegorici”, con zodiaco al centro e figurazioni mitologiche intorno, simili alle raffigurazioni costanzo-sforzesche.
Tornando comunque alla interpretazione performativa leonardesca dell’Orfeo, nella realtà fisica del suo riferimento natulalistico alla orografia terrestre, questo monte della tradizione bilico-alchemica si trasla molto più concretamente alla suggestione per le alture e le rocce paesaggistiche che fin dal suo primo importante lavoro pittorico eseguito nella bottega verrocchiana, l’artista fiorentino ha mostrato, e che rimanda ad altre proprie opere specifiche. Rinviando cioè, soprattutto, alla Annunciazione ritrovata nel Convento di San Bartolomeo di Monteoliveto vicino a Firenze, realizzata nel 1473-74, sul cui sfondo si vede con chiarezza un analogo ammasso montuoso, racchiuso prospetticamente tra due cipressi, nella cui conformazione in lontananza, e tridimensionale, la critica vede la iniziale affermazione esplicita dello sfumato tipicamente vinciano) [Figure 167 e 168].

Figure 167 e 168 – Leonardo Da Vinci, La Annunciazione, 1473-74: nel dettaglio del massiccio roccioso retrostante (foto di Corrado Gavinelli del 2021) [sopra] e nella immagine intera del dipinto [sotto]. La soffusione atmosferica del paesaggio in lontananza viene ritenuta, dalla critica leonardesca, una espressa anticipazione dello sfumato prospettico vinciano, impiegato dall’artista fiorentino anche nella plasmazione ombrata delle sue figure umane

Una visione montana isolata che appare addirittura nella tela del primo dipinto in assoluto del Da Vinci, Il Battesimo di Cristo cominciato nel 1472 dal proprio maestro, il fiorentino Verrocchio (Andrea Di Michele Di Francesco Di Cione) e concluso nel 1478, in cui l’allievo effettua l’angelo di sinistra, probabilmente proprio nel 1473 [Figure 169 e 170]. Che quello sfondo montagnoso sia poi anch’esso eseguito per mano vinciana (come ormai la critica d’arte tende a ritenere probabile), o realizzato dal titolare del dipinto, ha scarsa importanza nei confronti del fatto che quell’insieme paesaggistico indichi già un riferimento solido e incondizionato verso la natura oggettiva che il giovane apprendista impiegherà in altri propri lavori coevi e successivi.

Figure 169 e 170 – Andrea Di Michele Di Francesco Di Cione detto Verrocchio, con Leonardo Da Vinci, Il Battesimo di Cristo, 1472-78: nella raffigurazione totale del quadro [sopra] e nel Dettaglio delle Alture Montane sullo sfondo (foto di Corrado Gavinelli del 2021) [sotto]. La critica d’arte più recente considera anche il paesaggio – come l’Angelo di Sinistra nel dipinto – opera attuata dal giovane Vinci, allora apprendista nella bottega verrocchiese

E comunque queste presenze fisiche spiegano un interesse paesistico piuttosto perseguito da parte del giovane Leonardo, di invenzioni formali desunte da reali osservazioni, di cui è testimonianza inequivocabile il suo disegno a sanguigna dei monti lombardi delle Grigne (Le Prealpi di Lecco), disegnati nel 1486-88, di cui un didascalico fotomontaggio pubblicato nel 2020 dal lecchese escursionista alpino Angelo Recalcati fornisce un convincente confronto di veridica identità visiva [Figure 171 e 172].
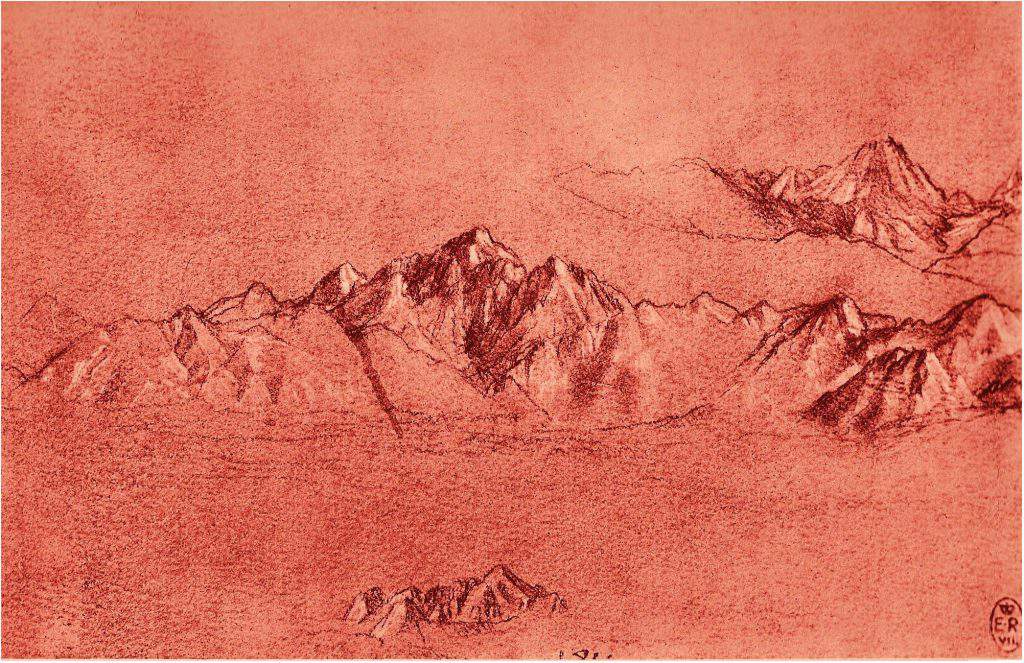
Figure 171 e 172 – La catena montuosa delle Grigne lombarde: nella immagine leonardiana (Le Prealpi di Lecco, 1486-88) [sopra] e nel fotomontaggio comparativo (Le Prealpi Lombarde nel disegno di Leonardo e nella corografia reale) pubblicato nel 2020 dall’escursionista e storico alpino lecchese, Angelo Recalcati [sotto]

Proseguendo sul teatralismo vincesco, altro allestimento scenico leonardesco conosciuto è quello progettato, ed eseguito, per la Comedia di Danae di Baldassare Taccone, Cancelliere di Ludovico il Moro, disegnato nel 1495 e presentato a Milano l’anno dopo nella Casa di Giovanni Francesco Sanseverino, fratello del condottiero Galeazzo, che era grande amico di Leonardo, [Figura 173].
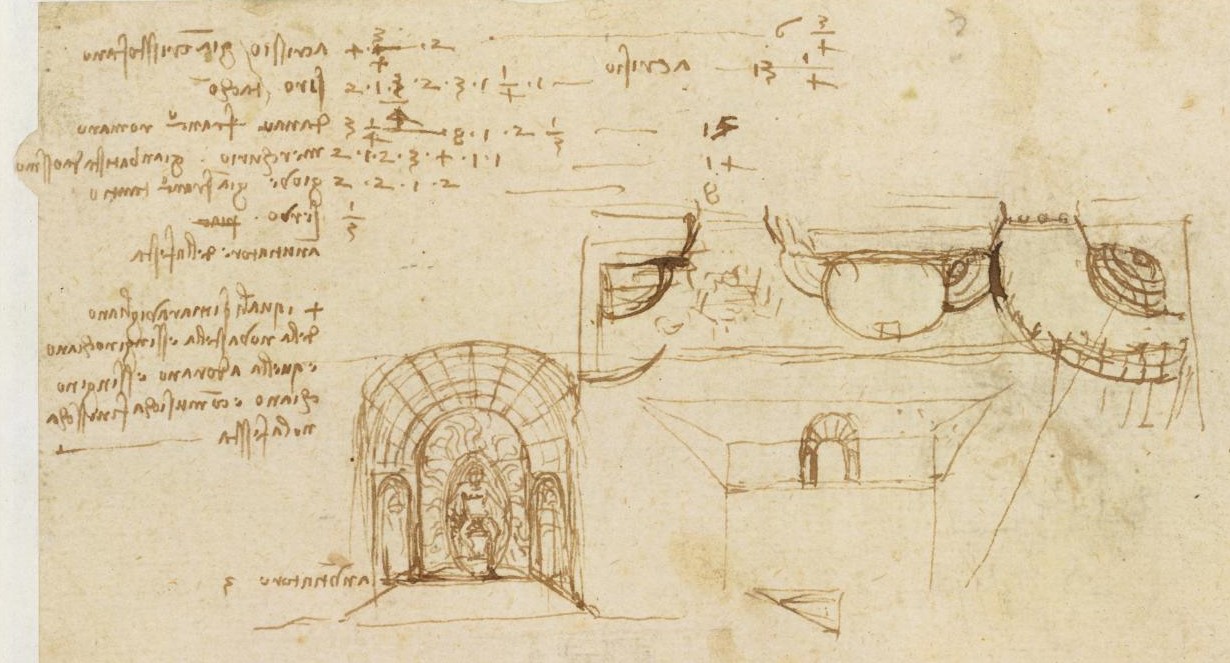 Figura 173 – Lo Schizzo per la Scenografia di Danae tracciato da Leonardo Da Vinci nel 1495, per la rappresentazione milanese della opera teatrale di Baldassare Taccone, Cancelliere di Ludovico il Moro, eseguita l’anno dopo nella Casa di Giovanni Francesco Sanseverino, fratello dell’amico vinciano, il condottiero Galeazzo
Figura 173 – Lo Schizzo per la Scenografia di Danae tracciato da Leonardo Da Vinci nel 1495, per la rappresentazione milanese della opera teatrale di Baldassare Taccone, Cancelliere di Ludovico il Moro, eseguita l’anno dopo nella Casa di Giovanni Francesco Sanseverino, fratello dell’amico vinciano, il condottiero Galeazzo
E’ questo un lavoro appartenente a quegli impegni teatrali che il Vinci ricevette dopo il 1490, in sèguito al favorevole risultato delle sforzesche nozze paradisiache, e che ebbe altri importanti committenze, non ducali ma da parte di diversi casati milanesi; tra cui hanno ricevuto ampio risalto i costumi elaborati e anche bizzarri per la Giostra cavalleresca tenuta davanti al Castello milanese degli Sforza nel 1491 (con disegni però dell’anno precedente) in riferimento ai festeggiamenti del sopra accennato Galeazzo Sanseverino, capitano di armata del Moro e suo genero, tra i cui vestiari appaiono anche vistose maschere grottesche (le prime, in pratica, e datate, di un autentico repertorio mascherato leonardiano) [Figura 174].
 Figura 174 – Leonardo Da Vinci, Maschere, 1490; disegnate – si ritiene – per la Giostra di combattimento equestre tenuta a Milano davanti al Castello Sforzesco in onore del Galeazzo Sanseverino sopra ricordato
Figura 174 – Leonardo Da Vinci, Maschere, 1490; disegnate – si ritiene – per la Giostra di combattimento equestre tenuta a Milano davanti al Castello Sforzesco in onore del Galeazzo Sanseverino sopra ricordato
Invece, una altra, e più effettiva, mascheratura di foggia umana, coprente il volto del suo portatore, è stata poi, nel 1495 (Ritaglio di Maschera, ma non è noto per quale genere di spettacolo) disegnata dal Vinci in una forma particolare, poiché sormontata da uno stretto piumaggio svolazzante, che risulta analogo ad un altro importante addobbo successivo – quello dello Studio per un Costume del 1511-12 – il cui cappello guarnito in alto ha un aspetto del tutto simile [Figure 175 e 176 (e 177)].
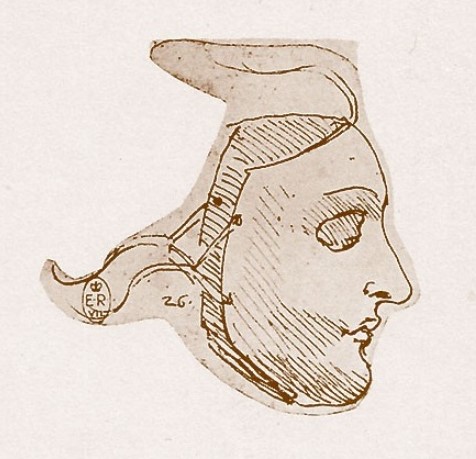 Figura 175
Figura 175
Figura 175-177 – La prima autentica Maschera Facciale, finora conosciuta, disegnata dal Da Vinci nel 1495 (e ritagliata, da un foglio più grande, da Francesco Melzi – l’allievo e collaboratore vinciano più fedele, e per questo diventato erede ed esecutore testamentario di tutti i lavori del suo maestro, che conservò e sistemò per parecchio tempo) per uno spettacolo non noto (ma probabilmente per i travestimenti di spettacolo della Danae tacconiana) [sopra]; mostrante, nel suo piumaggio superiore, una curiosa analogia con il successivo (del 1511-12) copricapo [sopra, a destra] osservabile nell’altrettanto leonardesco Studio per Costume Teatrale, eseguito in pieno periodo di vita francese dell’artista, ad Amboise, alla corte del Re Francesco I [sotto]
 Figura 176
Figura 176
Questo disegno di vestimento teatrale è ritenuto (secondo le indicazioni degli esperti del Centro per le Arti Sunny di Londra) riferibile al periodo del secondo soggiorno a Milano di Leonardo al servizio degli occupanti francesi, e specificamente per il governatore francese – già ricordato – Charles Di Amboise; ma, per la sua già tarda datazione milanese, è ascrivibile anche ad abbigliamenti cerimoniali – o scenici – successivi, appartenenti al repertorio della permanenza vinciana alla corte francese di Francesco I: poiché esso “raffigura un costume come viene descritto nelle celebrazioni del 1518” (forse quelle in onore della entrata del Re nella sua reggia di Amboise), festeggiamenti “bene documentati” in cui “gli abbigliamenti mostrano una stretta somiglianza con i disegni di Leonardo” precedenti, “suggerendo che tali studi erano per costumi indossati in quella circostanza” [Figura 177].

Invece la Maschera Ritagliata, molto probabilmente scontornata da un foglio disegnato più grande, ad opera di Giovanni Francesco Melzi – l’allievo e collaboratore vinciano prediletto e più fedele, che ereditò e curò tutti i materiali leonardeschi, ordinandoli e conservandoli – è verosimilmente un elemento scenico dei travestimenti di spettacolo della Danae tacconiana sopra citata: alquanto importante al proposito, poiché attesta che le performazioni teatrali leonardiane prevedevano anche espresse mascherature facciali a carattere non soltanto mostruoso o allegorico bensì pure normale.
Le ultime eclatanti rappresentazioni teatrali di Leonardo si svolsero quindi in Francia, nella residenza estiva del re ad Amboise, presso la quale l’artista era andato a dimorare – nel Castello di Clos Lucé, più familiarmente detto Palazzo di Cloux, nella valle della Loira – chiamato dal sovrano Francesco I, che lo onorò del titolo di “primo pittore, architetto e ingegnere del re”.
E qua il Vinci esibisce, sempre nel 1518, una replica, riadattata ma non meno splendida, del Paradiso sforzesco, come attesta una lettera di Galeazzo Visconti, Ambasciatore di Venezia: “il re offrì un banchetto in una festa straordinaria […]. La corte era ricoperta de panni del colore celeste, con le stelle di oro ad similitudine del cielo, poi gli erano li principali pianeti, el sole a un lato et la luna per opposito […], Marte Iove et Saturno erano messi al loro ordine con li 12 segni zodiacali […]. V’erano 400 candelabri a due bracci, tanto luminosi che la notte parea scacciata”.
Non può sfuggire, in tutto questo apparato misto di teatralità e mascherate anche divergenti o moderatamente sceniche, l’embrione di quello splendore curtense al cospetto di Luigi XIV, del quale ho trattato prima. E nelle cui performazioni iniziali, lo stesso futuro monarca agì come attore e ballerino, nei panni apollinei e con un vistoso coprifaccia solare dorato, recitando nel 1653 – nella propria Reggia di Versailles – la grandiosa opera della vittoria della luce sulla notte (che peraltro durava tredici ore! Cominciando alle 6 del pomeriggio) [Figura 142]: come espressivamente ce lo ha mostrato, nella oggettivistica interpretazione dell’attore francese Emil Tarding, il regista altrettanto francese Gérard Corbiau nel suo film del 2000 Il Re danza, traendone la ispirazione proprio dalla biografia sul Lully – “il musico del sole”, in tutti i sensi – che nel 1992 ha scritta il musicologo e storico della barocchità europea, l’ugualmente francese Philippe Beaussant [Figura 178, e 179].

Figure 178 e 179 – Il Re Danza! La immagine dorata del giovane – e futuro – sovrano di Francia Luigi XIV, mentre balla, quattordicenne, nel famoso spettacolo teatrale del Balletto della Notte del 1653, vestito da (e per la prima volta chiamato così) Re Sole [si veda la Figura 142]: in una immagine del film francese Le Roi Danse del 2000 (diretto dal regista Gérard Corbiau) interpretato dall’attore Emil Tarding [sopra]; e nella sorprendente somiglianza dell’aspetto fisico del personaggio filmico con la storica immagine del Sole Invitto scolpita nel 150-160 sulla Stele di Giove Dolicheno (della città di Dolico, in Anatolia) e conservata alle Terme di Diocleziano in Roma [sotto]

Dalla antica Roma al Medioevo
Le feste, e gli spettacoli in maschera, nel loro genere precipuamente di massa, si ritrovano, nella cultura occidentale, già – embrionalmente – dalla antichità, e si sviluppano particolarmente con il Medioevo, quando il crollo dell’impero romano, e l’avvento del Cristianesimo, cambiano notevolmente vita e cultura, ed abitudini inveterate, delle popolazioni europee.
I Saturnalia
Sono le Feste Saturnali – rituali romano-antichi in onore del Dio Saturno, protettore ìnfero della fertilità agraria, e per commemorazione ancestrale della mitica Età dell’Oro – a fondamentalmente istituire la tradizione poi divenuta carnevalesca della libera sfrenatezza gioiosa, che consentiva la più ampia espressione dei comportamenti personali, aperta e svincolata da ogni consueto condizionamento etico-sociale, approfittando di quella circostanza annuale particolarissima (da cui è venuto il famoso motto latino “semel in anno licet insanire” – una sentenza attribuita al filosofo, drammaturgo, e politico romano Lucio Anneo Seneca, espressa nel 58-59 dopo Cristo – ovvero diventare folli almeno una volta all’anno).
Svolti liberamente e senza inbizioni dai tempi antichi (e poi – per evitarne gli eccessi imprevedibili e nocivi – regolamentate nel 217 avanti Cristo), questi festeggiamenti rituali celebravano il rinnovamento annuale portato dal solstizio d’inverno, che avveniva dal 17 al 23 Dicembre, e annunciavano la rinascita della natura, preludendo al conclusivo giorno di apparizione del Sole Invincibile al 25 del mese (in epoca cristiana corrispondente alla nascita di Gesù, ed all’Avvento). E tali cerimonie festose, oltre alle solite ritualità di cortei e danze in pubblico, si svolgevano in una sorta di permissiva liceità privata a sovvertire l’ordine convenzionale delle cose e delle azioni, in uno sfrenato repertorio di divertimenti smodati e di esagerazioni cibarie [Figura 180].
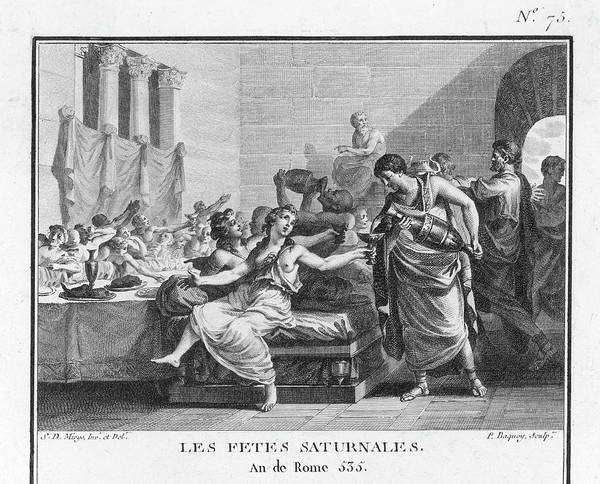
Figura 180 – Le Feste Saturnali. Nell’Anno 535 di Roma (ovvero nel 217 avanti Cristo), incisione del 1799 del grafico francese Pierre-Charles Baquoy, ripresa da un disegno dell’artista e stampatore Silvestre David Mirys, preparata per le illustrazioni del libro didattico, voluto dalla Rivoluzione Francese, sulla “Storia della Repubblica Romana” (e pubblicizzato quale esemplare “opera eseguita per ordine del governo da servire alla istruzione pubblica”, con speciali figure stampate “su carta velina”)
Gli eventi collettivi avvenivano senza particolari costumi o travestimenti, e soltanto il loro Principe designato portava una casacca rossa (colore delle divinità del sottosuolo) ed una maschera sul viso (forse retaggio arcaico dei primitivi abbigliamenti speciali, distintivi del loro rango ritico-scenico, indossati dagli sciamani), dalla foggia molto elaborata e sgargiante (che venne ripresa poi, in una versione orrenda perché emblema demoniaco della empietà pagana, nel Medioevo) [Figura 181; e 183, 187, e 189].
 Figura 181 – William Arthur Simpson, Saturnalia Romani, 1843. Il corteo spontaneo dei festanti per le vie cittadine, rappresentato dal grafico neo-classico e pittore realistico scozzese divenuto noto per i suoi dipinti di guerra ottocenteschi (di cui fu un diretto testimone dal vero)
Figura 181 – William Arthur Simpson, Saturnalia Romani, 1843. Il corteo spontaneo dei festanti per le vie cittadine, rappresentato dal grafico neo-classico e pittore realistico scozzese divenuto noto per i suoi dipinti di guerra ottocenteschi (di cui fu un diretto testimone dal vero)
Durante questi rituali che nella sostanza conducevano i partecipanti a comportarsi da pazzi (e diventare folli), si formavano quelle tipiche sfilate per le strade cittadine, in genere spontaneamente improvvisate, con varie persone compiaciute di attuare azioni esagitate e incontrollate, che nei secoli successivi divennero autentiche feste della follia (di cui sono piene le miniatura medievali, ed è popolarmente notoria la scena del mostro di Notre Dame de Paris descritto nel romanzo famoso dello scrittore francese Victor Hugo pubblicato nel 1831, il gobbo e storpio Quasimodo, campanaro della cattedrale, coinvolto nella sarabanda dei festeggiatori folleggianti ed incoronato loro re dalla folla tripudiante) [Figura 182].
 Figura 182 – Quasimodo, il campanaro storpio della Cattedrale parigina protagonista del noto romanzo storico dello scrittore francese Victor Hugo Nostra Signora di Parigi uscito nel 1831, in una vignetta tratta dal film del 1996 Il Gobbo di Notre Dame (prodotto dalla Corporazione Disney e disegnato dalla cartonista statunitense Kathy Zielinski) che lo mostra nel ruolo di Re dei Folli. E’ da notare che la immagine della corona è tuttavia riferita – per accentuare il carattere buffo e ironico della situazione – ad un berretto da giullare, più che ad un vero copricapo regale
Figura 182 – Quasimodo, il campanaro storpio della Cattedrale parigina protagonista del noto romanzo storico dello scrittore francese Victor Hugo Nostra Signora di Parigi uscito nel 1831, in una vignetta tratta dal film del 1996 Il Gobbo di Notre Dame (prodotto dalla Corporazione Disney e disegnato dalla cartonista statunitense Kathy Zielinski) che lo mostra nel ruolo di Re dei Folli. E’ da notare che la immagine della corona è tuttavia riferita – per accentuare il carattere buffo e ironico della situazione – ad un berretto da giullare, più che ad un vero copricapo regale
Mascherate mostruose ed animalesche nel Medioevo
Si sa, dalle numerose iconografie d’epoca, che le feste medievali – quando non possedevano particolari contenuti morali come le danze cerimoniali delle corti di re e nobili – a volte erano svolte con mascheramenti, scherzosi e divertenti (ma anche orripilante e spaventoso), che facevano parte di un apparato ufficioso e signorile, come si ritrova illustrato nei manoscritti miniati e quindi riferiti ad un certo rango sociale altolocato.
Esistono comunque testimonianze scritte dell’uso popolare di maschere durante particolari eventi, tra cui il Carnevale, che condussero – per motivi di liceità e sicurezza – a venire proibite. Ed esemplare di tale fatto è il divieto ad indossare la maschera non soltanto poiché nascondeva il viso di chi la indossava, ma anche in quanto quell’occultamento facciale poteva proteggere un possibile ambiguo ed esecrabile comportamento, usato soprattutto dai malviventi, per evitare di venire riconosciuti nell’adempimento dei loro delitti. E comunque, a titolo precauzionale, le città italiane decretarono speciali leggi sull’impiego concesso delle maschere fino dal 1268, particolarmente in riferimento alla pratica dispettosa di lanciare uova – fresche o marce – durante certe ricorrenze pubbliche (come per la medesima usanza, non necessariamente mascherata, ancòra oggi viene perseguita in periodo carnevalesco).
E a proposito delle tipiche performazioni mascherali di medio Evo, una interessante illustrazione di esecutore ignoto disegnata per un messale del 1175-77 di altrettanto amanuense sconosciuto, raffigurante la netta opposizione tra esibizioni permese e proibite, in una chiara divergenza tra danze “celesti” e “infernali”, mostra come la unica esibizione con travestimenti e comportamenti smodati era quella delle feste sfrenate più popolari, guidate da un partecipante in costume mostruoso [Figura 183], risalenti alla figura saturnale del prìncipe di antica tradizione guidante le sfilate, divenuta in tale caso orribile e demonica non soltanto perché rappresentezione di una divinizzazione pagana, ma anche in quanto mostruoso riferimento ad un personaggio di sua provenienza (Saturno) che, come Crono, era stato un crudelissimo, ed orripilante, divoratore dei propri figli.
 Figura 183 – Autore Ignoto, Danze Celesti e Danze Infernali, 1156-57; raffigurazione etica incisa per un Messale di Oxford
Figura 183 – Autore Ignoto, Danze Celesti e Danze Infernali, 1156-57; raffigurazione etica incisa per un Messale di Oxford
E che come tale, questo conducente di cortei e balli vietati, è rimasto, con aspetto selvaggio ed invasato, fino all’Ottocento, nella magnifica, per quanto orrenda, figura di Saturno che Mangia un Figlio dipinta nel 1821-23 dallo spagnolo Francisco De Goya [Figure 184 e 185]; o – sempre ancòra nel Medioevo – riproposto in un dettaglio della splendida miniatura del 1318-20 eseguita dall’artista e libraio “Geufroi de S. Ligier” (attualizzato in Geoffroy De Saint-Léger, località nella diocesi di Bayeux in Normandia presso Caen, nota per il famoso arazzo della conquista normanna della Inghilterra dopo la Battaglia di Hastings) per il Romanzo di Fauvel, poema satirico francese scritto tra il 1317 ed il 1324 dal notaio Gervais Du Bus, Cancelliere della corte reale di Filippo IV il Bello, in una sorta di sfilata festaiola di più complessa composizione, con numerose maschere allegoriche, anche simpatiche e sornione, di forma animale (tuttavia, queste, sempre di referenzialità demoniaca) o anche caratterialmente umane (e però ugualmente di espressioni deformi e spiacevoli, anche esse di tradizionale rifacimento ad immagini infero-infernali) [Figura 186, e 187].
 Figura 184
Figura 184  Figura 185
Figura 185
Figure 184 e 185 – La raffigurazione saturnale pagana, rievocata nel messale oxfordiano millecentesco precedentemente citato come immagine mostruosa e informe, nel particolare del danzatore infernale [a sinistra], e la sua prosecuzione orrida più recente, nella rappresentazione dell’artista spagnolo Francesco De Goya (dettaglio del dipinto Saturno che Mangia un Figlio del 1821-23) [a destra]
 Figura 186
Figura 186
Figure 186 e 187 – Un eccezionale documento figurativo medievale illustrante costumi e maschere durante una festa danzante del più svariato genere, miniate dall’artista francese Geoffroy De Saint-Léger per il cosiddetto Romanzo di Fauvel, poema satirico trecentesco scritto tra il 1317 ed il 1324 dal notaio Gervais Du Bus, Cancelliere della corte reale di Filippo IV il Bello: il particolare di un danzante dal volto mostruoso, di derivazione saturnal-infernale [sopra] e l’intera Pagina del Manoscritto con la sarabanda dei festanti [sotto]

Questa ultima eccezionale raffigurazione, tipicamente rappresentante la cosiddetta e storica Festa dei Folli (o degli Incolpevoli: una sfilata in maschera che si svolgeva ogni anno dal 26 al 28 Dicembre, nei tre giorni rispettivamente dedicati a Santo Stefano, San Giovanni, ed agli Innocenti, con riferimento alla famosa strage biblica), riporta la immagine della manifestazione laico-religiosa che veniva organizzata dal clero in Europa, ma particolarmente in molte città della Francia settentrionale a partire dal Millecento (in una consuetudine cerimoniale durata fino al Seicento) derivandola dai Saturnali (ed infatti effettuata nel medesimo periodo invernale della festività romana).
Tali complesse, e articolate, manifestazioni sono però collegate anche alle tradizioni folcloristiche più popolari (e gli storici vedono in tali parodie liturgiche una delle origini – medievali e successive – del teatro) che costituiscono anche un curioso repertorio di mascherature di variegatezza strana ed elaborata, da cui sono state create altre icone pubbliche di impiego successivo: come il medico con la testa di asino protettiva dei contagi (che nel Seicento diventerà la copertura corvina per il medico della Peste) [Figura 187, e 43], tra cui sorprendentemente una stravagante figura di danzante svestito dalla cintola in giù, incredibilmente simile alla effigie caricaturale del futuro Leonardo da Vinci! [Figure 188].
 Figura 188
Figura 188
Figura 188 – Un altro Particolare con Danzante nel corteo festante del romanzo fauveliano, di uno stravagante personaggio caricaturale seminudo (senza brache), dalla sconcertante somiglianza con la fisionomia facciale – e per il berretto anche – di Leonardo da Vinci!
I festaioli danzanti e suonanti, indossanti maschere burlone oppure spaventevoli, si ritrovano poi in altre versioni più gentili e cortesi (curtensi), come si può vedere nell’esemplificante, trecentesco, Manoscritto Bodleiano di Oxford, la cui illustrazione di corteo-ballo in costume mascherato (per nozze o altro accadimento, e non proprio una “Danza per il Carnevale” come altrimenti la immagine viene ritenuta da alcuni commentatori), dipinta dal miniatore fiammingo Iehan (o Jean) De Grise tra il 1339 e il 1344 per la parte riguardante il Romanzo di Alessandro (Magno, il condottiero macedone, rielaborato nella tradizione medievale) nella speciale compilazione di un ignoto amanuense di Tournai, in Belgio, effettuata dal 1335 al 1338, riporta una versione addolcita e pacata della più scatenata Festa dei Folli [Figura 189].

Figura 189 – Una ulteriore sfilata di Ballo in Costume e Maschere (considerata genericamente Danze per il Carnevale, e però più probabilmente riferibile ad una festa curtense) raffigurata – dal miniatore fiammingo Iehan De Grise nel 1339-44 – per il Romanzo di Alessandro (il Grande condottiero macedone) scritto da un ignoto Amanuense Belga, di Tournai, tra il 1335 ed il 1338
Il cui agitato ricordo mascherario (e manifestazione rituale) scomparirà più avanti, in epoca rinascimentale, per lasciare posto a maggiormente pensate, e disegnate, maschere regolari, per le attività teatrali itineranti e stabili, o per utilizzazioni personali private, di cui in precedenza abbiamo visto storia e sviluppo.
Ed una esemplare conferma di questo abbandono delle dissennatezze medievali mascherate, proviene proprio dall’autore che più, e prima, di tutti, interessandosi alle varie e stravaganti esternazioni della follia intellettiva, ha descritto appieno i fenomeni e le espressioni della esasperazione sfrenata, anche demenziale, nei comportamenti e nelle fisionomie umane, a proposito del Carnevale: si tratta del già ricordato Peter Bruegel il Vecchio, il cui disegno del 1559, inciso a stampa dal fiammingo Pieter Van Der Heyden, riportante la La Festa dei Folli ancòra in pieno Cinquecento (con una però generale – meno che per una sola persona in basso a destra presso il campo di bocce – mancanza di maschere) [Figure 190 e 191],

Figure 190 e 191 – Pieter Van Der Heyden, La Festa dei Folli (incisione da un disegno di Pieter Bruegel il Vecchio) 1559. E’ la rappresentazione rinascimentale, prospetticamente realistica, della tradizionale sfilata, caotica e popolare, di continuità medievale [sopra], liberamente agìta in abiti consueti e senza più maschere (una presenza di mascheratura si ritrova, infatti, unicamente in un solo partecipante, in basso a destra, vicino alla competizione con le sfere, arcaico gioco delle bocce) [sotto]
 Figura 191
Figura 191
rappresenta quella nuova versione festaiola di sola ebbrezza collettiva, anche incontenuta e pazzoide, che nello stesso anno lo stesso artista olandese evidenzierà nel sopra citato suo quadro affollatissimo descrivente La Lotta tra Carnevale e Quaresima, precedentemente commentato [Figure 73 e 74].
Maschere più tipiche del Teatro dell’Arte italiano (e altro)
La neutrale anonimità del mascheramento comune [Figure 192 e 193], è invece estremamente marcata nelle figure storiche e tradizionali della Commedia dell’Arte italiana, dalle cui singole identità caratteriali delle personalità che rappresentano, sono state fissati i più specifici aspetti dei personaggi mascherati avvicendatisi sulla scena (goldoniana e no).
Figure 192 e 193 – Maschere di foggia varia: nella settecentesca stampa Tre Personaggi Veneziani del 1786 (foto di Corrado Gavinelli del 2021) dei già citati grafico Nicolò Cavalli (incisore) e pittore Maggiotto (disegnatore del soggetto) [sopra]; ed in un acquarello ottocentesco con Costumi di Carnevale, eseguito nel 1817 dal pittore e incisore francese Antoine Jean Baptiste Thomas, specializzato in soggetti di genere popolaresco e paesaggi caratteristici [sotto]. Nella prima immagine, con personaggi di sicura appartenenza carnevalesca (nella baùtta a sinistra), di derivazione teatrale (nell’Arlecchino a destra), e di duplice rappresentatività mista (nella giovane con la moretta in mano e a volto scoperto, che potrebbe essere una donna veneta qualunque oppure la figura di Colombina). E nella altra illustrazione, con più eterogenea commistione mascheraria, anche improvvisata negli abbigliamenti

Figure 192 e 193 – Maschere di foggia varia: nella settecentesca stampa Tre Maschere Veneziane (intitolato anche, ma meno propriamente, Arlecchino e Colombina) del 1786 (foto di Corrado Gavinelli del 2021) dei già citati grafico Nicolò Cavalli (incisore) e pittore Maggiotto (disegnatore del soggetto) [sopra]; ed in un acquarello ottocentesco con Costumi di Carnevale, eseguito nel 1817 dal pittore e incisore francese Antoine Jean Baptiste Thomas, specializzato in soggetti di genere popolaresco e paesaggi caratteristici [sotto]. Nella prima immagine, con personaggi di sicura appartenenza carnevalesca (nella baùtta a sinistra), di derivazione teatrale (nell’Arlecchino a destra), e di duplice rappresentatività mista (nella giovane con la moretta in mano e a volto scoperto, che potrebbe essere – indifferentemente – una donna veneta qualunque oppure la figura di Colombina, come rivela l’uccello nel cestino). E nella altra illustrazione, con più eterogenea commistione mascheraria, anche improvvisata negli abbigliamenti
 Figura 193
Figura 193
La mappatura dell’Italia delle Maschere teatrali, o rappresentativamente regionali, riporta 33 fondamentali figure mascherate in tutto, variamente distribuite per aree regionali e città [Figura 194].

Figura 194 – Autore Ignoto (delle Edizioni Pianeta Bambini), Cartina dell’Italia con le Maschere di Carnevale, 2018. Nella didascalia di questa mappa si può riscontrare il fatto che i personaggi della Commedia dell’Arte rientrano tutti (anche quelli più tipici della Commedia dell’Arte e del teatro in genere) ormai nell’insieme eterogeneo dei costumi carnevaleschi indifferentemente
Ma di tutto il repertorio mascheraio alcuni soggetti sono rimasti, nella tradizione storica come nella preferenza popolare, con più alta notorietà o riferimento. E tra queste, ricorrendo sempre alle raffigurazioni della iconografia artistica d’epoca, Pulcinella (dall’inconfondibile copricapo cilindrico, alto e afflosciato, e la casacca molle con bottoni grandi, sul genere del Pierrot francese, di cui riferirò tra poco) risulta uno di maggiormente rinomati personaggi ricordati: soprattutto per le molte, ed impareggiabili, riproposizioni dategli da Giovanni Domenico Tiepolo nel Settecento; un artista che, oltre ad altri riporti di genere festaiolo e non teatrale (quali si vedono nei suoi Minuetti in costume, danzati tra la folla delle feste veneziane) [Figura 195, e 196], ha ritratto fattezze e comportamenti pulcinelliani in

Figure 195 e 196 – La passione mascheraria di Giovanni Domenico Tiepolo, grande pittore veneziano figlio del più rinomato Giambattista, nonché nipote dell’altro importante artista veneto Francesco Guardi: nella variegata tematica del Minuetto, dipinto nel 1756 (i cui ballerini sono Pantalone e Colombina) [sopra] e nella propria più perseguita preferenza per la figura pulcinellesca, nel Trionfo di Pulcinella del 1764-66 [sotto]

tantissime pitture e disegni. Tra i quali spiccano le raffigurazioni affrescate – dal 1759 al 1797 – nella Villa appartenente alla famiglia Tiepolo, a Zianigo di Mirano, zona periferica alla città di Venezia sopra Marghera (ora però conservate nella capitale veneta a Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano) [Figure 197 e 198], e dunque il centinaio di disegni della raccolta dei Divertimenti per li Regazzi, elaborati in 13 anni, dal 1791 al 1804 (fino alla morte del pittore) [Figura 199].

Figure 197-199 – Tre diverse raffigurazioni giandomenico-tiepolesche riguardanti le vicende pulcinelliane: il famosissimo affresco della Altalena dei Pulcinella, eseguito nel 1793-97 sul soffitto della Villa Tiepolo a Zianigo di Mirano nell’entroterra veneziano soprra Marghera (ora conservato al Museo di Ca’ Rezzonico a Venezia) [sopra], l’altrettanto zianighese Pulcinella Innammorato dipinto nel 1797 [sotto], e quindi uno (Pulcinella Corteggiatore, del 1796-97) dei 104 disegni dei Divertimenti per Ragazzi effettuati dal 1791 al 1804 [in basso]


Altro particolare personaggio della commedia mascherata, che è diventato importante per il suo insolito ricoprimento (composto non da una celata facciale applicata alviso bensì da un occultamento da camerino teatrale che gli rivestiva il volto con uno spesso strato di cerone bianco) oltrechè per il carattere triste e rassegnato, è il cosiddetto Pierrot francese, in origine traduzione di Pierotto (comparsa italiana creata verso la fine del Cinquecento da Giovanni Pellesini, attore della Compagnia dei Gelosi che interpretava il simile personaggio di Pedrolino, variazione del servo veneziano Zanni, anch’esso indossante un abito bianco, ampio e floscio). La sua adozione in Francia proviene proprio dal fatto che i teatranti gelosiani, operanti a Parigi dal 1574 al 1577 alla corte del Re Enrico III, lo lasciarono quale figura locale – poiché il territorio francese è privo di originarie maschere proprie – divenendo inevitabilmente emblema nazionale del teatro.
E della sua delicata e patetica figura è stato particolarmente il pittore francese Jean-Antoine Watteau l’interprete maggiore, particolarmente con il suo fantomatico Pierrot altrimenti detto Gilles del 1718-19 [Figura 200] (riproposto due anni dopo – 1720 – al centro del gruppo di Commedianti Italiani ammassati sul palcoscenico, e diversamente ritratto anteriormente – nel 1714-15 – nel dipinto Amoreggiamento nel Teatro Italiano) [Figure 201 e 202];

Figura 200-202 – La più famosa maschera d’oltralpe, dipinta dal suo maggiore interprete artistico, il pittore francese Jean-Antoine Watteau: nella connotativa (e maggiormente nota) immagine di Pierrot altrimenti detto Gilles del 1718-19 [sopra] e nelle altre due, diversificate dal modello frontale statico, più significanti sue raffigurazioni (al centro del quadro dei Commedianti Italiani del 1720, e nella composizione Amoreggiamento nel Teatro Italiano del 1714-15) [sotto e in basso]. La patetica figura pierrotina, divenuta tipicamente francese – non avendo la Francia originarie maschere tradizionali – è provenuta da un personaggio italiano di cui è una traduzione nominale (Pierotto), creato in Italia verso la fine del Cinquecento ad opera di Giovanni Pellesini, attore della Compagnia dei Gelosi, che interpretava il simile personaggio di Pedrolino (variazione del servo veneziano Zanni) indossante anch’esso un abito bianco, ampio e floscio


e tuttavia celebrato anche da altri suoi connazionali a lui contemporanei, come Philippe Mercier e Nicolas Lancret (il quale ultimo lo ha riportato ad una presenza umana più che soltanto da palcoscenico), che lo hanno immortalato in quella sua estranea, e del tutto contraria alla frivola ilarità degli attori comici, disposizione scenica, rivestente invece il ruolo opposto di tragico rappresentante della mestizia umana [Figure 203 e 204-205].

Figure 203-205 – Il Pierrot francese in altre opere di suoi artisti connazionali: Philippe Mercier (Pierrot e Arlecchino Difendono l’Onore della Figlia del Dottore, del 1707) [sopra] e Nicolas Lancret (Gli Attori della Commedia Italiana, del 1734, nonchè Pierrot in Piedi, in un Paesaggio, del 1728) [sotto e in basso]
 Figura 204
Figura 204

Eppure egli è stato non soltanto considerato nella propria epoca di più estesa rinomanza, ma esaltato perfino dai maggiori artisti moderni, da (in ordine cronologico) Honoré Dumier (nel 1870-73), James Ensor (1892), Pablo Picasso (dal 1901 ed in altre successivi lavori), Pierre August Renoir (nel 1901-02), August Macke (1912), Amedeo Modigliani (1915), Juan Gris (1921), e George Roualt (nel 1936 e 1937-38).
Non di meno, tra tutte le importanti maschere più note non si può concludere questa succintissimo elenco selezionante senza ricordare la maschera famosa più grande al mondo: il frizzante Arlecchino, italiano non veneto ma lombardo (di Bergamo), il servo più intrigante e inaffidabile di ogni padrone, inizialmente giunto sulle scene con un costume bucherellato e a brandelli da povero straccione quale in effetti egli era per la sua infima appartenenza popolare (e con tale aspetto egli è stato rappresentato, agli esordi della sua figura iconograficamente apparsa nel 1584, nella cosiddetta Raccolta Fossardiana, repertorio storico di incisioni e altre stampe e manifesti e fogli vari riguardanti la Commedia commissionata da Luigi XIV al suo copista e musico di corte François Fossard, iniziata nel 1680 e conclusa nel 1690) [Figura 206], che nel tempo si è trasformato nella tipica divisa a scacchiera romboidale multicolore che tutti oggi riconoscono con dimestichezza [Figura 207-210].
 Figura 206 – Una tavola del 1584 (Arlecchino. Zanni Cornetto. Il Signor Pantalone) di autore sconosciuto, appartenente alla cosiddetta Raccolta Fossard (così chiamata dal nome del suo compilatore), eterogenea collezione assortita di stampe e manifesti di scene teatrali storiche, in cui appare – per la prima volta – la figura arlecchinesca originaria, dal vestito sbrindellato e straccione. E’ nel 1662, dopo che l’anno prima il Re Sole di Francia aveva istituito la Accademia Regale della Danza, che sempre lo stesso monarca francese affidò a François Fossard, suonatore di violino e Musico della Cappella Regale, l’incarico di raccogliere le composizioni musicali dei balletti eseguiti a corte dopo il regno di Enrico III (risalenti dunque al 1590), per collocarli – ed il suo compilatore iniziò dal 1666 – nella Biblioteca Regia, fondata – dal predecessore regnante Carlo V – a Parigi. Nel 1683, affiancato da André Danican Philidor detto l’Anziano (suonatore di diversi strumenti musicali e Musico della Grande Scuderia), dovettero occuparsi – come Guardiani della Biblioteca di Sua Maestà – di un ufficio, appositamente istituito, di copisti provetti (calligrafi e disegnatori) chiamati per riunire diverse opere musicali, da documenti di ogni genere. Nel 1690 la raccolta aveva ricomposto le vecchie danze eseguite durante la giovinezza del re Sole, insieme ai balletti ed alle coreografie musicali di Lully (il cui pezzo più antico – un manoscritto di raggruppamento di balli – rimonta al 1681)
Figura 206 – Una tavola del 1584 (Arlecchino. Zanni Cornetto. Il Signor Pantalone) di autore sconosciuto, appartenente alla cosiddetta Raccolta Fossard (così chiamata dal nome del suo compilatore), eterogenea collezione assortita di stampe e manifesti di scene teatrali storiche, in cui appare – per la prima volta – la figura arlecchinesca originaria, dal vestito sbrindellato e straccione. E’ nel 1662, dopo che l’anno prima il Re Sole di Francia aveva istituito la Accademia Regale della Danza, che sempre lo stesso monarca francese affidò a François Fossard, suonatore di violino e Musico della Cappella Regale, l’incarico di raccogliere le composizioni musicali dei balletti eseguiti a corte dopo il regno di Enrico III (risalenti dunque al 1590), per collocarli – ed il suo compilatore iniziò dal 1666 – nella Biblioteca Regia, fondata – dal predecessore regnante Carlo V – a Parigi. Nel 1683, affiancato da André Danican Philidor detto l’Anziano (suonatore di diversi strumenti musicali e Musico della Grande Scuderia), dovettero occuparsi – come Guardiani della Biblioteca di Sua Maestà – di un ufficio, appositamente istituito, di copisti provetti (calligrafi e disegnatori) chiamati per riunire diverse opere musicali, da documenti di ogni genere. Nel 1690 la raccolta aveva ricomposto le vecchie danze eseguite durante la giovinezza del re Sole, insieme ai balletti ed alle coreografie musicali di Lully (il cui pezzo più antico – un manoscritto di raggruppamento di balli – rimonta al 1681)
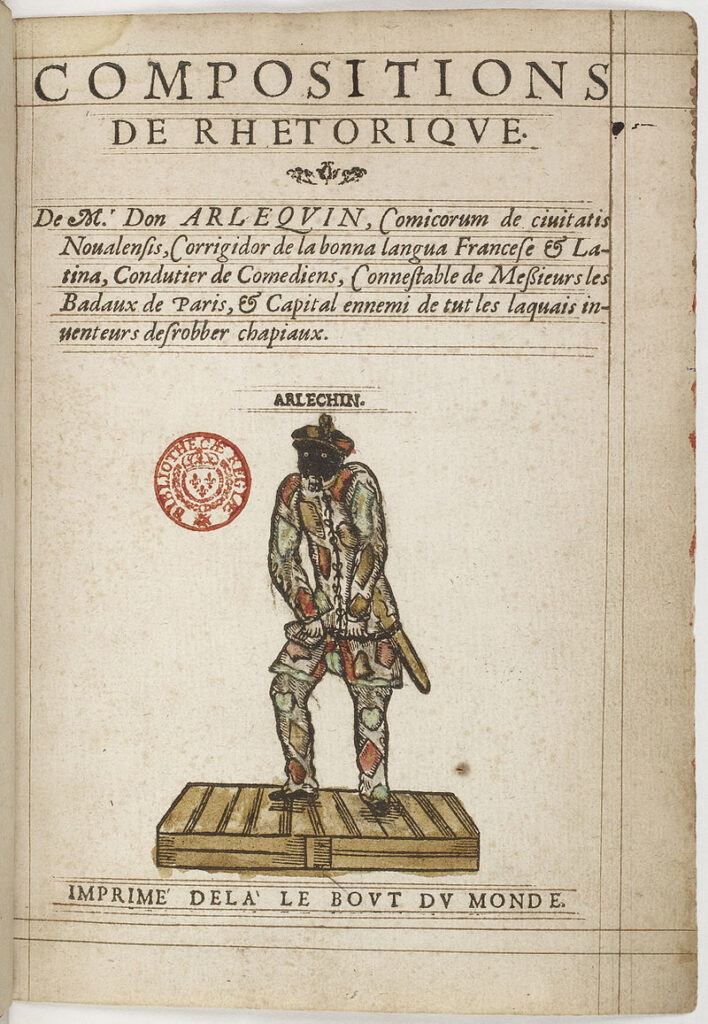
Figure 207-210 – La progressiva trasformazione del costume arlecchinesco iniziale, informalmente stracciato con grossi buchi ampiamente diffusi sul corpo (nella versione di Tristano Martinelli, acrobata e attore mantovano, apparsa come Arlecchino sul suo testo manoscritto Composizioni di Retorica “del Signor Don Arlecchino” del 1641 [sopra]; e in una simile stampa coeva – Domenico Locatelli detto Trivelino – del 1645, eseguita dal pittore francese Gregoire Huret) [sotto] divenuto geometricamente regolare con pezze diagonali multicolori (come si vede illustrato, nel 1819, nella figura di Domenico – ovvero l’attore italiano seicentesco Domenico Giuseppe Biancolelli, altro rinomato interprete arlecchinesco – dall’artista parigino Pierre-Paul Prud’hon, su disegno del collega Sébastien Coeuré (nella figura 210) [in fondo]. Per la cronaca storica, il Martinelli è stato il primo Arlecchino della Commedia dell’Arte, che ha interpretato quel personaggio a partire dal 1584, disegnandone – quell’anno stesso – interessanti immagini del suo costume e di altre maschere sue pari; e nel 1601 pubblicò, a Lione, il suo libretto che ho sopra citato nella edizione di un quarantennio dopo (il cui stravagante titolo completo è Composizione di Retorica del Sig. Don Arlecchino,Comico della Città Novalense, Correttore della Buona Lingua Francese e Latina, capo-Comico, Conestabile degli Spettatori di Parigi, e Principale Nemico di tutti i Lacchè Inventori di Sistemi di Ruberie), senza indicarne luogo o data, ma riferendo che è stato “stampato in Capo al Mondo”, e considerandolo come “scherzo tipografico tipicamente arlecchinesco”, con dedica a Maria De Medici, novella sposa del Re di Francia Enrico IV. Invece la incisione del Prud’hon riportante il Locatelli/Trivelino (la immagine in questione è quella pubblicata nel 1872) è stata eseguita nel 1816 da una opera altrettanto ottocentesca del pittore parigino Antoine-Pierre-Charles Favart, che lo ha ripresa dalla immagine originale, seicentesca, del Huret (e non Auret, come altrimenti viene scritto erroneamente): essa riporta la figura della primitiva maschera arlecchinesca, Trivelino, inventata nel 1654 – ed impersonata – dall’attore italiano seicentesco Domenico Locatelli, che si esibì a Parigi con la compagnia di Giuseppe Bianchi, prima per un solo biennio (1639-40) chiamata dal Re Luigi XIII di Francia, e poi per un più ampio periodo (dal 1653 al 1660), organizzando, con il collega e connazionale Tiberio Fiorilli, il gruppo recitante del Teatro Italiano in Francia. Ed il suo emblematico personaggio trivelinico, divenuto famoso in territorio francese, non si può mancare di vederlo nella propria tipica connotazione fisionomica, sebbeme semi-nascosto all’estremo fondo destro del quadro del Verrio precedentemente ricordato (si vedano le Figure 139 e 207) ridipinto identico, nella medesima postura e con lo stesso vestiario, dopo venticinque anni, nel 1670 (nella Figura 209) [in basso]
 Figura 208
Figura 208  Figura 209
Figura 209
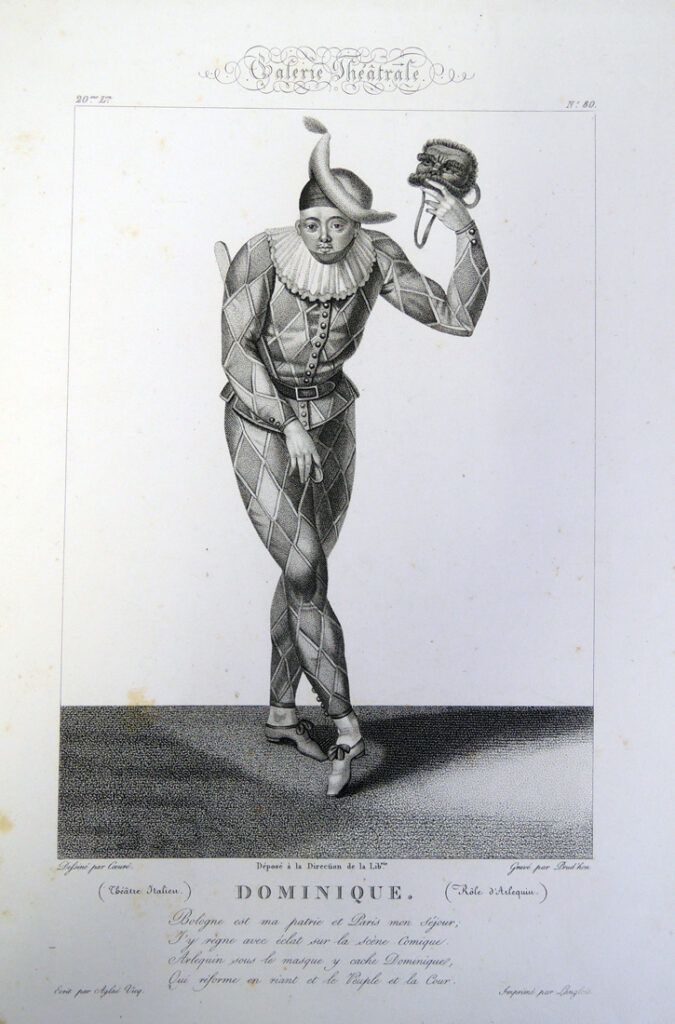
Quella prima versione a buchi e sbrindellata del vestito arlecchinesco è stata comunque presentata, da lui inventata dal 1584 (quando ne portò il personaggio sulla scena disegnandone quell’anno stesso, su fogli rimati in francese italianizzato, interessanti immagini di quel costume e di altre maschere della Commedia dell’Arte), dall’acrobata e attore italiano Tristano Martinelli di Mantova, primo Arlecchino della Commedia dell’Arte; che di quella maschera ha poi disegnato, stampata postuma nel 1641 a Lione, una serie più varia di specifiche immagini singole e simili in un libro intitolato Composizione di Retorica del Sig. Don Arlecchino, ripreso da un precedente manoscritto incompleto di 93 pagine, completamente vuote e con poche raffigurazioni soltanto, composto un quarantennio prima (nel 1601) [Figura 207].
Ed anche per tale maschera, per dovere di cronaca, i ritratti ad essa dedicati dagli artisti di epoca moderna non sono da meno tanti e interessanti: e realizzati da Edgar Degas (nel 1884 e 1890), Paul Cézanne (1889-90), Picasso (dal 1901 e sempre in altre innumerevoli versioni per tutta la esistenza del pittore) Albert Bloch (1911), Juan Gris (1919), Gino Severini (1919 e 1921-22), Salvador Dalì (variamente dal 1923 al 1926), e Aldo Carpi (nel 1944, nel curioso ed insolito quadro della Fuga degli Arlecchini: in cui numerose impersonificazioni di questo costume mascherato scappano, agitate, dappertutto, inseguite da un compatto plotone di poliziotti, rammentanti i famosi Celerini italiani post-bellici del Ministro degli Interni Giuseppe Romiti, socialista, divenuti poi famigerati con il Presidente del Consiglio del governo di Luigi Einaudi, Mario Scelba, democristiano) [Figura 211].
 Figura 211 – Le Maschere scappano, e scompaiono (per non tornare mai più). Con l’epoca moderna, l’interesse dominante per le mascherature storiche diminuisce, e lentamente decàde. Come satiricamente mostra l’allegra Fuga degli Arlecchini di Aldo Carpi, pittore e scultore milanese, dipinta nel 1944, con le famose maschere storiche dai vestiti a losanghe multicolori uscenti dalla scena urbana per la carica disperdente dei noti – futuri – Celerini (reparti mobili della Polizia di Stato italiana istituiti dal Ministro degli Interni Giuseppe Romiti, e divenuti poi più famigerati protagonisti delle azioni anti-sommossa con Mario Scelba, Presidente del Consiglio del governo di Luigi Einaudi, nei primi Anni Cinquanta)
Figura 211 – Le Maschere scappano, e scompaiono (per non tornare mai più). Con l’epoca moderna, l’interesse dominante per le mascherature storiche diminuisce, e lentamente decàde. Come satiricamente mostra l’allegra Fuga degli Arlecchini di Aldo Carpi, pittore e scultore milanese, dipinta nel 1944, con le famose maschere storiche dai vestiti a losanghe multicolori uscenti dalla scena urbana per la carica disperdente dei noti – futuri – Celerini (reparti mobili della Polizia di Stato italiana istituiti dal Ministro degli Interni Giuseppe Romiti, e divenuti poi più famigerati protagonisti delle azioni anti-sommossa con Mario Scelba, Presidente del Consiglio del governo di Luigi Einaudi, nei primi Anni Cinquanta)
LA CONCLUSIONE DELLA STORIA (“LA COMMEDIA E’ FINITA”)
Con la decadenza degli spettacoli della Commedia dell’Arte, sopravanzati da altre esibizioni più attuali ed epocali, le maschere goldoniane sono retrocesse ad un ruolo pressocchè unicamente carnevalesco, lasciando il posto a fisionomie ricoprenti il volto più inerenti alla realtà odierna ed alla cultura contemporanea: tra cui le immagini maggiormente diffuse, e note dalle nuove generazioni particolarmente filmico- telematiche, sono il protagonista della seguitissima serie di episodi a fumetti V per Vendetta concepita dal cartonista e scrittore anarchico inglese Alan Moore (ripreso poi nel film dall’omonimo titolo del regista australaino James McTeigue girato nel 2004, ma uscito nel 2006); la Faccia di Fantasma inventata dallo sceneggiatore statunitense Kevin Williamson apparsa nei 4 filmati dell’orrore della saga intitolata Urlo (che non a caso il volto assomiglia al famoso quadro omonimo di Edvard Munch), girati dal regista – anche egli degli USA – Wesley (detto Wes) Earl Craven tra il 1996 ed il 2011; ed il Fantasma dell’Opera del famoso spettacolo musicale prodotto nel 1986 dal rinomato (perché autore anche di Gesù Cristo Sperstar, Evita, e Gatti) compositore inglese Andrew Lloyd Webber [Figure 212-214].

Figure 212-214 – Tre delle mascherature contemporanee di maggiore diffusione figurativa e telematicamente sociale, di cosiddetta tendenza informatica: la prima, nella beffarda figura schematizzata di Guy Fawkes (il responsabile più convinto della Congiura delle Polveri con cui alcuni dissidenti inglesi cercarono – senza però riuscirvi – di fare esplodere la Camera dei Lord a Londra nel 1605) disegnata dal suo ideatore, l’illustratore britannico David Lloyd nel 1982, per V, il protagonista della seguitissima serie di episodi a fumetti V per Vendetta concepita dal cartonista e scrittore anarchico, altrettanto inglese, Alan Moore, ripreso poi nel film dall’omonimo titolo del regista australaino James McTeigue girato nel 2004, ma uscito nel 2006 (in una foto di Chiara Senatore del 2017) [sopra]; la seconda [sotto], nel decisamente più macabro (e impaurente) volto disfatto, come colante, della Faccia di Fantasma apparsa nei 4 filmati dell’orrore – girati dal regista, anche egli degli USA, Wesley (detto Wes) Earl Craven tra il 1996 ed il 2011 – per la saga intitolata Urlo (non a caso questa maschera assomiglia al famoso quadro di Munch), e riguardante uno spietato, e psicopatico, assassino seriale occulto, inventato dallo sceneggiatore statunitense Kevin Williamson; e la terza [in basso], nello istitutivamente teatrale personaggio del Fantasma dell’Opera, il famoso spettacolo musicale prodotto nel 1986 dal rinomato (perché autore anche di Gesù Cristo Superstar, Evita, e Gatti) compositore inglese Andrew Lloyd Webber (di cui nella foto, scattata da Joan Marcus, viene mostrato l’attore James Barbour nella sua interpretazione al Teatro di Broadway a New York nel 2017)


Tutti personaggi resi ampiamente conosciuti dai nuovi mezzi di comunicazione di massa, non più soltanto teatrali ma anche cinematografici e televisivi; che si mostrano per altro anche maggiormente indulgenti verso il senso di malignità e di orrore di questa nostra turbinosa epoca della cattiveria spietata e dell’etica deviata.
E con tali inquietanti interpreti, come recita il finale della famosa opera lirica dei Pagliacci del musicista italiano Ruggero Leoncavallo inaugurata nel 1892 (e diretta da un giovane ed allora sconosciuto maestro d’orchestra, suo connazionale, Arturo Toscanini) – per davvero “La Commedia è finita!” [Figure 215 e 216].
 Figura 215
Figura 215
Figure 215 e 216 – La Commedia (dell’Arte) è – davvero – finita! Due rappresentazioni dell’opera lirica I Pagliacci, capolavoro musicale del compositore italiano Ruggero Leoncavallo, elaborata nel 1880-82: in una immagine delle Comparse al Teatro San Carlo di Napoli nella esibizione del 2011 [sopra] e nella grandiosa registrazione del 1978 dell’indimenticabile tenore italiano-parmense Luciano Pavarotti (nel brano “Vesti la Giubba”, ovvero Ridi, Pagliaccio) [sotto]

E così, nella Parte Seconda prossima di questo mio saggio, verrà affrontato l’argomento più specifico e complesso della iconografia mascheraria nelle espressioni della Arte di Avanguardia del Novecento e contemporanea, insieme alla tipica copertura sanitaria della Maschera della Peste (emblema oiginario della necessità protettiva da ogni genere di epidemia), nella propria entità storica e con tutti gli elementi tematici di sua connessione, tipologici e figurativi; concludendo quindi con un breve riscontro formalistico sulla immagine della Mascherina, a sua volta effigie segnaletica – ma strumento pratico – di utile riparo dalla infezione attuale del Virus Corona
Corrado Gavinelli
Torre Pellice, Marzo e Aprile-Maggio 2021
Pubblicazione gratuita di libera circolazione Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito Qualsiasi richiesta ingiustificata verrà considerata un abuso e potrà essere segnalata alle autorità competenti