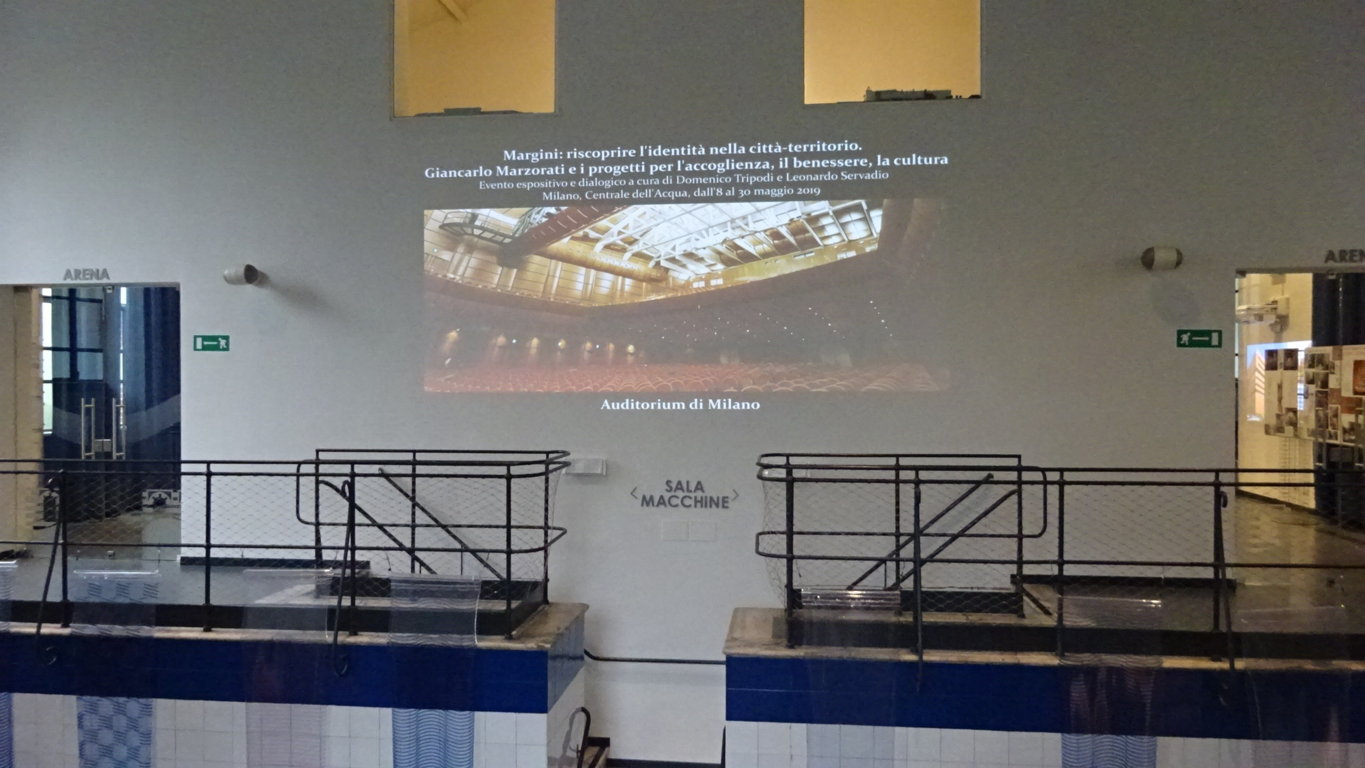Corrado Gavinelli
TEODOLINDA A BELLINZAGO NOVARESE ?
Una leggenda paesana di misteriosa provenienza (e complessa attestazione)
“Il tempo frantuma e poi disperde la verità, e quel che rimane diventa leggenda” (Nuto Revelli, Il disperso di Marburg, 1994)
AVVERTENZA: NELLE FIGURE L’ARTICOLO E’ ANCORA IN SISTEMAZIONE
INTRODUZIONE
Quanti racconti, e leggende, abbiamo ascoltato incuriositi e avvinti, prestando attenzione con stupore – o increduli – alle loro vicende, per il contenuto apparentemente reale oppure autenticamente incerto che contenevano, accogliendo i loro argomenti e riponendoli nei recessi nascosti della memoria (nostra, e collettiva, della intera umanità, di una nazione o di un popolo, o soltanto nei ricordi caratteristici di localistiche situazioni di città e paesi e personaggi importanti o meno noti). E quanto ci siamo comunque abituati, nell’arco intero della nostra esistenza, a ricordarcele tramandate da anni abbondantemente trascorsi di racconti secolari che si possono perdere nella confusione del tempo (e delle epoche), e che venivano identicamente (salvo qualche fantasiosa aggiunta poetico-narrativa o diversa altra invenzione introdotta a puro scopo sensazionale di accrescimento dell’ascolto) riproposte alle generazioni nuove per conservarne il ricordo e i significati intrinseci, spesso di enfatica conclusione elogiativa o moralistica [Figura 1].

FIGURA 1 – Albert Anker, Il Nonno racconta una Storia, 1884. E’ in questo modo che i nostri parenti più anziani (e particolarmente nei mesi invernali al caldo delle stalle) trasmettevano le loro memorie, vere o favolose: comprese le leggende come quella di Teodolinda a Bellinzago Novarese
Quasi sempre, però, indipendentemente dai loro argomenti sovente irreali, impossibili storicamente, oppure esasperati oggettivamente, lo svolgimento narrativo della leggenda possedeva un afflato di narrazione indipendente dai soli fatti, che erano soltanto un pretesto per potere descrivere una situazione particolare probabilmente accaduta e confusasi nello scompiglio degli eventi, ma rimasta come espressione di una condizione in qualche modo vissuta, sebbene alterata dal passare dei secoli.
E quante volte, dunque, certe dicerie e credenze si sono poi dimostrate plausibili, o verosimili, se non autentiche ed accettabili in una versione più logica e razionalizzata, allorchè se ne è potuto ricavare una giustificazione storica circostanziata.
Del resto, non soltanto nelle consuetudini del passato, ma anche nei tempi recenti delle affabulazioni tramandate da persone di sapienza e però non alfabetizzate da poterne sufficientemente depositare il racconto in una versione scritta, le favole di famiglia e di paese, di comunità intere e popolazioni variegate, la cui tradizione orale non è mai stata messa per iscritto ma ha continuato a procedere identica e intatta soltanto nelle parole degli anziani e dei loro prosecutori, hanno continuato a scorrere nell’insieme della memoria delle genti e della cultura popolare.
Dai ricordi dei nostri vecchi provengono i punti fissi di una epopea estinta, genericamente realistica ma più sovente fantasiosa e resa esagerata, e tuttavia memorizzata nella sua sostanza fondamentale, e tramandata per la conservazione di avvenimenti eccezionali da non dimenticare, e mantenere nella loro essenza, ed entità, di patrimonio di comunità [Figura 2].

FIGURA 2 – Joan De La Malla, Maasai che si raccontano storie ad Amboseli in Kenya, 2018. Nella cultura arcaica, priva di documentazioni scritte, la conoscenza (compresi miti e leggende del popolo) veniva spartita tra i vecchi dei villaggi per essere trasmessa a tutta la tribù
Della importanza storica degli eventi narrativi, in modo non trascurabile e perfino decisamente importante, hanno poi dato il loro decisivo riscontro anche i documenti più comuni e meno eclatanti (come le cosiddette note delle spese o i noiosi verbali burocratici) in quanto sempre testimonianze concrete di situazioni accadute, e di ineliminabile attestabilità; di cui gli studiosi più impegnati verso una storiografia della totalità documentaria – come i redattori e autori degli Annales francesi, la rivista di ricerca e critica storica innovativa fondata nel 1929 da Marc Léopold Benjamin Bloch e Lucien Fèbvre, rinomati storici moderni – hanno sostenuto la indispensabile essenzialità analitica per una più completa ricomposizione dei dati e dei fatti epocali, che non possono riguardare soltanto le storie degli eroi, dei personaggi eccelsi, dei conflitti bellici decisivi e dei vincitori, e dei grandi avvenimenti in genere, ma devono raccogliere pure gli elementi perfino anonimi o banali della quotidianità [Figure 3 e 4-5].
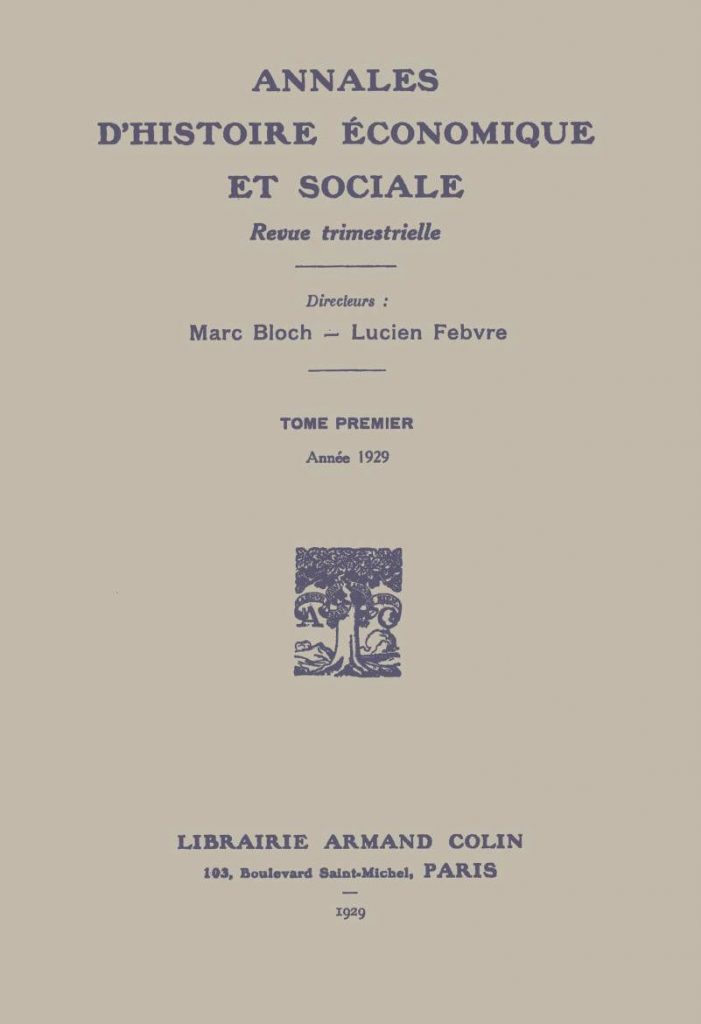
FIGURA 3 [sopra] – Il primo numero (del 1929) degli Annali, la rivista francese diretta dagli storici Marc Bloch e Lucien Fèvre che ha rivoluzionato le tradizionali metodologie storiografiche, aprendone le ricerche ai fatti non soltanto principali ed importanti ma anche agli episodi marginali e quotidiani (evenemenziali), perfino ritenuti banali o fantasiosi (come le leggende) [foto di Corrado Gavinelli del 2022]
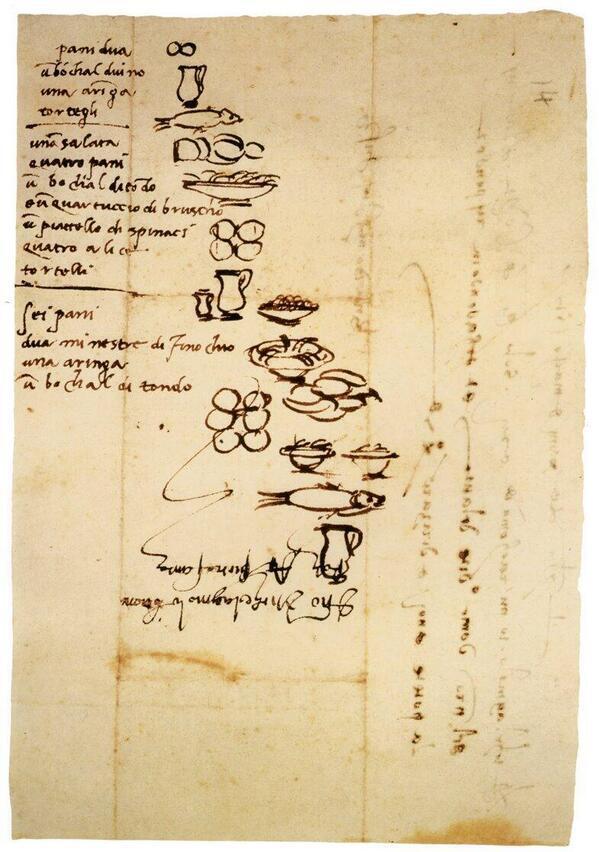 Figura 4
Figura 4
FIGURE 4 e 5 – Michelangelo Buonarroti, Lista della Spesa per un Servo analfabeta [sopra] e Studio per il Cristo Risorto [sotto], entrambi del 1518. Il primo documento è un caso egregio di dato evenemenziale, di più limitata importanza rispetto all’invece diversamente determinante disegno per una eccelsa opera artistica (entrambe foto di Corrado Gavinelli del 2022). Eppure anche la nota delle spese cibarie del grande pittore rinascimentale italiano comporta un attestato essenziale della sua vita personale e del proprio lavoro
 Figura 5
Figura 5
La fenomenologia dei fatti accaduti possiede una ampia consistenza materiale, non selezionabile dunque sui dati solamente principali, bensì composta da una strutturazione maggiormente articolata e minuta, e cosiddetta evenemenziale (riguardante cioè – come la ha indicata il proprio interprete odierno più quotato, lo storico anche egli francese e annalistico, Fernand Braudel, nel 1949 nel proprio testo Il Mediterraneo – tanto di semplice cronaca quanto di partecipazione variegata, e completante, delle più differenti discipline).
Ed a questo insieme complesso di intrecciate documentazioni, anche le leggende possono lecitamente fare parte (come lo è, nella psicanalisi, l’aleatorio valore dei sogni junghiano), apportando il loro contributo pragmatico, complementare, alla Storia, nella loro speciale maniera narrativo-contenutistica.
Dei racconti mitici e leggendari il famoso filosofo settecentesco Voltaire (François-Marie Arouet), nel proprio cinico razionalismo scettico di tipica concezione illuministica, però così tanto originale e denotativo nei risultati delle sue interpretazioni, diceva che “Se abbiamo bisogno di leggende, che esse […] abbiano almeno l’aspetto della verità! Mi piacciono le favole dei filosofi, rido di quelle dei bambini, odio quelle degli impostori”, conducendoci verso un dichiarato senso dubitativo distaccato e cautelato verso quanto non è di evidente accertamento.
Ma la concezione contemporanea, fin troppo farcita di assurdità fantasiose e realtà impossibili che ci provengono anche dalle più incontrollate informazioni di massa della false notizie sulle reti telematiche, si ritiene convinta (anche essa con una propria motivazione) – come nel 2012 ha ottimisticamente (ed insinuantemente) affermato Merida, la giovane principessa scozzese protagonista del filmato ‘Ribelle’ della regista e sceneggiatrice statunitense Brenda Chapman, di produzione disneyana – che “In ogni leggenda c’è sempre un pizzico di verità”.
E allora vediamo, in questa situazione di Teodolinda a Bellinzago (che riassuntivamente narra, secondo i racconti tramandati dai vecchi del paese, come la regina longobarda sia stata imprigionata in un castello del posto: e per altro, come ho accennato, attenendosi a questa sola succinta affermazione, senza altre aggiunte) di cui mi accingo ad elaborare una discussione analitica e critica, quali aspetti si mostrino nascostamente veri, oppure quanto consista soltanto in un prodotto di invenzione.
Leggende storiche di importanti donne piemontesi
Non è comunque un episodio isolato questo di Teodolinda nel Novarese, perché di narrazioni storiche leggendarie riguardanti donne importanti il Piemonte è abbastanza invaso: e le più sensazionali sono quelle della Donna Morta di Pinerolo, della Bella Alda di Avigliana, e della più ampiamente famosa Griselda di Saluzzo.
Tutti personaggi però, che posseggono una effettiva storicità, e contenuti etici sostanziali, invece non riferibili alla narrazione teodolindica bellinzaghese, limitata al solo fatto (certamente misterioso e pietosamente triste, ma laconico) del suo generico imprigionamento.
La Fumna Morta pinerolese
Alle favole di Pinerolo, appartiene il racconto fantasioso, ma basato su certificazioni storiche e personaggi autentici, della cosiddetta Donna Morta, di cui per altro, nel luogo in cui è avvenuto il finale della leggenda, ancòra adesso si trova un cippo di ricordo: un edificio semplice, come una caratteristica cappelletta di campagna, chiamato dialettalmente Pilùn d’la Fumna Morta (il Pilone della Femmina Deceduta) [Figura 6].

FIGURA 6 – Fotografo Ignoto, Veduta del Pilone della Donna Morta, senza data (ma forse del 1891, quando l’edificio venne fatto restaurare: ovvero “riedificare”, come riporta la targa commemorativa posta sulla base della edicola)
Evitando di usare nuove parole per descrivere questa vicenda (“tramandata nei secoli dai racconti orali delle genti contadine del posto” ma anche da cronisti e scrittori moderni, e “la cui storia risale almeno al Duecento”) ne riporto una mia esposizione che di quel fatto ho pubblicato nel 2011 sul periodico pinerolese ‘Vita’ (con il titolo Il mistero del Pilone della Donna Morta).
“La leggenda sorta intorno a questo sito narra della tragica morte incidentale, ma quasi cercata, di una giovane e coraggiosa popolana che, per una scommessa fatta con alcune sue compagne durante una delle loro adunanze notturne per filare la seta nella stalla, decise di recarsi in quel luogo dove racconti orali attestavano la presenza di lugubri fate (le famose masche, poi divenute streghe per le loro fattezze orrende e spaventose), con il deciso intento di dimostrare la falsità di quelle credenze, da lei considerante soltanto fantasie superstiziose. Promise, anzi – per dare maggiore credibilità al suo gesto impavido – di piantare, sotto l’albero di castagno che si riteneva il posto preciso degli eventi spiritici, il proprio fuso tessile: e così, in piena notte e nel buio più fitto, si recò sul posto e conficcò l’asta del roccolo nel terreno; ma quando cercò di tornare alla stalla si sentì trattenere per le vesti, da qualcosa che non riuscì a vedere (ma che in realtà era il suo fuso stesso, maldestramente da lei conficcato nella propria gonna) e che per lo spavento la fece morire sul colpo. Trovata dalle sue colleghe la mattina dopo, la popolazione decise di ricordarne l’episodio erigendo una edicola commemorativa, che fino ai restauri di fine Ottocento riportava appunto un affresco con una giovane che piantava un roccolo, sostituito in sèguito da una effigie sacra. La presenza della cappella è ricordata nelle documentazioni pinerolesi dal 1346 come edificio innalzato “in plano femine morte”, e quindi il suo reale – o presumibile – avvenimento dovrebbe risalire a più indietro negli anni; eppure un’altra credenza popolare ne conferma l’avvenimento a mezzo secolo più tardi dalla iniziale erezione dell’edicola votiva, ed in particolare al 1402, all’epoca di Pinerolo capitale del Principato di Acaja sotto il dominio del duca Giacomo; la cui terza moglie, Margherita di Beaujeu, si uccise misteriosamente nel luogo del pilone, dopo avere vagato in preda alla disperazione alla ricerca dell’anima del proprio figlio” deceduto. “Questa versione patetica e romantica ha voluto dare una personificazione storica all’anonima Donna Morta, trasferendola nella figura della nobildonna degli Acaja, che – traumatizzata dall’improvviso decesso del proprio primogenito Filippo (avvenuto ad Avigliana in circostanze misteriose nel 1368) – essendo venuta a conoscenza di strane vicende di fantasmi irrequieti avvistati nottetempo a Costagrande che ella credette di potere identificare con l’infelice anima del proprio figliuolo scomparso, volle rintracciarne la presenza, morendo però di crepacuore per non averlo ritrovato”. Ed “Una semplice croce di ferro battuto venne conficcata sul posto”, a ricordo di quel tragico evento terrificante e pietoso.
La Béla Auda aviglianese
Anche la leggenda di Alda, una avvenente fanciulla aviglianese che per il suo fascino dai suoi concittadini era riconosciuta come la Bella, è una storia tramandata oralmente e poi trascritta per la sua grande rinomamanza popolare (tanto che ne hanno trattato il politico Cesare Balbo nel 1829, il noto storico pinerolese Domenico Carutti nel 1847, il versatile Massimo D’Azeglio nel 1867; e nel 1884 anche il romanziere e illustratore Edoardo Calandra, fratello dello scultore Davide) [Figura 7].
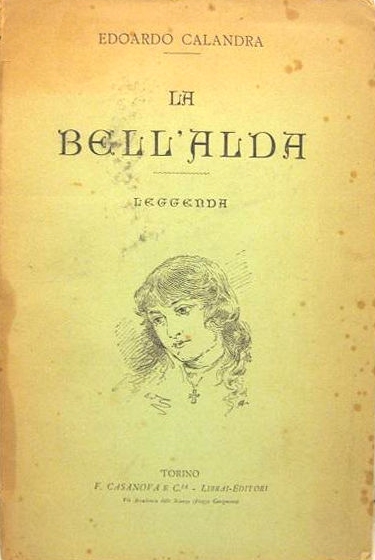 Figura 7
Figura 7
FIGURA 7 – La copertina del libretto narrante la leggenda aviglianese della Bella Alda, pubblicato nel 1884 e scritto dal romanziere e illustratore torinese Edoardo Calandra (fratello dello scultore Davide) che ne ha disegnato anche le figure
Sulla origine del racconto si ritrovano varie versioni di riferimento, a riguardo della identità del personaggio nella sua consistenza epocale. Una delle più recenti risale al 1699, riportata in una pubblicazione di quell’anno (Breve racconto della badia di San Michele della Chiusa) dallo storico piemontese sei-settecentesco Pier Giacinto Gallizia (autore soprattutto di biografie religiose), che ipotizzava come l’episodio avvenne nella prima metà del Seicento durante una delle tante guerre sabaudo-europee contro la Francia, e perpetrata da un gruppo di Lanzichenecchi spintisi fino alla famosa Sacra di San Michele, la grandiosa abbazia medievale arroccata su una vetta della Valle di Susa, il Monte Pirchiriano.
Nella quale erano soliti rifugiarsi le popolazioni vallive dei dintorni (come in un ricetto tipico dell’epoca) per trovare scampo dalle efferate incursioni delle soldataglie.
E per sfuggire agli abusi dei militi invasori che la inseguivano, nell’intento di conservare la propria purezza femminile che costituiva il suo vanto morale oltre alla esteriore bellezza, la Bella Alda si trovò costretta a gettarsi dall’alto della ultima torre della fortezza abbaziale (che si trovava su un dirupo scosceso, come la ha eccellentemente raffigurata tra il 1825 ed il 1830 l’artista piemontese Giuseppe Pietro Bagetti in un suo eloquente dipinto romanticistico – La Sacra di San Michele – e secondo quanto altrimenti ancòra oggi si vede, nel suo svettante rudere semi-distrutto, chiamato appunto la Torre della Bella Alda) [Figure 8-10] …

FIGURE 8-10 – Giuseppe Pietro Bagetti, La Sacra di San Michele, 1825-1830 [sopra]; Elio Pallard, La Sacra ammantata dalla neve, 2013 [sotto]; e Chiara Bunino, Torre della bell’Alda, 2012 [in basso]. L’incantata veduta della Sacra di San Michele (famosa abbazia benedettina sorta inizialmente nel 983-987 sulla cima del monte Pirchiriano, all’imbocco della Valle di Susa – e per questo chiamata più esattamente San Michele della Chiusa – nel comune di Sant’Ambrogio di Torino, sviluppatasi poi dal 999-1000 in stile romanico fino al suo conclusivo aspetto gotico del 1148-70) dove si è svolta la leggenda della Bella Alda, era in origine circondata da mura difensive; e la Torre famigerata da dove la giovane aviglianese si è gettata per sfuggire ai soldati che la inseguivano, è l’ultimo rudere esposto sul burrone ancòra oggi esistente, sebbene alquanto rovinato

FIGURE 9 (sopra) e 10 (sotto)

… preferendo così la morte al disonore [Figura 11].
 Figura 11
Figura 11
FIGURA 11 – Edoardo Calandra, Il Salto della Bell’Alda, 1884. Illustrazione mostrante il gesto disperato della giovane aviglianese, gettatasi dalla torre della Sacra sanmichelina per salvare il proprio onore dalla soldataglia che voleva abusare di lei
Ma avendo, la giovane aviglianese, pregato la Madonna di salvarla, si ritrovò illesa da quella mortale caduta, afferrata da due angeli che la depositarono a terra delicatamente.
Di questo fatto la fanciulla raccontò a tutti il miracoloso risultato, vantandosi di essere una protetta di Maria Vergine; ma siccome nessuno tendeva a crederle, volle dimostrare la verità di quanto diceva, ritornando alla torre e ributtandosi nuovamente nel vuoto. E questa volta però, “a causa della sua superbia” presuntuosa, non ricevette aiuto celeste alcuno, sfracellandosi orrendamente al suolo (come raccontano i versi di una canzone popolare del luogo: “La Bell’Alda insuperbita / qui dal balzo si gettò / sfracellata nella valle / la Bell’Alda se ne andò”).
E dove la ragazza morì, i monaci posero pure in tale caso una semplice croce, ancòra adesso esistente.
Altre versioni di questa leggenda la rimandano però al Medioevo: una all’epoca di un presunto assalto – mai però avvenuto nella realtà storica – alla Chiusa da parte dell’imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa verso la metà del Millecento, ed un’altra al Trecento per la incursione di non bene identificate “truppe legionarie”, ed infine – in una circostanza più specificata ma altrettanto fantasiosa, inventata dall’illustratore Calandra sopra citato – relativa al Mille, che ritiene la avvenente aviglianese quale sposa di Arduino di Ivrea, divenuto Re d’Italia nel 1002 [Figura 12].
 Figura 12
Figura 12
FIGURA 12 – Edoardo Calandra, Ritratto della Bell’Alda, 1884: è la prova di stampa per la copertina del libro della leggenda sopra riferito (si veda la Figura 7)
La Griselda saluzzese
Forse la più famosa di tutte le leggende piemontesi (perché trascritta dal narratore italiano Giovanni Boccaccio nella decima novella della ultima giornata di racconti del suo Decamerone compilati nel 1349-53; nonché magnificata nel 1691 dal poeta e letterato francese Charles Perrault, in una “fiaba in versi”; ma anche raccontata dai famosi scrittori, rispettivamente italiano ed inglese, Francesco Petrarca e Geoffrey Chaucer; e quindi riproposta da tanti altri autori ancòra) [Figure 13 e 14] è quella di Griselda, la muliebremente onesta e fedele pazientissima sposa del Marchese di Saluzzo Gualtieri.

FIGURE 13 e 14 – John William Waterhouse, Un racconto del Decamerone, 1916 [sopra] e Henry Steimer, Gualtieri incontra Griselda, 1903 [sotto]. Due riferimenti storici alla popolarità leggendaria del racconto griseldesco, riportata dallo scrittore medievale italiano Giovanni Boccaccio nell’ultimo suo racconto decameroniano, e in una illustrazione del grafico francese disegnata per i Racconti di Perrault (nella serie della Piccola Biblioteca Popolare) editi da Jules Rouff a Parigi nel 1904
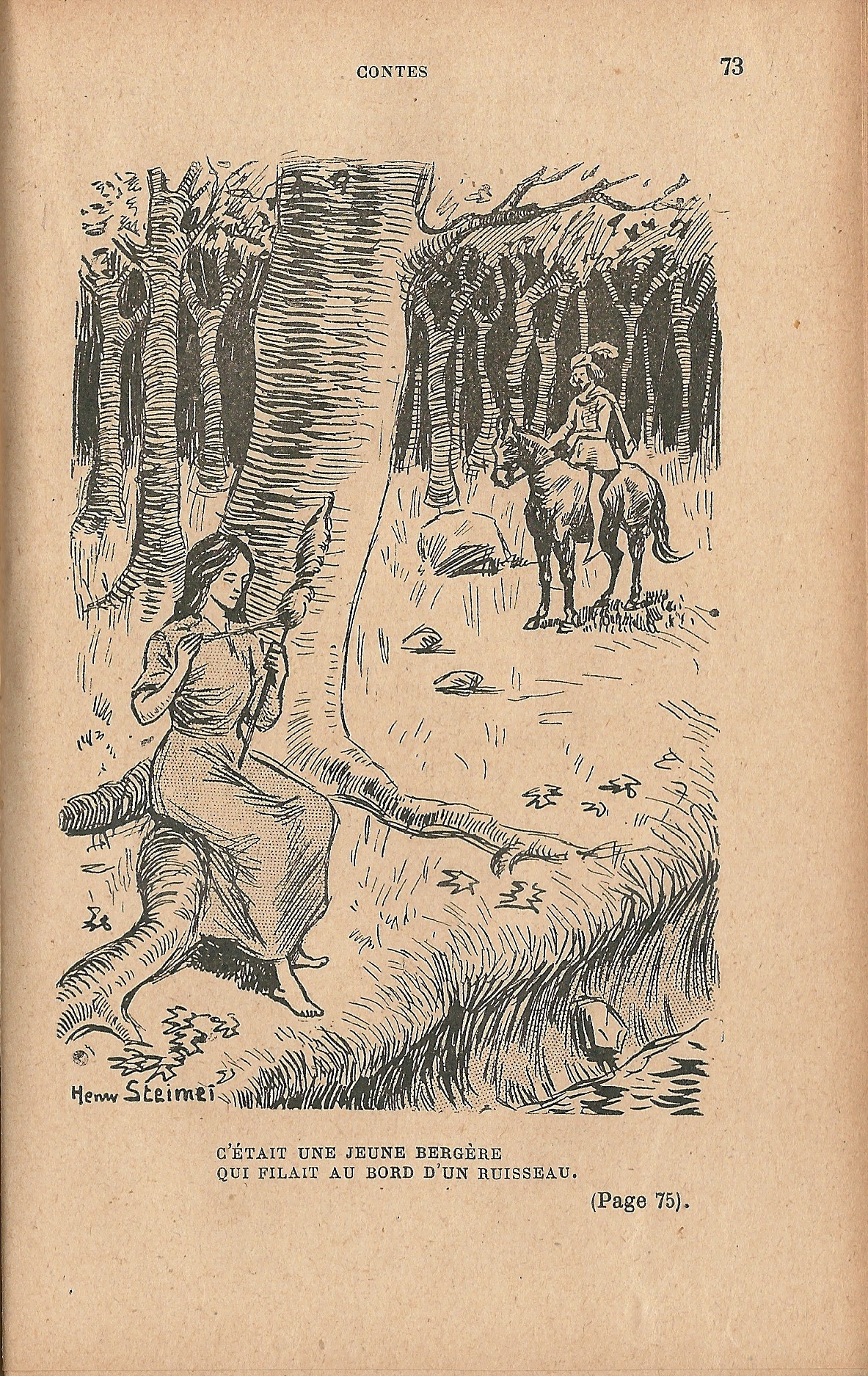
Dal quale però fu da lui ampiamente vessata e ingannata, con insolenza umiliante e atroci crudeltà, per metterne alla prova la effettiva fedeltà [Figura 15].

FIGURA 15 – Charles West Cope, Prima Prova della Pazienza di Griselda, 1848. E’ una delle tante vessazioni crudeli cui la giovane saluzzese venne sottoposta dal suo sadico marito per verificarne la fedeltà muliebre e – in questo caso – l’accettazione delle sue stravaganti decisioni, consistente nella risoluzione di sottrarle la loro primogenita e mandarla a morte attribuendone la volontà addirittura ad un ordine del loro re!
La giovane donna, anche ella di origine povera ma di aspetto assai piacevole, accetta queste prove tremende, mostrando così di essere una moglie proba e leale, e degna di una fama di correttezza. Ma anche persona di incredibile sopportazione, che la fa per questo diventare un modello eccelso di dedizione matrimoniale al limite di ogni pensabile tolleranza (che oggi si sarebbe risolta con un netto divorzio per incompatibilità di convivenza).
La vicenda griseldina si svolge sostanzialmente nelle terre saluzzesi – come riferisce nella sua cronaca del 1829 sulle Memorie Storico-Diplomatiche appartenenti alla Città ed ai Marchesi di Saluzzo l’ottocentesco storico “saluzzese” Delfino Muletti, rapportandosi ad autori precedenti da lui analizzati – “nel tempo in cui si dice abbia vissuto questo marchese”, e cioè al “principio dell’undicesimo secolo”, ma senza accertanti date più precise (e comunque, presumibilmente, intorno al 1006-09); mentre Adalinda Gasparini (psicoanalista e favolista di Firenze), nel suo saggio sui Misteri Gaudiosi e Dolorosi tra Favola e Novella del 2015, la attribuisce a tre centenni dopo – al “XIV Secolo” – riferendosi tuttavia, ritengo, con quella data, all’epoca della stesura del testo del Boccaccio.
Degli eventi griseldiani molti artisti figurativi dei secoli successivi al Trecento boccacciano, soprattutto dal Quattrocento, hanno rappresentato le scene di vita più caratteristiche, anche nei minuti dettagli formali dei singoli eventi. Allo stesso modo glorificante e pieno che anche per Teodolinda – come vedremo – è stato fatto dagli esegeti rinascimentali della regina longobardica (e successivamente da tutti gli altri pittori e illustratori più vari).
In particolare si sono distinti, nel primo Rinascimento quattrocentesco, il fiorentino Francesco Di Stefano detto Pesellino, con i suoi compattatamente narrativi Episodi della Storia di Griselda del 1445-50 (che rinviano allo stile tardo-gotico degli Zavattari della Cappella di Teodolinda a Monza, di cui anche tratterò più avanti specficamente), ed il teatralmente scenico Maestro della Storia di Griselda con i suoi pannelli del 1494, già di stesura pienamente rinascimentale sul genere botticelliano [Figure 16 e 17].

FIGURE 16 e 17 – Francesco Pesellino, Episodio dalla Storia di Griselda, 1445-50 [sopra], e Maestro della Storia di Griselda, Il Matrimonio, 1494 [sotto]. Due dipinti quattrocenteschi di accurata esecuzione paesistico-figurale; il primo con riferimenti stilistici al Beato Angelico ed a Filippo Lippi, e il secondo di maggiore influenza botticelliana

Ma altri artisti ne hanno complessivamente illustrato gli episodi, anche riprendendo atteggiamenti e raffigurazioni tipiche, fissate dai criteri narrativi dell’epoca e precedenti: come si può vedere nel confronto iconografico del Matrimonio griseldiano con il Marchese di Saluzzo analiticamente rappresentato dal grafico floreale inglese Thomas Derrick nella sua Griselda. Illustrazione per Il Decamerone di Boccaccio del 1920 (in cui la giovane saluzzese si spoglia dei suoi panni poveri da custode di greggi per indossare abiti più degni per il proprio nobile consorte) nella stessa modalità figurativa tematcamente elaborata dal Pesellino ed anche dal coevo, ed altrettanto fiorentino, artista Apollonio Di Giovanni nel suo dipinto della Novella di Griselda nel 1442-45: in una serie di rappresentazioni analoghe eseguita in maniera poco differentemente da autori diversi e in epoche altrettanto estranee [Figure 18-19 e 20].

FIGURE 18-20 – I racconti griseldini hanno ispirato parecchi artisti e illustratori in varie epoche, i quali comunquesi sono rimandati spesso le raffigurazioni tematiche sostanziali con medesima (ma non proprio identica) espressione: nell’episodio della spoliazione di Griselda dai suoi poveri abiti di pastora, si può riconoscere come il grafico e fumettista inglese Thomas Derrick di Bristol (nella sua immagine di Griselda. Illustrazione per Il Decamerone del Boccaccio del 1920) [sopra] riprenda formalmente il Pesellino prima citato [sotto, a sinistra: e si veda la Figura 16], non tanto altrimenti diversamente dal pittore fiorentino Apollonio Di Giovanni nel suo dipinto Novella di Griselda del 1442-45, che ne ha restituito la scena con più flessuosa sinuosità [sotto, a destra]
 Figure 19 e 20
Figure 19 e 20 
LA LEGGENDA BELLINZAGHESE DI TEODOLINDA
Come ho più sopra accennato, dalle ultime generazioni degli anziani bellinzaghesi proviene ancòra una particolare leggenda storica che aleggia nei racconti tramandati a figli e nipoti, e appartenente al riscontro favolistico più famigliare della intera comunità paesana: quella della “Regina Teodolinda, longobarda, che venne tenuta prigioniera nel castello di Bellinzago”.
Una versione che risulta di recente dizione, ma di cui esiste una precedente (almeno ottocentesca) diversa narrazione, ancòra però più generica – sempre comunque riferita ad una anonima sovrana dei Longobardi – riportata nel 1992 sul ‘Bollettino Storico per la Provincia di Novara’ in un articolo (Un Robin Hood in formato ridotto) del sacerdote bellinzaghese Don Francesco Marchi (studioso locale e parroco di Bellinzago di fine-Ottocento e primo Novecento), narrante una vicenda risalente al 1896, e ripubblicata nel 2001 dallo storico anche egli bellinzaghese Giacomo Musetta (Guida Naturalistica – o Accompagnatore – professionale, Direttore della Associazione Culturale Bellinzaghese Amici del Caffè, ed editore) nel suo Quaderno dal titolo Il Rosso dei Mostini di Bellinzago, in cui viene ricordato come nel “Castellaccio” (edificio medievale ora distrutto situato “sul declivio della collina” meridional-orientale di Bellinzago, di cui dettagliatamente tratterò più oltre) “si vuole che un tempo fosse morta, forse uccisa, una regina longobarda”.
E si tratta comunque – nel caso più precisato di riferimento a Teodolinda – di uno strano riscontro, poiché questo racconto storicistico viene presentato senza la prolissa esposizione solita delle favole o leggende di tradizione, bensì consistendo soltanto in una breve comunicazione di cronaca, priva di narrazione o storicità maggiormente elaborata.
In una attestazione verbale che non presenta agganci opportuni alla discrezionalità dei fatti.
Che ci permette però, nonostante la sua sintetica essenzialità, di poterci avvicinare agli aspetti più specifici, e considerevoli, appartenenti a quella situazione bellinzaghese, e di cercare di individuarne le – eventuali – connessioni con il contesto (e la realtà storica).
Perché Teodolinda proprio a Bellinzago?
Innanzitutto pe quale motivo, o circostanza, Teodolinda, e non altri personaggi storici analogamente importanti, doveva passare per Bellinzago? E quando questo evento avvenne (o avrebbe potuto accadere)?
E per quale condizione, ed evento, la stimata e potente Regina dei Longobardi doveva venire segregata nel castello di quello sperduto borgo paesano? (e chi la catturò – ammesso che il fatto sia davvero successo – e la tenne incarcerata in uno sconosciuto maniero del Novarese)?
E come, infine, avvenne la propria liberazione?
A tutte queste domande cercherò di rispondere tra poco, premettendo soltanto la vicenda di una simile situazione della sovrana longobardica riportata da una altra leggenda analoga, in tale caso però effettuatasi nel più lontano contesto delle montagne valtellinesi.
Il Castello di Teodolinda in Valtellina
Bellinzago dunque, per intanto, non è la unica località antica a vantare la diceria della presenza, tra i suoi vecchi manieri medievali, della presenza (e dell’imprigionamento) teodolindese: in quanto anche a Domòfole (località valtellinese presso la frazione Consiglio di Mello sopra Morbegno) una orale tradizione locale tramanda che nel suo maniero fortificato altomedievale – di cui restano pochi ruderi, ma di consistente riconoscibiltà tipologica – chiamato ancòra popolarmente Castello della Regina a causa della diffusa leggenda che lo riguarda [Figura 21], riferisce che vi avrebbe dimorato, sebbene temporaneamente, la sovrana longobarda Teodolinda, nel periodo della sua missione religiosa rivolta alla conversione al Cristianesimo delle popolazioni locali, cui si era piamente dedicata dopo il matrimonio con il Re dei Longobardi Agilulfo (avvenuto nel 591).

FIGURA 21 – Autore Anonimo della Redazione del sito telematico Orobie, Il Castello di Domofole, 2021. Si tratta della fortezza dove una leggenda locale – ma non vera – ha ritenuto fosse stata la Regina Teodolinda
Una tradizione però – questa della dimora domofolese – pure essa davvero leggendaria, perché il maniero domofolino non ha origini longobarde, essendo stato costruito molto più tardi, verso il Mille (e la sua prima notizia scritta ad essere documentata è dell’anno 1023), e non mostrando attestanti segni di edifici precedenti, tantomeno longobardi (anche se la vivace escursionista valtellinese Serena Dalan, scrittrice e ottima fotografa nonché alimentarista vegetariana, abbia confermato – nel 2016, sul sito telematico ‘B&B Costiera dei Cech’ – seguendo una orale diceria locale, non tuttavia provata, “che il Castello di Domofole sia stato fatto realmente costruire nel VI secolo dal re Agilulfo nonchè marito della Regina Teodolinda”) [Figure 22, e 23].


FIGURE 22 e 23 – Serena Dalan, scrittrice valtellinese e fotografa nonché alimentarista vegetariana (Castello di Domofole, 2016 [sopra]; e Muffin vegani al limone, 2021 [sotto ]), che nel 2016 (sul sito telematico ‘B&B Costiera dei Cech’: questo epiteto locale viene gergalmente riferito ai non-cattolici, ciechi alla fede cristiana) ha riportato una notizia tramandata oralmente e non tuttavia provata, secondo cui “il Castello di Domofole sia stato fatto realmente costruire nel VI secolo dal re Agilulfo nonchè marito della Regina Teodolinda”
E lo stesso vale per una seconda narrazione leggendaria riferita al maniero domofolese, riportata dallo storico locale Massimo Dei Cas in un suo articolo del 2022 riguardante Il Castello di Domòfole, apparso sul sito telematico PaesiDiValtellina, che ipotizza come la regina in questione non sia Teodolinda bensì “Forse, invece […] sua figlia, la meno nota ed assai più sfortunata Gundeberga”: la quale – “come narra lo storico Sidonio Apollinare [..] era andata in sposa ad Arioaldo, re dei Longobardi”, ma “Di lei si innamorò Adalolfo, che […] le chiese di diventare suo amante”; ed al rifiuto della donna, il suo pretendente “macchinò una perfida vendetta”, facendo “circolare” false “voci calunniose che parlavano di una tresca della regina con il potente duca di Toscana Tatone (o Tosone)”, comprendente l’assassinio “del consorte”.
Contro quella accusa invano la regina “protestò vivacemente la propria innocenza”, ma il Re, “nel dubbio, decise […] di far rinchiudere la moglie in un castello lontano”. Era “l’anno 634, ed egli scelse il castello che già aveva ospitato la madre Teodolinda, nella lontana Valtellina”, dove “Gundeberga rimase rinchiusa, per tre lunghi anni”; finchè – dopo “un’approfondita inchiesta” processuale – “alla fine trionfò la verità, la calunnia venne scoperta”, e “la regina riebbe la sua libertà”.
La verità storica tuttavia, come quasi sempre in queste leggende antiche, risulta leggermente diversa, in quanto Gundeperga (come altrimenti viene, più correntemente, chiamata il nostro personaggio) – che era figlia di Agilulfo e di Teodolinda – venne imprigionata dal proprio marito, Arioaldo Duca di Torino, a sèguito della accusa di avere congiurato contro di lui sostenendo la rivolta del Tasone sopra citato, e rinchiudendola però non in Valtellina bensì nel più vicino Castello di Lomello, sempre in Lombardia ma situato oltre il fiume Po, verso il Piemonte [Figura 24].

FIGURA 24 – Raphael Saderer, Gundeberga Regina Boia dei Longobardi, 1618. Il commento a questa stampa descrive la donna nella versione leggendaria secondo cui “accusata ingiustamente, […] guarda fuori dalla finestra della prigione la morte di Arioaldo avvenuta per punizione divina”; ma nella realtà storica la vicenda si svolse diversamente (intervento celeste a parte), poiché la sovrana venne perdonata e riabilitata dal marito, con la promessa di lasciarla sostenere la diffusione del Cristianesimo tra i Longobardi (come già si era prodigata sua madre Teodolinda); ed il re – di decisa fede ariana – decedette invece per un caso di avvelenamento, causato forse proprio dalla consorte. Per la cronaca, l’aggettivo Boia riferito alla sovrana, proviene dalla sua appartenenza al ceppo dei Boi, tribù celtica antica stanziata nella Boemia odierna nel 60-58 prima di Cristo
E comunque, anche per questo fatto più storicamente precisato, si deve rilevare una ulteriore leggera incongruenza dataria: poiché l’imprigionamento della regina avvenne, nella realtà dei fatti, non con il 634 bensì negli anni 627-629, e Tasone fu “Sovrano di Toscana” sùbito dopo, dal 630 al 685!
TEODOLINDA (REGINA DEI LONGOBARDI DAL 589 AL 624)
E dopo questa collaterale premessa, veniamo dunque alla nostra sovrana longobarda quale personaggio protagonista inaspettato della sua leggenda bellinzaghese. Porgendo però – prima di trattare il proprio caso favolistico in questo paese (ora cittadina alquanto metropolitanamente sviluppata) – una sintetica inquadratura della sua figura femminile e muliebre, politica e religiosa, e storica. Che sarà utile per potere dirimere nei dati reali i problemi generali e minuti della sua esistenza, e della propria consistenza di contributo personale alle vicende del suo regno (e nei confronti specifici della leggenda locale a lei attribuita).
La sua vita
Teodolinda, o altrimenti Teodelinda, era una principessa di stirpe regale, discendente per parte materna dalla casata longobarda più nobile dei Letingi (la prima dinastia di quel popolo che si trasmise – dal 445 – non più per elezione tribale ma per progenie famigliare).
Da parte di padre – Garipaldo I di Baviera, Duca dei Bavari dal 555 al 591, capostipite delle dinastie bavaresi – proveniva però da una gente germanica diversa, corrispondente alla attuale regione tedesca con tale nome (la Baviera), che aveva la propria capitale a Ratisbona, la città dove è probabile (perché non esistono documentazioni certe su questo fatto, come pure della data precisa di nascita di Teodolinda, attribuita al 570) che visse da infante e giovane la futura regina longobarda, prima di venire in Italia.
Ed ella lasciò la Germania nel 589, a 19 anni soltanto, per sancire una alleanza strategica, di difesa verso il dominio dei Franchi, con i Longobardi, sposando il loro Re Autari [Figura 25].
 Figura 25
Figura 25
FIGURA 25 – Michael Wolgemut (che è stato maestro di Albrecht Dürer) con il figliastro Wilhelm Pleydenwurff (a sua volta tutore düreriano), Re Arthari, 1492. La xilografia a colori appartiene alle numerose illustrazioni della cosiddetta Cronaca di Norimberga (chiamata in tale modo per la città dove il manoscritto venne stampato dall’editore Anton Koberger nel 1493, altrimenti detta Libro delle Cronache per gli studiosi latini; ma il titolo originale era Cronaca Mondiale) scritta dal medico tedesco (divenuto per altro dottore in medicina a Padova nel 1466), umanista e collezionista di libri, Hartmann Schedel. Le incisioni su legno vennero eseguite tra 1491 e 1493
Le nozze avvennero a Verona, in una località diplomaticamente a metà tra i regni bavaro e lombardo, ma sùbito gli sposi raggiunsero Pavia, che dal 572 era stata designata – da Clefi, successore di Alboino – capitale del regno longobardo (restandone ufficialmente come tale – a parte alcuni contingenti spostamenti – fino alla conquista franca di Carlo Magno nel 774). Con lo sposalizio autariano, Teodolinda divenne così Regina Consorte, al pari del sovrano eletto.
Purtroppo il matrimonio durò pochissimo, neppure un anno e mezzo, poiché il marito decedette nel 590, probabilmente avvelenato. E Teodolinda, su pressione del suo popolo che rischiava di restare senza un monarca, dovette risposarsi; e scelse (perché alle regine dei Longobardi era data la facoltà di decidere quale marito prendersi) Agilulfo, cognato del defunto monarca Autari, e Duca di Torino: personaggio influente in Piemonte, in quanto era di origine turingia – la popolazione germanica di collegamento tribale con gli Unni di Attila, stanziata al centro della Germania tra i fiumi Reno ed Elba – e divenuto Duca dei Turingi Taurini, ovvero torinesi, nel 531; allorchè, in conflitto – sempre – con i vicini Franchi che avevano annientato il suo dominio indipendente, dovette integrarsi con i Longobardi italici [Figura 26].
 Figura 26
Figura 26
FIGURA 26 – Wolgemut e Pleydenwurff, Re Agilulfo, 1492
Teodolinda contrasse il suo nuovo sponsale l’anno stesso del decesso del precedente consorte, ma questa volta a Lomello, in pieno territorio lombardo, ed all’inizio di quel pssesso piemontese tra Lombardia e le Alpi che gli portava il suo nuovo marito torinese, e che già aveva parzialmente acquisito con l’affidamento, dal 589, del Ducato di Asti al fratello della sovrana, Gundoaldo (una altra favorevole circostanza diplomatico-tattica che permise ai Longobardi di avere un ulteriore dominio fisso, a metà del territorio piemontese – sui luoghi in Piemonte della pianura padana rivolti al regno oltremontano dei Franchi).
La nuova unione matrimoniale ebbe una maggiore durata (25 anni, fino al decesso agilulfiano) della precedente, e concesse alla regina consorte di attuare diverse importanti – sociali, religiose, e tecniche – opere private e pubbliche (di cui specificherò tra poco).
E anche dopo che Agilulfo morì (nel 616) [Figura 27] la attività teodolindica di sovrana regnante proseguì continuativamente fino al 624, prima in qualità di Reggente del figlio Adaloaldo in attesa del raggiugimento della sua maggiore età, e poi come confermata madre-consorte del monarca; e infine, quando il subentrato Re venne deposto da una congiura di corte nel 626, la resistente sovrana decise di ritirarsi (ormai 56enne) a vita privata, morendo quindi due anni dopo (nel 628: anche se altri storiografi ne riportano il decesso ad un anno prima).
 Figura 27
Figura 27
FIGURA 27 – Autore Anonimo (ma Alfredo Colella), I Domini Longobardi alla morte di Agilulfo (616), senza data (ma del 2016)
La Regina fu sepolta con tutti gli onori nel tempietto palatino di San Giovanni a Monza (l’edificio che poi nel Trecento divenne il più ampio Duomo cittadino) di cui – come vedremo – fu la grande fondatrice e costruttrice, e munifica benefattrice, venerata dal popolo locale come beata per le sue pie e caritatevoli azioni verso la propria gente (anche se la Chiesa di Roma non abbia mai confermato liturgicamente il suo culto).
Il personaggio di Teodolinda, infatti, fu stimato per tutto il periodo del proprio regno, e molto amato dai sudditi, che la resero elemento fondamentale di numerose leggende e racconti popolari. E con il passare dei secoli divenne anche un soggetto riconosciuto di grande ricordo commemorativo, che soprattutto coinvolse anche la nobiltà lombarda, raggiungendo il proprio apice di considerazione nel Quattrocento, quando Filippo Maria Visconti, Duca di Milano (ed ultimo della dinastia viscontea) commissionò la esecuzione (in realtà si trattò di una risistemazione più ampia di un precedente spazio eretto alla fine del Trecento), nel 1440 (con conclusione nel 1446) della famosa Cappella di Teodolinda nel Duomo di Monza, divenuta artisticamente importante per la splendida decorazione dei grandiosi affreschi realizzati dai pittori milanesi Zavattari (di cui tratterò più avanti) illustranti la vita della regina longobarda, in un maestoso ciclo di dipinti che costituisce il più grande esempio italiano di Gotico Internazionale.
Le sue opere pubbliche
Teodolinda fu una donna oltre che bella anche intelligente e saggia, e non soltanto considerata e adorata dal suo popolo quale istitutiva regina (perché durante il suo regno riuscì a dare ai Longobardi potere e prosperità) ma particolarmente per essersi dimostrata una munifica mecenate, sostenitrice di vari attività e lavori (benèfici e materiali) per la sua comunità. Una attribuzione sociale che le è rimasta impressa – quasi come una predestinazione di ruolo – perfino nel significato verbale dello stesso suo nome, che vorrebbe dire – nella antica lingua germanica – Protettrice del Popolo (combinazione di Theud, gente, e Lind, scudo).
Però la parola Teodolinda che noi usiamo è comunque la forma italianizzata (volgar-tedesca) della denominazione consolidatasi nella tradizione storica e letteraria dell’Italia medievale (di epoca longobarda e successiva), quale definizione alterata della più originaria e giusta Teodelinda (che si ritrova in varie attestazioni documentarie storiche, tra cui il Papiro del Tesoro del Duomo monzese del 650 che la denomina Theodelinda, allo stesso modo che si legge nelle coeve lettere inviatele dal Papa Gregorio I), a sua volta proveniente dalle trascrizioni di Theudelinda (usata dal cronista delle gesta longobardiche, lo storico Paolo Diacono, nella sua Storia dei Longobardi del 787-789), di Theodellende (incisa sul suo sarcofago tombale monzese traslato in duomo nel 1318), nonchè del più antico Theodelenda, riportato sull’Evangelario della sovrana, dono fattole nel 603 sempre dal pontefice Gregorio quale attestazione di riconoscimento per la riuscita conversione dall’Arianesimo al Cattolicesimo della popolazione longobarda da lei attuata, segnatamente in occasione del battesimo del proprio figlio Adaloaldo, primo monarca dei Longobardi ad essere battezzato cristianamente.
La conversione dei Longobardi al Cattolicesimo
E’ questa opera di cambiamento di fede religiosa che costituisce il perno della attività operativa teodolindesca nel suo complesso, perché da tale atto di trasformazione di credo provengono tutti gli altri fatti anche materiali e fisici della sua azione verso i propri sudditi, e le ulteriori persone in genere della propria epoca.
Perché, sottostantemente, la conversione fideistica comportava anche una sorta di atto di unione per una popolazione di medesima stirpe ma politicamente dispersa in Italia ed anzi con forti conflitti interni di genere soprattutto religioso (e di potere).
I Longobardi infatti erano – per tradizione atàvica – pagani, e adoranti diverse divinità mitologiche ancestrali; mentre coloro che già avevano accolto il Cristianesimo non aderivano alla ortodossità papal-romana bensì alla concezione (dalla Chiesa Cattolica rifiutata e considerata eretica) ariana (ideologia di culto imposta da Alboino nel 568), che negava la natura divina di Cristo.
E per la verità neppure Teodolinda, che era comunque cattolica, si poteva ritenere una piena osservante del credo cristiano ufficiosamente riconosciuto, in quanto ne seguiva una sorta di versione nestoriana (cosiddetta dei Tre Capitoli, riferita agli scritti teologici di Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Ciro, e Iba vescovo di Edessa) che aveva creato uno scisma di interpretazione concettuale sulla natura umano-divina di Gesù (considerata con due aspetti totalmente separati e non coincidenti ipostaticamente, come veniva invece attestato canonicamente), condannata ideologicamente ma tollerata dal Cattolicesimo istitutivo, e nel caso specifico accolta criticamente dal Papa Gregorio Magno tramite la mediazione del missionario irlandese Colombano (divenuto poi santo: il noto predicatore di Bobbio – la località emiliana tra Piacenza e Novi Ligure dove è stata costruita la importante omonima abbazia – sostenuto dalla stessa regina longobarda).
Edifici a Torino e Monza
Conseguenza di questa azione prettamente di fede (non deve venire dimenticato che la religione a quell’epoca, come per vari secoli dopo, costituiva una determinante priorità di identità cultural-politica per le persone singole e per una nazione) è stata la derivata attività costruttiva che Teodolinda sostenne ed attuò per definire la organizzazione civile, oltre che di culto, del regno longobardo.
Siccome il marito Agilulfo, con la sua salita al trono del reame longobardico, aveva attuato lo spostamento della capitale del suo regno da Pavia a Milano (città vicino alla quale, a Monza, la moglie stabilì la propria nota dimora estiva), lasciando definitivamente la propria sede storica di Torino (di cui divenne duca il proprio figlio Arioaldo) che era costituita dalla Corte Ducale (la romana Curia Ducis, scelta quale proprio Palazzo, che si trovava nel sito antico degli edifici romani nella attuale zona del Parco Archeologico delle Torri Palatine), la sua consorte e regina Teodolinda ebbe facile agio a procedere in cospicui intervenenti nelle località di nuovo assetto del proprio reame.
Ed a Torino, il sito ducale agilulfiano di origine, da alcuni studiosi (come l’ingegnere torinese e romanziere storicistico Luca Buggio nel 2014, sulla base di precedenti indicazioni topografiche torinesi risalenti al primo-Settecento, e particolarmente provenienti dalla cartografia Torino – Città superba e forte, la Capitale del Piemonte elaborata nel 1700 dal cartografo tedesco Mattheus Seutten di Augusta, “geografo imperiale” di Carlo VI) era individuabile tra le Vie della Basilica e di Porta Palatina, come si ritrova riportato nella copia in italiano della Mappa Napoleonica di Torino del 1808 disegnata originariamente da Laurent Lombardi “Architetto Municipale”; mentre da altri autori (particolarmente lo storico torinese Riccardo Brayda, che nel 1890 ne scoperse il sito archeologico e ne descrisse le vicende storiche secolari) era riconosciuto nel vecchio Palazzo del Senato, parzialmente oggi conservato [Figure 28 e 29-30, e 31-32].

FIGURE 28 e 29-30 – Il sito dell’antico Palazzo Ducale longobardo a Torino nelle due ipotesi più accreditate: nella ricostruzione grafica effettuata nel 2014 dall’ingegnere torinese e narratore storico Luca Buggio (ripresa dalla mappa di Torino – Città superba e forte, la Capitale del Piemonte elaborata nel 1700 dal “geografo imperiale” di Carlo VI, il tedesco Mattheus Seutten di Augusta: la Corte del Duca è al Numero 6) [sopra], riportato anche (foto di Corrado Gavinelli del 2022) nel particolare della Mappa Napoleonica del 1808 (Piano della Città Imperiale di Torino e dei suoi Sobborghi, con i Nomi delle Vie e Numeri) “Disegnato da Laurent Lombardi”, cartografo “municipale” torinese, in cui il palazzo del Duca lomgobardo si ritrova collocato tra la Via della Basilica e la trasversale Croce d’Oro sulla area cittadina dell’allora cosiddetto Museum [sotto]; e quindi nella ubicazione riferita allo storico torinese Riccardo Brayda, scopritore nel 1890 del suo luogo archeologico di cui trattò la storia, che la ha ritenuta invece nella zona del vecchio Collegio dei Catecumeni (quale si vede nel dettaglio della Carta di Torino – Contesto – La piazza triangolare – segnata con la ellisse rossa, pubblicata nel 2022 da autore ignoto sul sito telematico AtlasFor) e dislocata sul vecchio sito della Casa del Senato (si vedano le Figure 31 e 32 ) [in basso] nelle odierne Piazza e Via IV Marzo (che sono state realizzate dopo il 1885 in base alle nuove leggi per la bonifica della città e dei centri antichi, tramite un piano di risanamento alquanto demolitivo e non restauratore come avveniva a quell’epoca per gli edifici fatiscenti)
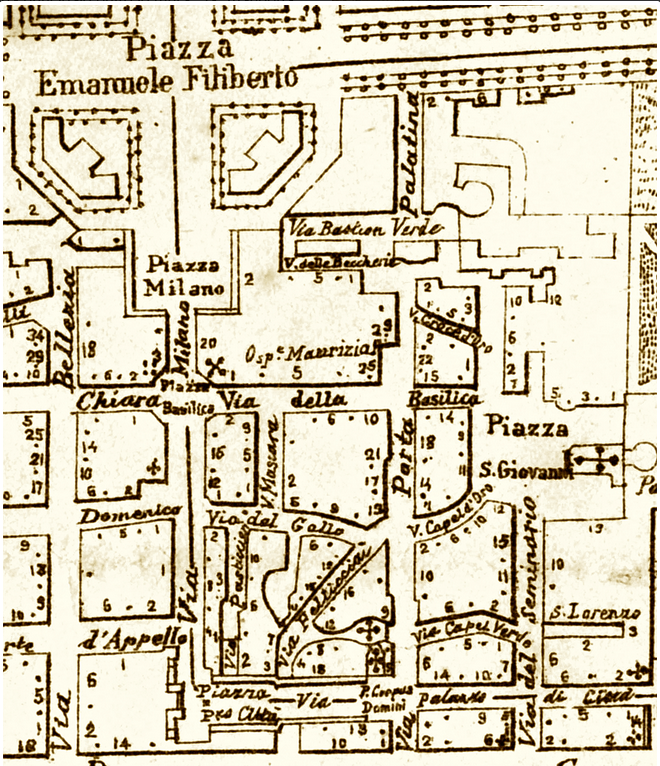
Figure 29 (sopra) e 30 (sotto)

 Figura 31
Figura 31
FIGURE 31 e 32 – Autore Ignoto della Agenzia AtlasFor, Piazza IV Marzo Torino – La Casa del Senato, 1998 [sopra], e Fotografo Anonimo della Agenzia Diciott di Torino, Casa del Senato, 2012 [sotto]. Dell’antico edificio senatoriale solamente la facciata medievale (la cui insolita altezza di quattro piani mostra tutta la importanza di caseggiato storico) è rimasta intatta nei secoli, e la foto di fine-Novecento ne mostra la evidente condizione di degrado. Nel 1890 il precedentemente citato Brayda, durante le demolizioni e ricostruzioni nel quartiere, rinvenì sotto le incrostature murarie degli intonaci sovrapposti nel tempo sulle pareti degli edifici, le forme medievali (e nel sottosuolo le fondamenta romane) della Casa del Senato, pesantemente danneggiata dalla incuria dei proprietari e dai bombardamenti della seconda guerra mondiale; cui di recente si è provveduto ad un opportuno restauro, per quanto parziale, tra il 2012 e il 2013 ad opera degli architetti torinesi Giorgio De Ferrari e Vittorio Jacomussi, che hanno completato il loro intervento con la aggiunta nuova di una torre postmoderna (decostruita sul genere del famoso progettista statunitense Frank Owen Gehry: l’architetto, per intenderci, del noto Museo d’Arte a Bilbao) in ricordo del torrione originale
 Figura 32
Figura 32
LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A TORINO
Ed avendo Teodolinda proclamato il santo battezzatore di Cristo (all’epoca competitore privilegiato nel culto cristiano-arcaico dei personaggi evangelici, perfino nei confronti della figura stessa di Gesù, in quanto considerato il Santo Precursore, avendo profetizzato l’avvento di Cristo ancòra prima della sua nascita) protettore dei Longobardi e quale patrono di Torino e di altre località varie, è plausibile – come viene dagli storici riportato – che proprio nel capoluogo piemontese dal 591-92 la regina avviò la costruzione iniziale dell’odierno Duomo torinese, che fece completare (nel suo primo assetto templare) nel 615. Della antica costruzione nulla rimane poiché i vecchi edifici vennero demoliti tra 1490 e 1492 per fare posto all’attuale cattedrale progettata dall’architetto rinascimentale Amedeo De Francisco da Settignano, detto Meo Del Caprino, iniziata nel 1491 e teminata nel 1498, con adattamento ulteriore proseguito fino al 1505 [Figure 33 e 34] (ed ampliata poi dal Seicento con varie integrazioni costruttive; tra cui …

FIGURE 33 e 34 – Due immagini (una attuale e l’altra più vecchia) del Duomo di Torino: in una foto del 2019 di autore sconosciuto con pseudonimo Eccekevin (raddrizzata prospetticamente da Corrado Gavinelli nel 2022) [sopra] ed in una cartolina d’epoca (Torino. – Cattedrale.) [sotto] eseguita nel 1885 dall’artista francese, di Parigi, Albert Quantin, incisore e litografo (riprendendola da un disegno dall’artista suo connazionale Henri-Jean-Guillaume Martin, che proprio nel 1885 soggiornò in Italia) [foto di Corrado Gavinelli del 2022]
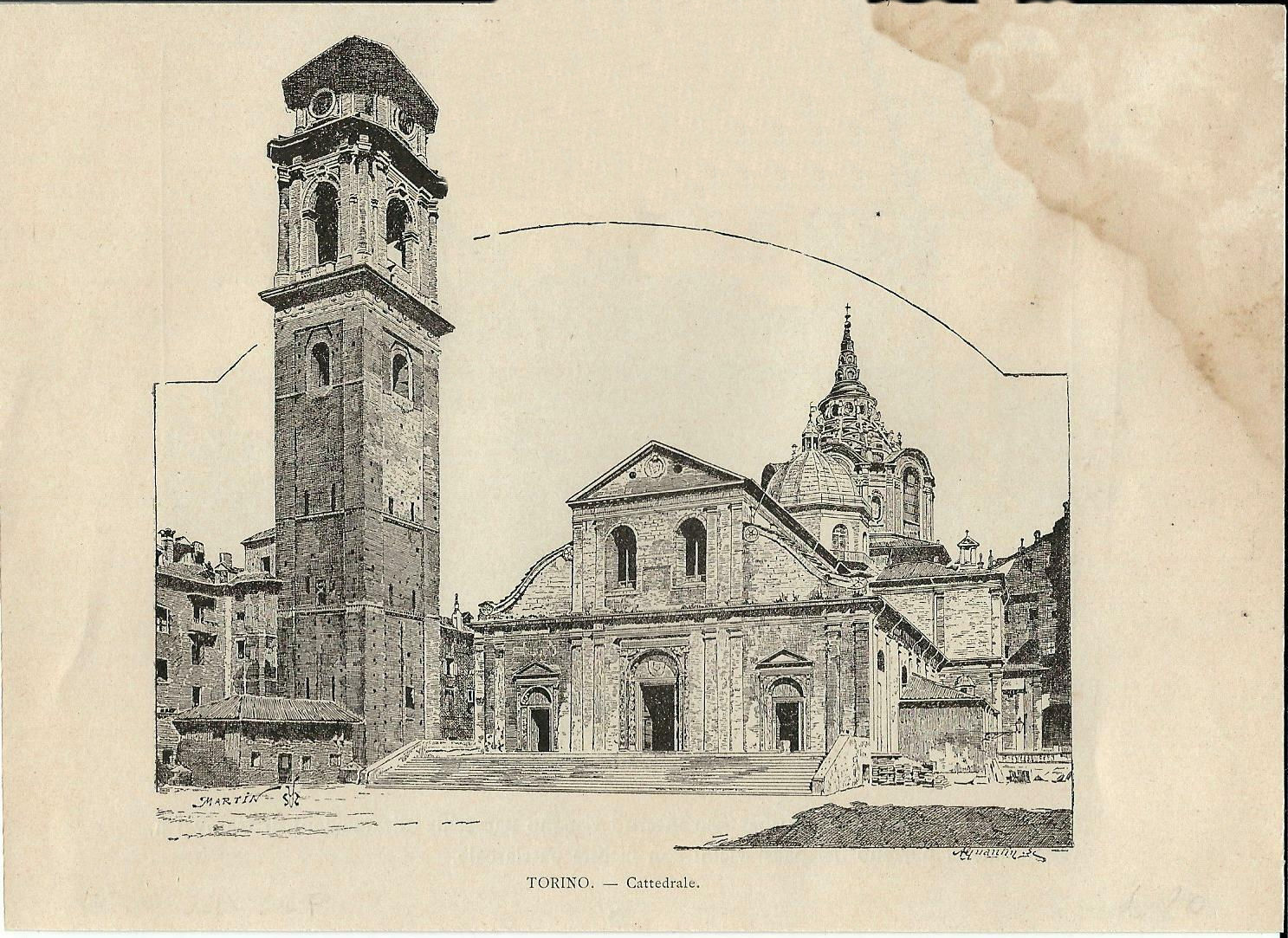
… la famosa Cappella della Sindone, iniziata nel 1649 dall’architetto Bernardino Quadri ma completata nel suo assetto finale dal sacerdote teatino modenese Guarino Guarini tra 1668 e 1683) [Figure 35 e 36].
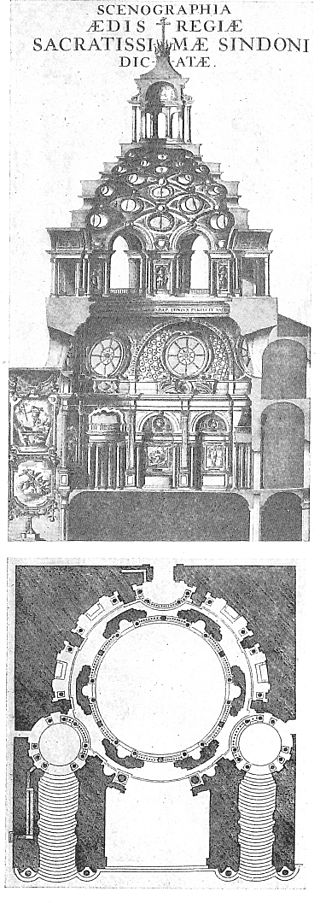 Figura 35
Figura 35
FIGURE 35 E 36 – Guarino Guarini, Cappella della Sacra Sindone, pianta e sezione, 1682 (incisione ri-stampata dal progetto originale del 1667) [sopra], e Autore Anonimo, La Cappella della Sindone nella sua visione esterna, di data sconosciuta [sotto]

Neppure si sa come potesse presentarsi complessivamente, dentro e fuori, la Chiesa sanbattistina all’epoca di Teodolinda, ma per la condizione del suo ruolo cittadino, o metropolitano, si può congetturare che si mostrasse nella forma semplice della basilica a croce latina, allungata, dovendo accogliere una quantità di fedeli molto più numerosa di una cappella.
Era dunque un organismo spaziale sul tipo delle chiese paleocristiane arcaiche, il cui aspetto plausibile proviene dai resti rinvenuti, in due scavi archeologici effettuati nel 1840 ed nel 1909, nella odierna area degli attuali San Giovanni e Palazzo Reale, che scoprirono tre antiche basiliche, disposte in sequenza e fisicamente attaccate lateralmente (le chiese del Salvatore, eretta dal 580 al 586; di San Giovanni Vecchio – riadattamento della cattedrale da parte di Teodolinda – del 592-615; e di Santa Maria De Dompno, realizzata tra 817 ed 827 quale Cappella Episcopale del vescovo torinese Claudio), sulla cui demolizione è sato costruito il quattrocentesco (ed ancòra odierno) duomo [Figure 37-39].
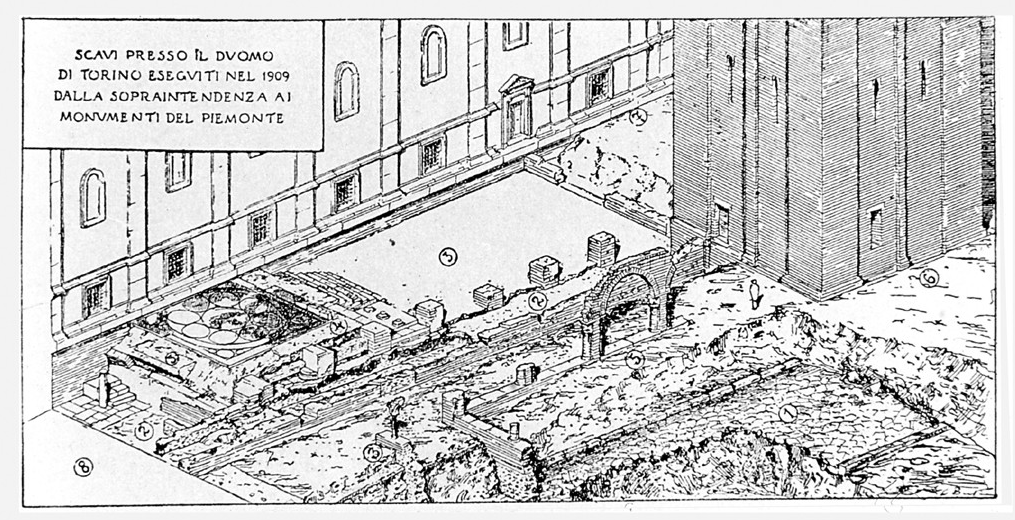
FIGURE 37-39 – Le cosiddette Tre Chiese, paleocristiane, esistenti sull’area del Duomo torinese prima della sua costruzione quattrocentesca: in un disegno assonometrico (Scavi presso il Duomo di Torino eseguiti nel 1909 dalla Sopraintendenza ai Monumenti del Piemonte) di Cesare Bertea, ingegnere dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Piemonte e della Liguria allora diretta dal pittore ed architetto Alfredo d’Andrade (il famoso costruttore del Borgo Medievale al Valentino in Torino), “emersi dalle demolizioni del 1899 e dagli scavi del 1900”) [sopra]; la terna di edifici ecclesiali prima della costruzione della odierna cattedrale di San Giovanni Battista (Le Tre Chiese antecedenti al Duomo in una foto anonima del Centro Archeologico di Torino del 2012: A Chiesa del Salvatore, B il vecchio San Giovanni, C Santa Maria De Dompno) [sotto], e la nuova basilica taurinense – Duomo di S. Giovanni Battista (1491-1498) – in un rilievo planimetrico del 2018 di autore anonimo della Associazione Culturale Landscapefor di Torino [in basso]
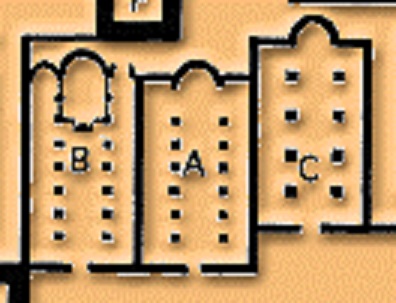 Figura 38
Figura 38
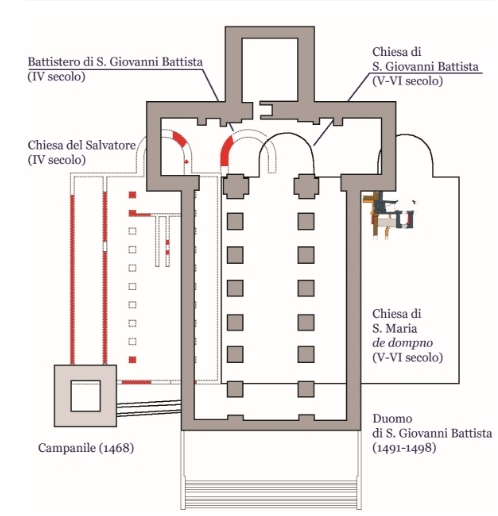 Figura 39
Figura 39
Il San Giovanni torinese dunque, come le altre sue due chiese attiguamente parallele, era composto da un semplice organismo latinamente cruciforme a pianta rettangolare absidata diviso in tre navate sorrette da uguali pilastri lapidei [Figura 38, Numero A].
LA CAPPELLA PALATINA A MONZA
Invece, diversamente dalla chiesa basilicale allungata a Torino, quasi contemporaneamente Teodolinda fece erigere a Monza una propria Cappella Palatina, e questa volta nella forma più compatta della croce greca di provenienza bizantina [Figura 45]: tipologia tradizionalmente impiegata nei templi palaziali, poiché tali impianti di culto non dovevano servire alla popolazione comune, ed erano di esclusivo uso, privato e concentrato, per i signori (ed eventualmente per le cerimonie della corte).
Nel borgo monzese, località – come accennato – dalla regina resa capitale estiva del Regno longobardo, questa cappella nuova dedicata anche essa a San Giovanni Battista, venne concepita come parte integrante del Palazzo Reale (che la sovrana fece costruire sempre insieme alla cappella), e poi a sua volta, nel procedere dei secoli, sarebbe stata inglobata, alquanto modificata, nell’impianto medievale del Duomo cittadino (come tuttora si può vederla).
In realtà si trattava di un Oracolo (ovvero Oratorio, nel senso di tempietto dove pregare) privato, realizzato tra 595 e 628, di cui rimangono pochi resti, a lato della abside della odierna basilica monzese ed addossati alla cosiddetta Torre Longobarda (un edificio stretto e alto, a doppio vano, appoggiato alle pareti esterne del duomo innalzato nel 1300-1346, di cui specificamente tratterò più avanti) [Figura 40].
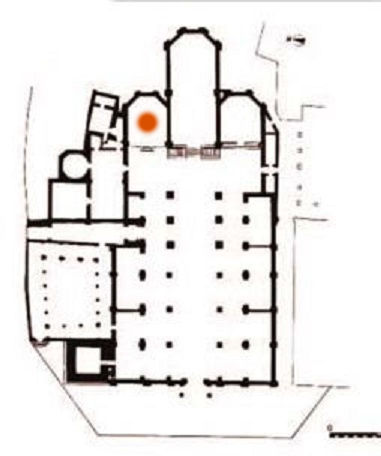 Figura 40
Figura 40
FIGURA 40 – Corrado Gavinelli, Il sito della Cappella di Teodolinda nell’odierno Duomo di Monza, 2022 (da una immagine – Basilica di San Giovanni Battista – del 2012 di Paolo Cecchellero, della Agenzia Telematica Animated Web di Milano: è però la planimetria del Duomo di Monza nella sua condizione attuale, con la Cappella teodolindica (segnata in pallino rosso) nella sua condizione non originaria e post-trecentesca
Un rimasuglio del suo aspetto fisico di epoca longobarda lo si ritrova nei disegni di rilievo che l’architetto milanese Luca Beltrami ha eseguito nel 1904 in sèguito agli scavi di ricognizione archeologica da lui effettuati tra il 1890 e il 1908 per i lavori di restauro dell’edificio (particolarmente applicati alla facciata, al sarcofago sepolcrale teodolindico, ed all’altare maggiore) [Figura 41]; con cui il restauratore milanese ricollocò il monumento tombale della regina (che alla morte della sovrana dei Longobardi – avvenuta nel 628 mentre ancòra la sua cappella non era terminata – era stato posto al centro della attuale navata sinistra, e poi trasferito nella odierna Cappella di Teodlinda nel 1308) durante i lavori iniziali di riedificazione del duomo nuovo (riponendolo definitivamente dove ancòra adesso si trova) [Figura 42].
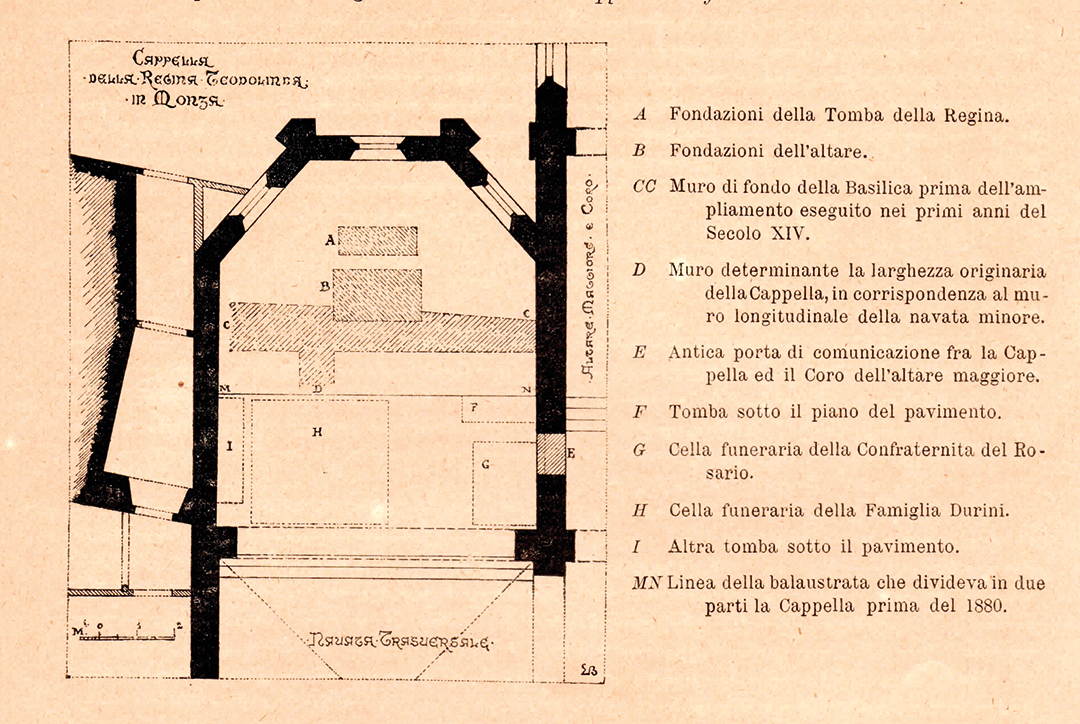
FIGURA 41 [sopra] – Luca Beltrami, Pianta della Cappella di Teodolinda con le strutture ricavate durante gli scavi, 1904. E’ la parte absidale del vecchio Oratorio teodolindico di epoca longobarda conservato dalla demolizione trecentesca effettuata per erigere il nuovo Duomo di Monza, rilevata dall’architetto-restauratore milanese durante le sue ricognizioni di risistemazione (foto di Corrado Gavinelli del 2022)
 Figura 42
Figura 42
FIGURA 42 – Pietro Majocchi, Il Sarcofago di Teodolinda – 1308, 2006. La sepoltura teodolindica, avvenuta in un avello sotto terra scavato nella vecchia abside della Cappella della regina come è stata identificata dagli scavi beltramiani, dietro il vecchio altare [si veda la Figura 40 alla Lettera A] viene disotterrata nel 1308 e riposta in un sarcofago collocato nella cappella di San Vincenzo nel transetto del costruendo nuovo Duomo monzese. Spostato ancòra due volte, finalmente la cassa tombale lapidea di Teodolinda viene sistemata nel 1890 nella cappella teodolindiana come la si ritrova ancòra adesso, sollevata su quattro colonnine granitiche, volute (e disegnate) dal Beltrami
Gli storici convenzionali del tempio monzese considerano la forma rimasta della attuale Cappella di Teodolinda (quella tramandata nei rilievi di scavo disegnata dal Beltrame, per intenderci) l’effettivo aspetto dell’originario tempio di San Giovanni voluto dalla regina longobarda. Ma in tale sua configurazione – alquanto planimetricamente differente dagli spazi centrali, a croce greca, prediletti dalla sovrana e tipicamente (tipologicamente) in uso a quell’epoca per questo genere di organismi ecclesiali – la sua conformazione presenta una esplicita incongruenza morfologica rispetto al modello longobardico, apparendo come un normale impianto di spazialità absidale, tronca al proprio ingresso, sagomata da una geometria di fondo con tre pareti poligonali (sicuramente riadattata negli interventi di ricostruzione della cattedrale successiva) [Figura 43].
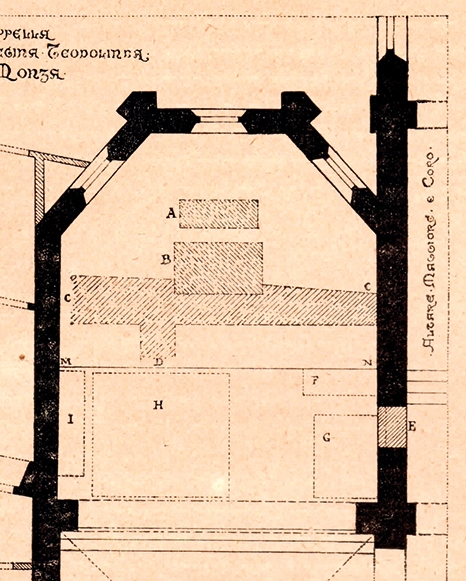 Figura 43
Figura 43
FIGURE 43-46 – La parte muraria rimasta della Cappella longobarda iniziale, nel particolare del rilievo beltramesco del 1904 [si veda la Figura 40], costituente la zona absidale dell’edificio originario [sopra]. Che nella sua configurazione antica doveva proseguire dentro l’attuale Duomo, secondo la figura da me ricomposta (Corrado Gavinelli, Ricostruzione dell’originario Oratorio di Teodolinda a croce greca, 2022) [sotto] nella sua possibile totalità di organismo spaziale basato su uno schema planimetrico greco-cruciforme ad abside tonda (Autore Anonimo, Basilica a Croce Greca, senza data) [in basso], e però conformata con le murature absidali smussate in tre tratti parietali (molto probabilmente ricomposta nelle trasformazioni trecentesche), nel modo in cui si evince dalla mia conseguente ricostruzione (Corrado Gavinelli, Ricomposizione dell’impianto cappellare teodolindico monzese con la parte del presbitero sagomata, 2022) [più in basso]
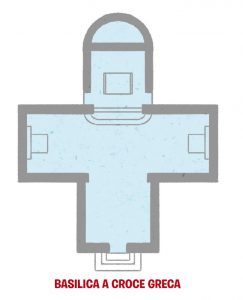 Figura 44
Figura 44
Figura 45
Figura 46
Questo ambiente cappellare invece, a mio parere, era diversamente conformato in una planimetria – poi parzialmente distrutta, e altrimenti trasformata – impostata secondo una completante croce greca che invadeva lo spazio della navata laterale destra della basilica trecentesca, ricavata dagli iniziali lavori di costruzione del nuovo edificio, nel 1306-07, ed evidentemente foggiata a cappella tradizionale per ospitare il sepolcro teodolindico da conservare [Figure 44-46].
Ma per valutare ancòra di più la sua condizione tipologica antica, e di tradizione bizantina, la si può idealisticamente ipotizzare – attuando una azzardata conformazione sofisticata della cappella ricomponendola in una estremizzata planimetria centrale ottogonalizzata [Figura 47], in un organismo circolar-smussato, di pura fantasia disegnativa ma utile per comporne
FIGURA 47 – Corrado Gavinelli, Ottogonalizzazione Idealizzata dell’Oratorio di Teodolinda nello schema tipologico caratteristico delle Cappelle Palatine antiche, 2022. Questa ricostruzione inventiva, puramente ideale, è stata da me eseguita per considerare la forma totalmente poligonale riscontrabile negli altri organismi cappellar-palaziali (si vedano le figure 48-51)
una comparazione figurale con gli organisnismi di questo genere ad impianto centralizzato dell’epoca, nonché precedenti e successivi, presenti nelle realizzazioni più note della storia della architettura antica e primo-medievale.
I quali rinviano alla centralità assoluta di altre cappelle palatine maggiormente antiche (come quella del più esemplare di quegli edifici, fatto erigere – nel 792-804/05, ad opera delll’architetto tedesco Ottone da Metz – da Carlo Magno ad Aquisgrana dentro il proprio Palazzo Reale [Figure 48 e 49], e rimandanti perfino
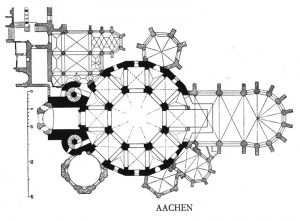
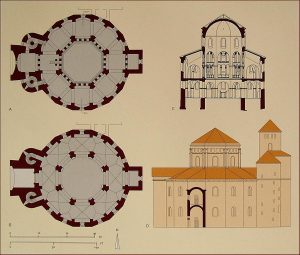
FIGURE 48 e 49 – La Cappella Palatina fatta costruire da Carlo Magno ad Aquisgrana dentro il proprio Palazzo Reale nel 792-804/05, ad opera dell’architetto tedesco Ottone da Metz, nella tipica forma ottagonale semplice (evidenziata in nero spesso nella generale Planimetria del Piano Terreno: di Autore Ignoto, Aachen, senza data) [sopra, a sinistra] e in un disegno di visualizzazione totale (Disegnatore Sconosciuto, Cappella Palatina di Aquisgrana, 2017) [sopra, a destra]
ai precedenti e più vecchi mausolei paleo-cristiani (quale è il bizantino-ravennate edificio di San Vitale, del 532-547) e tardo-romani (come la rotonda per Santa Costanza – la Costantina figlia dell’imperatore Costantino – a Roma, eseguita nel 337-351) [Figure 50 e 51].
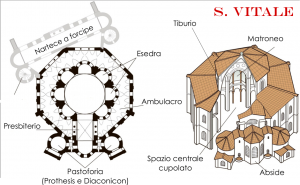
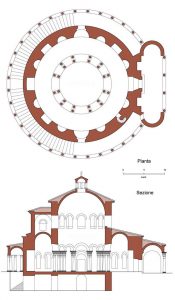
FIGURE 50 e 51 – Giacomo Campoli, Pianta della Basilica di San-Vitale, 2016 [sopra, a sinistra]; e Autore Anonimo della Agenzia ArchWeb di Roma (specializzata in restituzioni grafiche di architetture “dalla tipologia edilizia, al dettaglio architettonico”), Mausoleo di Santa Costanza, senza data [sopra, a destra]. La tipologia a pianta centrale delle cappelle palatine rimanda ai precedenti organismi architettonici paleo-cristiani, bizantini (come il San Vitale ravennate, edificato nel 532-547) e tardo-romani (Santa Costanza a Roma, ancòra in forma di rotonda circolare di tipo classico, che venne fatta costruire da Costantina, figlia dell’imperatore Costantino, nel 337-351)
Ma tra tutti questi modelli architettonici antichi, l’esemplare che più di altri, per morfologia tipologica soprattutto planimetrica, si può considerare vicino alla Cappella di Teodolinda, può essere il semplice ed arcaico Mausoleo bizantino di Galla Placidia costruito a Ravenna in una epoca di intermedia datazione storica (e comunque precedente di due secoli all’Oratorio teodolindico) rispetto agli altri edifici prima considerati [Figura 52 (e 53-54)], e

FIGURA 52 – Fotografo Anonimo con pseudonimo Currybet (ma Martin Belam), Ravenna, Italia – Mausoleo di Placidia, 2006
segnatamente edificato tra il 427 ed il 429 durante la reggenza placidiana (425-437) quale regnante in carica per la minore età del figlio Valentiniano. Composto in una contratta croce latina tendente alla centralità greca – ed inoltre con un impianto geometricamente sghembo rispetto alla regolare disposizione dritta, ortogonale, che i vecchi testi di storia hanno sempre tramandato con rilievi inesatti [Figure 53-54], la cui effigie di cristianità si riflette nel famoso cielo stellato della cupola realizzato a mosaico dentro la cappella [Figura 55] – questo …
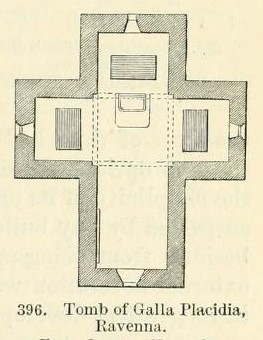
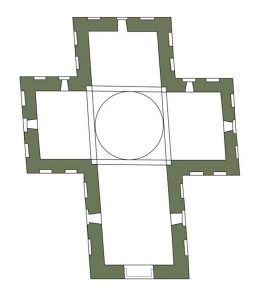
FIGURE 53-55 – Disegnatore Ignoto, Tomba di Galla Placidia, Ravenna, 1853 (immagine planimetrica ripresa da un disegno dell’architetto tedesco Alexander Ferdinand Von Quast del 1842, eseguita per il libro dell’architetto e storico scozzese James Fergusson, il Manuale Illustrato di Architettura, comprendente “un reendiconto conciso e popolare dei diversi stili architettonici prevalenti in tutte le epoche e nazioni”, pubblicato nel 1855 dallo stampatore londinese John Murray) [sopra, a sinistra]; Grafico Anonimo del sito telematico The White Page, Mausoleo di Gallia Placidia, senza data (ma dopo il 2018) [sopra, a destra]; e Charles Sturt, Cupola di Galla Placidia, 2019 [sotto]. La planimetria realizzata dal disegnatore fergussoniano riporta una impropia sagomatura, ortogonalizzata, secondo il criterio espositivo delle illustrazioni ottocentesche (Figura 53), che il rilievo del 2018 invece mostra nella sua reale immagine sghemba posta di traverso (Figura 54). Morfologicamente, la croce latino-greca della planimetria placidiana è la proiezione terrena del mosaico cruciforme cristiano intarsiato nel cielo del soffitto dell’edificio (Figura 55). Per la Cronaca, Galla Placidia era figlia di Teodosio detto il Grande (ultimo imperatore romano-antico) e sorella degli imperatori successivi Arcadio e Onorio; ed il suo monumento architettonico non era un edificio commemorativo, bensì una costruzione funeraria cristiana ad uso di tomba propria e famigliare, risalente al 427-429
 Figura 55
Figura 55
… eccezionale monumento tanto corposo e sobrio all’esterno (nei suoi nudi laterizi) quanto elaborato e particolareggiato dentro (con splendenti mosaici interni di ignoto artista ravennate), è stato in origine concepito (e come tale fatto costruire) dalla stessa regina per essere il sepolcreto proprio (e di suo marito Costanzo III co-imperatore di Occidente, nonché del fratello Flavio Onorio), che tuttavia non occupò mai: poiché, alla propria morte – nel 450, avvenuta a Roma – la salma della sovrana venne deposta nel Mausoleo Onoriano della città eterna (edificato per contenere i corpi defunti di Flavio Onorio, primo monarca del Sacro Romano Impero di Occidente, e dei suoi famigliari, presso la antica basilica di San Pietro).
Sull’aspetto edilizio effettivo della Cappella originaria di Teodolinda dunque, abbiamo visto che non esistono immagini di riferimento costruttivo accettabili, ma soltanto ricomposizioni congetturali; nonché alcune rappresentazioni figurative trasmesse dall’arte pittorico-scultorea, di configurazione però incerta (come appare nel dipinto dell’italiano Federico Faruffini – Agilulfo dona gioielli alla giovane Regina Teodolinda ed il modello del Duomo di Monza – del 1860) [Figure 56-57] se non decisamente erronea (quale si presenta il plastico preliminare della statua Teodolinda offre il duomo alla città modellato dagli scultori altrettanto italiani Luigi Secchi e Antonio Carminati nel 1890-91 [Figure 58-59]; perché la facciata
 Figura 56
Figura 56
 Figura 57
Figura 57
FIGURE 56-59 – Il modello della Cappella teodolindica nel particolare del dipinto del 1860 del pittore italiano Federico Faruffini Agilulfo dona gioielli alla giovane Regina Teodolinda con il modello del Duomo di Monza [sopra] e nel quadro intero [sotto]; e analogamente nel plastico preliminare della statua Teodolinda offre il duomo alla città modellato dagli scultori anche essi italiani Luigi Secchi e Antonio Carminati nel 1890-91 (dettaglio ed opera completa) [in basso e più sotto]. Queste immagini artistiche non possono venire però considerate del tutto corrispondenti filologicamente all’edificio teodolindico storico, perché non soltanto è probabile che l’Oratorio monzese fosse stato deciso dalla sola regina, indipendentemente dal marito sovrano, e la facciata della basilica nelle mani della statua di Teodolinda è di elaborazione più tarda (milleduecento anni) del periodo di costruzione della Cappella. Per inciso, mi devo scusare della scarsa nitidezza percettiva del plastico dipinto nel quadro faruffiniano, che non sono riuscito a trovare in una migliore definizione figurale (e che provvederò a sostituire con una immagine adatta quando sarò riuscito a reperirla)

Figura 58 [sopra]

Figura 59 [sopra]
cosiddetta a vento – chiamata con tale eufemismo in quanto appoggiata sulle navate frontali della chiesa – della basilica di Monza è stata realizzata molto più tardi della Cappella, nei lavori trecenteschi di rifacimento di tutto l’insieme ecclesiale: di cui – ho riferito – l’ultima sistemazione definitiva è stata attuata tra Ottocento e Novecento dal Beltrami, per i lavori del quale la immagine esecutiva del modello secchian-carminatiano è stato approntata) [Figure 60 e 61].
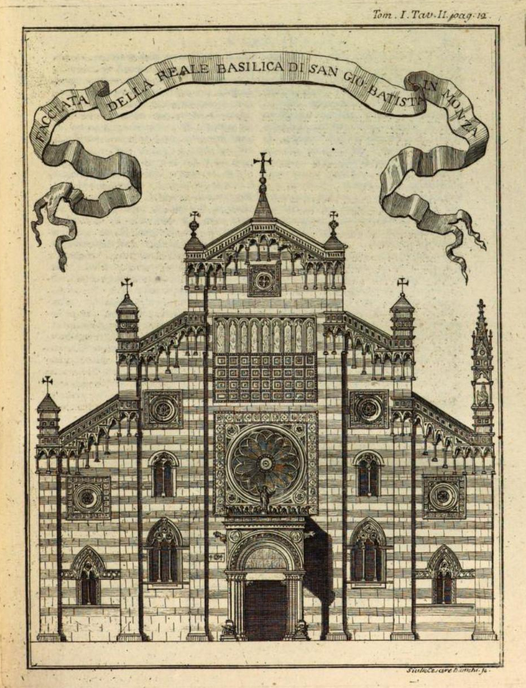 Figura 60
Figura 60
FIGURE 60 e 61 – Due immagini, vecchia e odierna, del fronte anteriore del duomo monzese in epoca gotica, nell’aspetto formale trecentesco che sostanzialmente possiede ancòra oggi senza eccessivi cambiamenti: nella incisione dell’artista monzese Giulio Cesare Bianchi del 1793 (Facciata della Reale Basilica di San Gio: Battista in Monza) pubblicata sul testo Memorie Storiche di Monza e sua Corte scritto dal Canonico del Duomo Anton-Francesco Frisi [sopra], confrontato con una foto odierna (Duomo di Monza del 2021) di David Persico [sotto]

Tornando quindi alla idea iniziale della costruzione della Cappella di Teodolinda originaria, quella eseguita prima delle sue trasformazioni avvenute con la esecuzione del duomo trecentesco (di cui nel ciclo delle Storie teodolidiane dipinte dagli Zavattari già ricordati esiste un eccellente affresco mostrante la Posa della Prima Pietra, che altro non è che la riproposizione sintetica di un tipico cantiere tardo medievale e quattrocentesco) [Figure 62 e 63], secondo la

FIGURE 62 e 63 – La scena della Posa della Prima Pietra del duomo monzese in un dipinto del 1445 degli Zavattari nella Cappella di Teodolind a a Monza [sopra]: il particolare con i muratori al lavoro [sotto] è però, sostanzialmente, la riproduzione di un tipico cantiere edilizio quattrocentesco (foto di Corrado Gavinelli del 2022)
 Figura 63
Figura 63
tradizione leggendaria la regina aveva promesso di erigere un tempio dedicato a San Giovanni Battista presso il proprio palazzo monzese, e attendeva una indicazione divina che le segnalasse la località più idonea per farlo. E partita per cercare “un luogo adatto” alla edificazione della sua cappella durante una battuta di caccia [Figure 64 e 65] nella piana
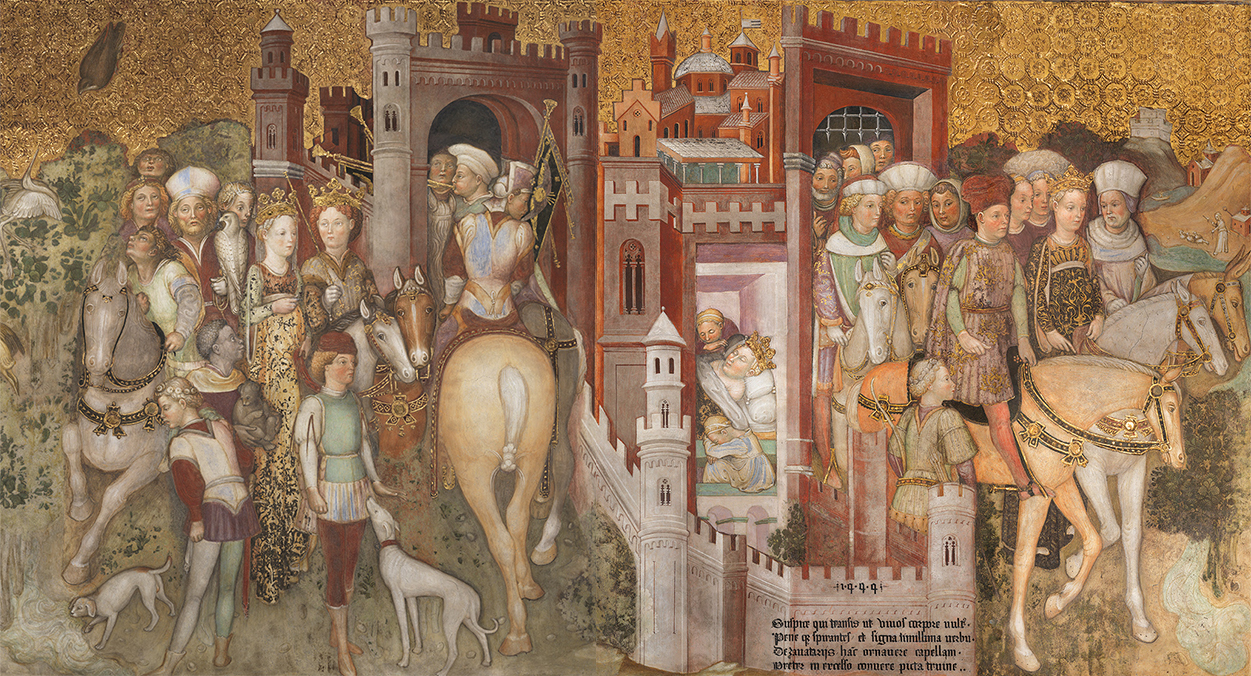
FIGURE 64 e 65 – L’affresco zavattariano mostrante la Partenza per la Caccia (a sinistra) e per cercare un “luogo adatto” dove erigere la Cappella di Teodolinda, nella sua estensione totale [sopra] e nel dettaglio della Regina con il proprio falcone venatorio [sotto] (foto di Corrado Gavinelli del 2022)

boschiva di Monza fitta di olmi (ma anche di querce e vigneti) sulle rive del fiume Lambro, sostando a riposare su una sponda di quel corso d’acqua, le apparve in sogno [Figura 66 (e 62)] una colomba – emblema dello Spirito Santo – [Figura 67]; che, fermatasi poco lontano da lei, le disse, in latino, “Modo” (ovvero Qui) cui solertemente la donna rispose “Etiam” (E sia), suggerendo così il sito sul quale costruire il tempietto (e per la cronaca, dalle due parole pronunciate dall’uccello e dalla sovrana, la consuetudine storica riporta che derivò il primo nome della città di Monza, anticamente chiamata Modoetia).


FIGURE 66-67 e 68 – Il Sogno di Teodolinda nel quale la sovrana longobarda riceve l’annuncio della colomba [sopra, a sinistra] nella sua sembianza iconograficamente convenzionale di Spirito Santo [sopra, a destra] confermante il sito fisico dove costruire la Cappella teodolindica (dettagli degli affreschi degli Zavattari), ed il tipico dolce lombardo a forma di colomba [sotto] (foto di Corrado Gavinelli del 2022)
 Figura 68
Figura 68
La colomba come specialità dolciaria di pasticcieria
E a proposito dell’uccello apparso in sogno alla sovrana longobarda, una altra tradizione, questa volta culinaria, tipicamente lombarda, ulteriormente si sovrappone alla leggenda teodolindana della sua visione onirica: si tratta della invenzione della Colomba Pasquale milanese, che sarebbe invece di origine monzese, in quanto risalente ad un particolare episodio riguardante il frate irlandese San Colombano sopra ricordato, solerte evangelizzatore del continente europeo e fondatore di monasteri (tra cui il suo più famoso, quello di Bobbio in Italia, voluto nel 614 al confine tra la Emilia-Romagna e la Lombardia, presso il Fiume Trebbia, su un esteso territorio donatogli proprio dalla Regina Teodolinda) che divenne uno di luoghi culturali più rinomati di allora (e dopo). Al quale predicatore la sovrana monzese era alquanto affezionata, religiosamente, in quanto egli era un sostenitore dell’anti-arianesimo e si era posto a mediatore della concezione dei cosiddetti Tre Capitoli di carattere nestoriano (affermante “la totale separazione delle due nature del Cristo, quella divina e quella umana”), considerata ufficiosamente eretica ma non condannata dal Papa (Gregorio Magno), che veniva seguìta dalla sovrana longobarda.
Questa leggenda teodolindico-colombana narra che nel 612, quando il frate dalla Svizzera scese in Italia per perorare in Vaticano la accettazione della propia regola monastica, sul tragitto per la capitale laziale i sovrani longobardi lo invitarono alla corte di Monza, coi suoi monaci al séguito, per onorarlo – come era di norma in queste solenni occasioni – con un sontuoso pranzo composto di abbondanti portate vegetali e di cacciagione. Ma considerando, quel banchetto, eccessivamente lauto ed esagerato per la moderazione cibaria perseguita dai frati, il futuro santo lo rifiutò; ma per evitare che Teodolinda si offendesse per quel brusco diniego, Colombano si inventò una scappatoia, chiedendo di benedire il pasto, e trasformando quindi tutti gli alimenti in colombe di pane.
In questa narrazione ovviamente inventiva (che per la prima volta venne riportata dal Frate Giuseppe Bernardino Burocco, monaco francescano monzese dell’Ordine Minore degli Osservanti, che ne scrisse nel 1729 sulla sua miscellanea di Fragmenti Memorabili – Dell’Imperial Città di Monza – Da vari libri historici, e diverse scritture antiche raccolti) risulta sostanzialmente che la Colomba dolciaria è di San Colombano.
Ed invece quella di Teodolinda è fatta riferire ad una diversa occasione, accaduta dopo la scoperta del luogo per la costruzione della propria Cappella, allorchè la regina, tornata al suo Palazzo monzese dopo avere trovato il luogo su cui erigere la propria Cappella, decise di offrire un pranzo di festeggiamento ai suoi cortigiani, comprendenti dolci conclusivi a forma di colomba, farciti con pezzi di frutta all’interno e ricorperti di mandorle in superficie: in quella stessa confezione che ancòra oggi riconosciamo nel tipico uccello pasquale [Figura 68].
E però, per complicare ancòra di più i fatti (o i miti), esiste anche una precedente versione pasticciera a riguardo della colomba dolciaria, risalente al 572, e che sembrerebbe – narrativamente – la più accettabile: perchè questa cronistoria fa risalire l’origine del dolciume in forma colombare alla iniziale epoca longobarda di Re Alboino, in riferimento al fatto che egli, valicate le Alpi, intraprese la propria guerra di conquista della Italia assediando Pavia, e conquistando la città dopo tre anni di blocco dall’esterno; e che i Pavesi, per evitare la furia degli assalitori, fecero loro il dono di soffici dolci dall’aspetto di colomba, come gesto di pace (in ricordo dell’uccello biblico del diluvio universale). Un gentile atto di considerazione verso il nemico vincitore, che – sempre stando alla leggenda – fece evitare il truce saccheggio della città e condusse Pavia ad essere nominata capitale del nuovo regno dei Longobardi.
Ad ogni modo, indipendentemente da tutto, questa primizia lombarda – di originaria confezione monzese o pavese – resta sempre una indiscussa tradizione antica di matrice longobarda.
E del suo contenuto figurativo non si deve trascurare tutto il riferimento semantico-religioso che appartiene all’altrettanto leggendario columbide chiaramente rinviante al mito della Arca di Noè nel ritrovamento della terra inondata da riabitare; ma anche (soprattutto per la quercia e la vite ad essa avvinghiata di cui scrive la narrazione del Burocco) alle credenze pagane nordiche dei druidi e dei sacerdoti celti di atavico ricordo anglo-germanico, ed alle pratiche sciamaniche ancòra più antiche degli aruspici classici che interpretavano il volo degli uccelli: dei quali la Teodolinda si fa partecipe e trasformatrice complessiva – quale sacerdotessa laica, ma di rango regale – di un cerimoniale sacro di fondazione per la propria cappella, in veste di più cristianizzata ritualità.
Infine, questa particolarità cibaria nell’aspetto di volatile, prima inesistente nei pranzi regal-nobiliari della Italia settentrionale, cominciò a sostituire il dolce convenzionale nei pasti medievali, alla cui conclusione esso veniva dato sotto forma di confetti, o piccoli pasticcini delicati ovoidali (come gli stessi Zavattari hanno delineato nel loro affresco raffigurante il Banchetto di Nozze tra Teodolinda ed Agilulfo) [Figure 69 e 70], e non nella forma del grosso e gonfio impasto colombare inventato da Colombano, fatto preparare da Teodolinda, o prodotto dai cittadini pavesi.

Figure 69 e 70 – Il Banchetto di Nozze (dipinto dagli Zavattari nella Cappella di Teodolinda del Duomo di Monza) con i dolci a forma di pasticcini (biscotti tondi) o di confetti, in uso nei pranzi delle persone benestanti nel Medioevo: sulla tavola imbandita [sopra] e nel dettaglio dei dolciumi [sotto] (foto di Corrado Gavinelli del 2022)

Una variante cibaria di uccellagione comunque insolita, che differentemente si collega alla più consueta portata avicola della cacciagione, o degli uccelli di allevamento domestico, di cui il Tesoro dei gioielli teodolindici testimonia esemplarmente nel famoso gruppo scultoreo in argento dorato e gemme preziose della Chioccia con Sette Pulcini: capolavoro di arte bizantina creato tra il 596 ed il 607 da un ignoto cesellatore; e la cui immagine – che pertanto risulta piuttosto importante – compare addirittura raffigurata tra i doni offerti dalla regina a San Giovanni Battista nel rilievo della Lunetta del Portale del Duomo realizzata nel 1319/20-45 – [Figure 71 e 72-74], nella caratteristica portata prandiale maggiormente apprezzata sulle tavole imbandite dei nobili signori del Medioevo.
 Figura 71
Figura 71
FIGURE 71-74 – Uno dei più curiosi oggetti preziosi appartenenti al cosiddetto Tesoro monzese (l’insieme delle ricchezze dei monarchi longobardi, di proprietà o ricevuti in dono): la Chioccia con 7 Pulcini, di cesellatore bizantino ignoto, realizzata tra il 596 ed il 607 [sopra]. Opera composita di gioielleria di grande importanza per Teodolinda, tanto da venire raffigurato (insieme alla Croce di Berengario e alla Tazza di Zaffiro che la regina usò al suo matrimonio con Agilulfo) nella Lunetta del Portale del Duomo di Monza [in basso]. Questa ultima scultura a bassorilevo eseguita nel 1319/20-45 da un lapicida campionese anonimo diretto da Matteo da Campione, è riportata nel particolari al vero del portone monzese [sotto, a sinistra] e in una copia artistica di riproduzione – Basso-rilievo – disegnata e incisa nel 1829 dall’artista Francesco Roberti di Bassano) [sotto, a destra]

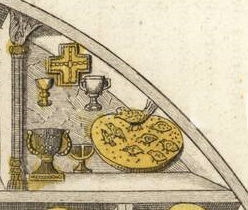

IL PALAZZO REALE ESTIVO A MONZA
Come già indicato, accanto all’Oratorio di Teodolinda la regina monzese fece erigere nel 595-602/03 anche il suo (e del consorte Re Agilulfo ovviamente) Palazzo Reale estivo (cui già il predecessore – Flavio Teodorico il Grande, Re degli Ostrogoti nel 474 e sovrano del Regno ostrogoto in Italia dal 493 al 526 – aveva cominciato ad erigere per la favorevole condizione climatica di cui a suo parere godeva la decentrata Monza, nella campagna selvatica del Lambro: come ha riportato lo storico dei Longobardi Paolo Diacono (autore di una consistente Historia Langobardorum in 6 volumi, scritti piuttosto velocemente tra il 787 ed il 789), “perché la zona, vicina alle Alpi, è temperata d’estate e salubre”, e comunque certamente più mite di quel rigido clima centro-europeo della Pannonia da cui Teodolinda era originaria, e da cui venivano le stesse tribù barbare ostrogoto-longobarde).
Anche di questo antico edificio non rimangono resti, essendo esso stato demolito per la costruzione del duomo trecentesco, se non nella sola modesta (ma che un tempo era più elevata) Torre Longobardica (risalente al 599-602) addossata alla Cappella di Teodolinda (e strettamente incastrata tra questa e le contigue parti edilizie [Figura 75, 76 (e 41), 77 (e 88) e 78].
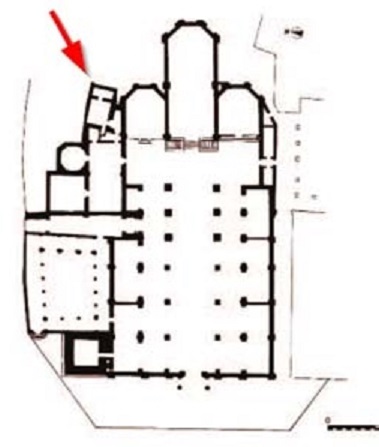 Figura 75
Figura 75
FIGURA 75 – Paolo Cecchellero (della Agenzia Telematica Animated Web di Milano), La Basilica di San Giovanni Battista, 2012. La Torre Longobardica (risalente al 599-602) addossata alla Cappella di Teodolinda (indicata con la freccia rossa) risulta però inesatta nel suo troppo regolare impianto rettangolare (e in realtà si trovava proprio incuneata nell’interstizio spaziale dell’edificio segnato e la chiesa, come si vede nella Figura 76)
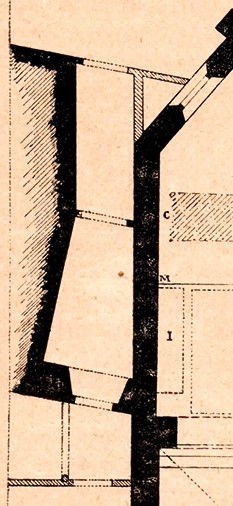 Figura 76
Figura 76
Figura 76 – La Planimetria della Torre Longobarda a Monza, nello stralcio del disegno di rilievo del Beltrami eseguito nel 1904 per la Cappella della Regina Teodolinda in Monza (si veda la Figura 41)
 Figura 77
Figura 77
FIGURA 77 – La forma scomposta del volume esterno della torre longobarda monzese nel dettaglio di una incisione (Il lato settentrionale della Basilica) di autore non riconosciuto (perché non dichiarato e per la sua firma incomprensibile) e non datata, pubblicata per il libro Descrizione Storica della Basilica di S. Giovanni Battista in Monza dello storico monzese Luigi Modorati, senza data (ma probabilmente del 1912, in quanto il volume è stato stampato “a beneficio dell’erigenda cappella comune nel cimitero urbano”) [si veda la Figura 92]
 Figura 78
Figura 78
FIGURA 78 – La antica torre monzese nella sua parvenza volumetrica della sua condizione odierna (al 2021) in una foto di Alberto Mos (Monza Duomo Abside)
Il suo aspetto planimetrico è stato – come già riferito – rilevato nel 1904 dall’architetto Luca Beltrami a séguito dei suoi scavi archeologici anche essi precedentemente descritti [Figura 41 (E 76)], e però già prima – nel 1831, e dallo storico monzese Augusto Merati – completamente disegnata nella propria parvenza tridimensionale di rudere rimasto [Figure 79-80]. In una foggia lasciata con una possibile maggiore elevazione (che doveva …
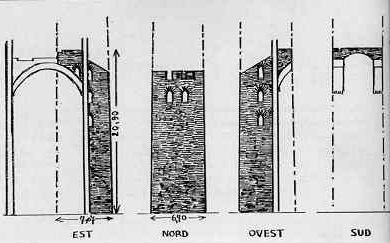 Figura 79
Figura 79
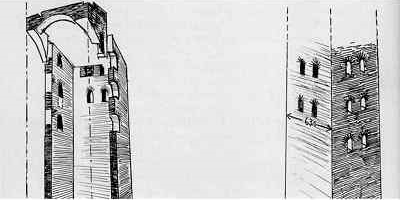 Figura 80
Figura 80
FIGURE 79 e 80 – La torre del Palazzo Reale di Monza nei disegni di rilievo e ricostruttivi del 1831 dello storico monzese e archeologo Augusto Merati (che mostrano il rudere rimasto: nei Prospetti dei Quattro Lati – Est Nord Ovest Sud – [in alto] e nelle Assonometrie dello Spaccato Interno e dell’Aspetto Esterno [in basso]
… raggiungere i 21 metri) [Figura 81], come è stata altrimenti rappresentata anche in uno schizzo ricostruttivo sempre di esecuzione meratiana (Il Borgo di Monza nel XIV secolo) [Figure 82 e 83], riportante la conformazione monumentalmente essenziale della località monzese alla fine del Trecento, osservabile nel suo passato assetto medievale di epoca …
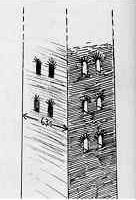 Figura 81
Figura 81 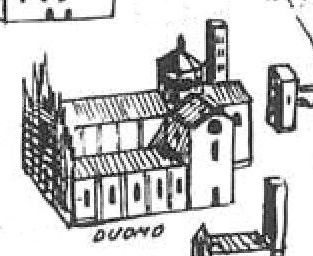
FIGURE 81 e 82-83 – La torretta longobarda (nello stralcio del disegno meratiano precedente) [sopra, a sinistra] con i segni della possibile elevazione maggiore (che doveva raggiungere i 21 metri) come si vede nel dettaglio dello schizzo di ricostruzione [sopra, a destra] del contesto monzese alla fine del Trecento (Il Borgo di Monza nel XIV secolo) elaborato sempre dal Merati e nel 1831 (foto di Corrado Gavinelli del 2022) [sotto]. Questo assetto monzese di epoca gotica evidenzia la Cappella Ottagonale teodolindica ancòra non inserita nel Duomo – fatto che avvenne nel 1396-98 – e la retrostante Torre Longobardica invece a tutta altezza, essendo essa, tra 909 e 911, stata adattata a campanile, nel suo svettante slancio verticale originario prima della parziale riduzione, sopraggiunta nel 1394-95
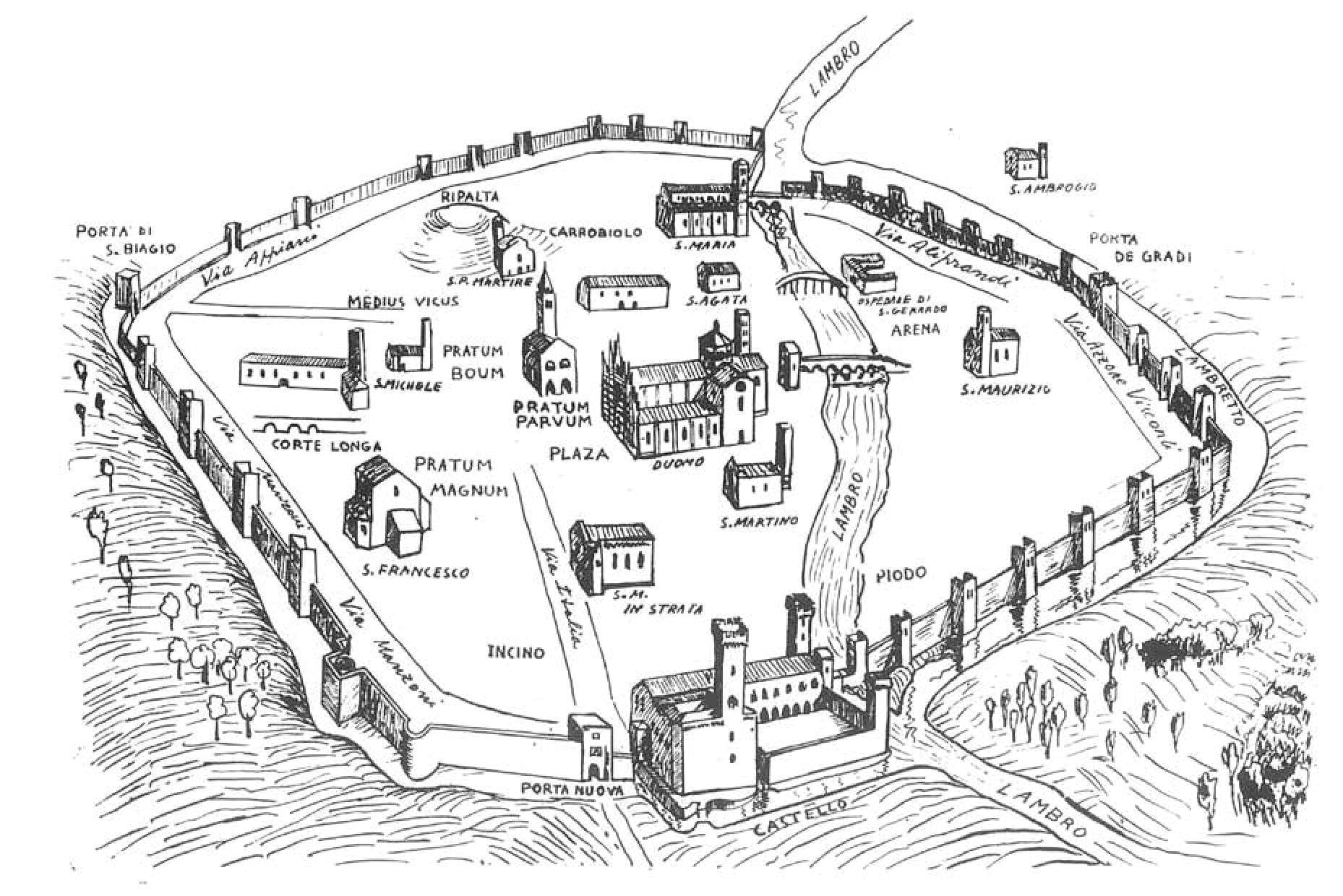
… gotica (ancòra con la Cappella Ottagonale teodolindica non inserita nel Duomo – fatto che avvenne nel 1396-98 – e con la retrostante Torre longobardica, che dal 909 al 911 era stata adattata a campanile, nella sua svettante altezza originaria prima della propria parziale riduzione, sopraggiunta nel 1394-95), in una generale composizione antica non più ritrovabile nelle mappature successive (tanto in quelle topograficamente approssimate – quale si mostra la Monza dell’ingegnere-architetto Pietro Antonio Barca del 1615 disegnata per il controllo funzionale dei mulini monzesi sul Lambro – quanto in quelle più misurativamente precise del Catasto Teresiano del 1720/21-22, o della Monza del Tenente Giovanni Brenna del 1849-50: queste due ultime mappature entrambe bene specificate, e soprattutto quella brennana, ma decisamente non proprio corrispondenti alla effettiva situazione esistente del costruito dietro al Duomo)[Figura 84 e 85-86].

FIGURE 84-86 – La restituzione topografica del borgo monzese nella mappatura approssimata del Seicento (in un disegno sintetico a schizzo – Monza – dell’ingegnere e architetto del Ducato di Milano spagnolo Pietro Antonio Barca del 1615 rappresentante i lavori lungo il corso del Lambro ai Mulini comunali) [sopra] e nella cartografia moderna più precisa (nella ricomposizione attualizzata del Catasto Teresiano – Analisi dell’edificato del centro di Monza al 1722 – eseguita dall’architetto pavese Massimo Giuliani per il Piano di Governo del Territorio del Comune Monza del 2010-16) [sotto] nonchè nella cartografia di Monza stampata nel 1849-50 dal “Tenente Ingegnere Geografo in pensione” Giovanni Brenna che “rilevò dal terreno, disegnò e diresse” nel 1836 con aggiornamento del 1842) [in basso]. Nelle due ultime mappature però la situazione edilizia dei resti teodolindici viene riportata con generica restituzione, mostrando il retro della basilica senza inerenti specificazioni edilizie
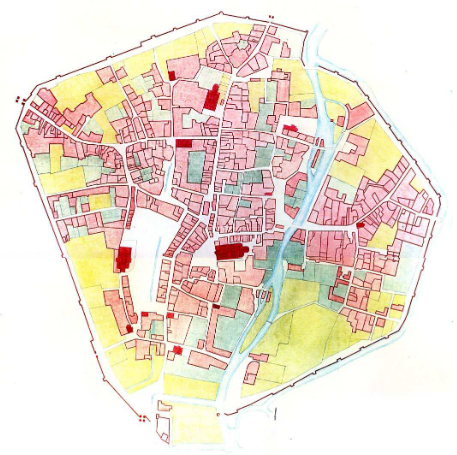 Figura 85
Figura 85

LA CAPPELLA DELLA REGINA TEODOLINDA A MONZA NEI DIPINTI ZAVATTARIANI
E’ nella ormai famigerata Cappella di Teodolinda che si ritrovano tutti gli aspetti, fatti e leggende, della vita di questa regina altrettanto famosa, narrati pittoricamente da un eccezionale ciclo di affreschi che costituiscono non solamente un puntuale riporto degli episodi sostanziali della esistenza della sovrana longobarda, ma anche una diretta testimonianza di tutta una serie di condizioni sociali d’epoca nella realtà lombardo-gotica del Quattrocento.
Voluta nel 1441 dall’ultimo Duca di Milano della dinastia viscontea, Filippo Maria Visconti, per sancire la propria discendenza femminile (non avendo egli lasciato figli maschi o di altro genere, nominando però la propria figlia naturale Bianca Maria sua erede legittima, andata sposa in quell’anno a Francesco Sforza, “condottiero di compagnia di ventura” e futuro iniziatore di una altra importantissima dinastia ducale milanese-lombarda), e dare del suo regno una sensazionale immagine d’arte, l’intera opera venne affidata ai più prestigiosi pittori regionali dell’epoca, che realizzarono uno stupendo insieme di pitture storiche, giustamente considerato uno dei capolavori dell’arte tardo-gotica internazionale.
I protagonisti di questi lavori, appartenenti alla rinomata famiglia lombarda degli Zavattari (il cui capostipite Cristoforo, pittore e maestro vetraio, è segnalato dal 1407 al 1409, e suo figlio Franceschino si ritrova documentato dal 1417 fino al 1453 nella realizzazione delle vetrate del Duomo di Milano) sono convenzionalmente ritenuti il suddetto Francesco con i suoi due figli (Gregorio e Giovanni), artisti attivi nel territorio milanese per tutto il Quattrocento; ma in una Guida di Monza e circondario del 1897 scritta dagli storici monzesi Zaccaria Lucchini e Giuseppe Riva viene menzionato anche – tra gli “Autori della grande pittura murale” delle scene della vita teodolindica – l’artista locale “Troso da Monza”, citato pariteticamente agli Zavattari nei lavori della cappella ma poi però completamente omesso, e dimenticato, dalla critica artistica successiva.
Forse perché questo pittore monzese era meno noto (e meno stilisticamente completo degli altri esecutori) o magari in quanto più considerato da aiuto degli affrescatori incaricati o come specializzato realizzatore di parti compendiarie e di corollario, quali decori e completamenti figurativi (essendo di lui nota la capacità di esecuzione prospettica e per le partiture a grottesca). Ma anche perché, con precisione, della trosoina attività operativa agli affreschi zavattareschi non si riesce con certezza documentata (sebbene la si possa individuare nei tratti disegnativo-formali di certe parti dei dipinti) a riconoscere la sua mano, e distinguerla dalle esecuzioni propriamente zavattariane.
In realtà questo artista (altrimenti chiamato Troso di Giovanni Jacobi o anche De Medici per la sua appartenenza famigliare) sembra non essere di Monza, essendo nato a Lodi e mai ritrovato attivo nell’àmbito monzese se non nella sporadica partecipazione, oltre agli affreschi della cappella teodolindica, a minuti lavori vetrari del duomo (ed in particolare – e soltanto – le opere di vetrata nei tondi degli spicchi, chiamati gergalmente antelli, del Rosone della facciata della basilica monzese) [Figura 87]. Una circostanza operativa che forse ha portato a confondere il lavoro vetrario del Troso con la contemporanea affrescatura che si stava titanicamente svolgendo sulle pareti della cappella della regina longobarda.
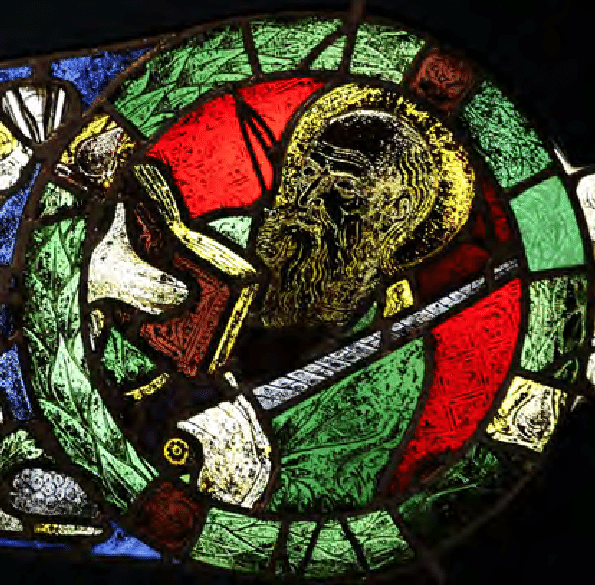
FIGURA 87 – Troso di Giovanni Jacobi (detto Da Monza, ma impropriamente, perché invece era di Lodi), San Paolo, 1395. E’ uno dei tondi istoriati in vetro colorato inseriti negli spicchi di vetrata (chiamati Antelli) del Rosone del Duomo monzese, realizzato da questo mastro vetraio (che ha collaborato agli afffreschi teodolindici degli Zavattari essendo anche pittore)
Ma può anche darsi – voglio aggiungere io e suggerire criticamente – che la parte di attuazione pittorica fornita all’opera zavattarina dal Troso si possa riscontrare nelle scene di rappresentazione paesistico-urbana (essendo per altro la specializzazione trosoesca rivolta alle raffigurazioni prospettiche), evidenziatamente alquanto diverse (schematiche e rozze, di maniera ancòra tradizionalmente medievale nella loro esecuzione dimensionalmente irreale e prevalentemente assonometrica) dai dipinti degli Zavattari, invece più riconoscibilmente rinascimentali, e connotate da rifinite immagini di persone e animali realizzati con matura conformazione rinascimentale [Figure 88 e 89 (e 64 e 154-55)].

FIGURE 88 e 89 – Due immagini di definizione prospettica dell’ambiente cittadino dipinte sullo sfondo, ed a contorno, delle raffigurazioni degli Zavattari nella Cappella di Teodolinda a Monza, attribuibili al lavoro del Troso, indicato dalle cronache medievali quali esperto di raffigurazione architettonica: la parte edilizia fortificata nella Scena 32 (della Partenza della Regina alla Ricerca del Luogo Adatto per la costruzione della propria Cappella palaziale monzese) il cui confronto iconografico con la scena delle figure umane ed animali non solo appare sottodimensionata oggettivamente rispetto alle misure vere, ma si presenta anche piuttosto schematica e rozza, e delineata assonometricamente anziché in prospettiva [sopra], e lo sfondo con una città della Scena 26 (dell’Incontro di Teodolinda e Agilulfo a Lomello) di analogo trattamento tecnico formale [sotto]. Entrambe queste raffigurazioni paesistiche si mostrano alquanto diverse dalle altre sagomature più realistiche, e prospettiche (ovvero a tutto tondo), delle immagini zavattariane, e portano a pensare che siano opera dell’ancòra tardo-gotico artista lodigiano, pittore di non piena padronanza tecnica rinascimentale
 Figura 89
Figura 89
LA IMMAGINE FISIONOMICA DI TEODOLINDA
Nella racchiusa conca pittorica del luogo teodolindico, composto da una absidatura tri-poligonale ancòra chiaramente visibile dall’esterno [Figure 90-92], e da due pareti laterali interne protese verso le navate della chiesa, in un maestoso e sontuoso spazio dipinto

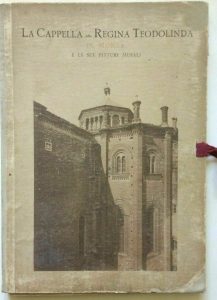
FIGURE 90-92 – La situazione attuale della Cappella teodolindiana osservata dall’esterno (foto di autore anonimo – ma forse Alberto Mos – senza data, e probabilmente del 2011), nella sua riplasmatura attuata nel 1396-98 [sopra, a sinistra]; un simile scorcio della torre in una immagine del milanese Carlo Fumagalli (fotografo di arte e di architettura) del 1890 utilizzata per il volumetto di Luca Beltrami su La Cappella della Regina Teodolinda in Monza e le sue pitture murali pubblicato nel 1891 (si vedano le figure 41 e 43) [sopra, a destra]; e Il lato settentrionale della Basilica del 1897 eseguito da autore non riconosciuto più sopra citato, pubblicata sul libro di Luigi Modorati Descrizione Storica della Basilica di S. Giovanni Battista in Monza, non datato (ma probabilmente del 1912 in quanto il volume è stato stampato “a beneficio dell’erigenda cappella comune nel cimitero urbano”) [sotto], in cui la Torre Longobarda si riconosce, scompostamente coperta da due tetti sbiechi (perché la planimetria dell’edificio è alquanto irregolare nel suo appoggio alla Cappella di Teodolinda: si veda la Figura 76) tra la chiesa ed il caseggiato retrostante davanti al campanile (foto di Corrado Gavinelli del 2022)
 Figura 92
Figura 92
su ogni propria parte [Figure 93-94 e 95], i lavori degli Zavattari vennero realizzati dal 1441 al 1446 in due non interrotte fasi successive intramezzate dall’anno 1444 …


FIGURE 93-94 e 95 – Due immagini di interno (entrambe di fotografo anonimo del Museo e Tesoro di Monza del 2016) della odierna sede cappellare teodolindica nel Duomo monzese (la Cappella di Teodolinda vista verso l’Altare e l’Abside [sopra], ed una parziale Veduta Generale degli affreschi sulle pareti laterali [sotto]: questa ultima con raddrizzamento prospettico di Corrado Gavinelli del 2022); nonché una visione totale panoramica (mostrata con le pareti disposte di sèguito su una sola superficie piana) del Rilievo Fotogrammetrico eseguito nel 2009 dal tecnico-grafico Massimo Silenti [in basso] proprio per seguire con precisione visiva il ripristino pittorico delle raffigurazioni effettuato tra 2010 e 2015 dalla restauratrice milanese Anna Lucchini. L’Oratorio cappellare, dipinto in due riprese (non interrotte e continuative) tra il 1441-44 e il 1445-46 dagli Zavattari, stirpe di pittori milanesi (ideatore del progetto è stato Franceschino Zavattari, mentre gli esecutori pratici furono i figli – e dunque chiamati i Fratelli – Giovanni, Gregorio, e Ambrogio), che rappresentarono la vita di Teodolinda in quarantacinque scene accostate e sovrapposte. La traccia narrativa si basa sulla Storia dei Longobardi del cronista di Cividale del Friuli Paul Warnefried (più noto con il nome latinizzato Paolo Diacono) scritta in 6 libri tra 787 e 789, ma elaborata secondo i criteri illustrativi a riquadri compatti della letteratura romanza della cultura curtense medievale. Il ciclo dei dipinti, chiamato Storie della Regina, viene considerato dagli studiosi di arte medievale come uno dei massimi capolavori della pittura del gotico internazionale, non sotanto per l’Italia. Gli affreschi ovviamente non costituiscono una restituzione ricostruttiva oggettiva delle vicende teodolindiche, bensì – come era in uso nella pittura dell’epoca e rinascimentale – una loro raffigurazione nelle forme convenzionali dei costumi del periodo in cui sono state dipinti, ovvero della metà del Quattrocento, quando quelle opere furono eseguite: fornendo così una immagine estremamente vivida di come dovesse svolgersi la vita alla Corte milanese dei Visconti – casato che commissionò la Cappella – che per altro era riconosciuta come una delle più sfarzose dell’intera Europa

… (la cui datazione appare nella trentaduesima scena del ciclo di affreschi raffigurante la uscita dei cortigiani per la caccia e la partenza alla ricerca di un “luogo adatto” ove costruire l’Oratorio di Teodolinda) [FigurA 96 (e 88 e 64].
 Figura 96
Figura 96
FIGURA 96 – La data di esecuzione (1444) del riquadro raffigurante la ‘Uscita per la Caccia’ di Teodolinda, scritta nella parte basamentale dell’affresco in perfetti ed eleganti caratteri gotici, con la quale viene affermata la paternità dei dipinti fino ad allora eseguiti (“Gli De Zavattarii adornarono questa cappella”) a partire dal 1441 (foto di Corrado Gavinelli del 2022)
Il racconto iconografico degli affreschi si sviluppa, concentrato ed affollatissimo di figure e dettagli, nella descrizione sequenziale di vari episodi, importanti e aneddotici, riguardanti la persona teodolindica e quanto attorno le concerne, culminante – figurativamente – nella maestosa apoteosi del suo Incoronamento, che la stabilisce Regina dei Longobardi, e sovrana insieme al marito [Figura 97].
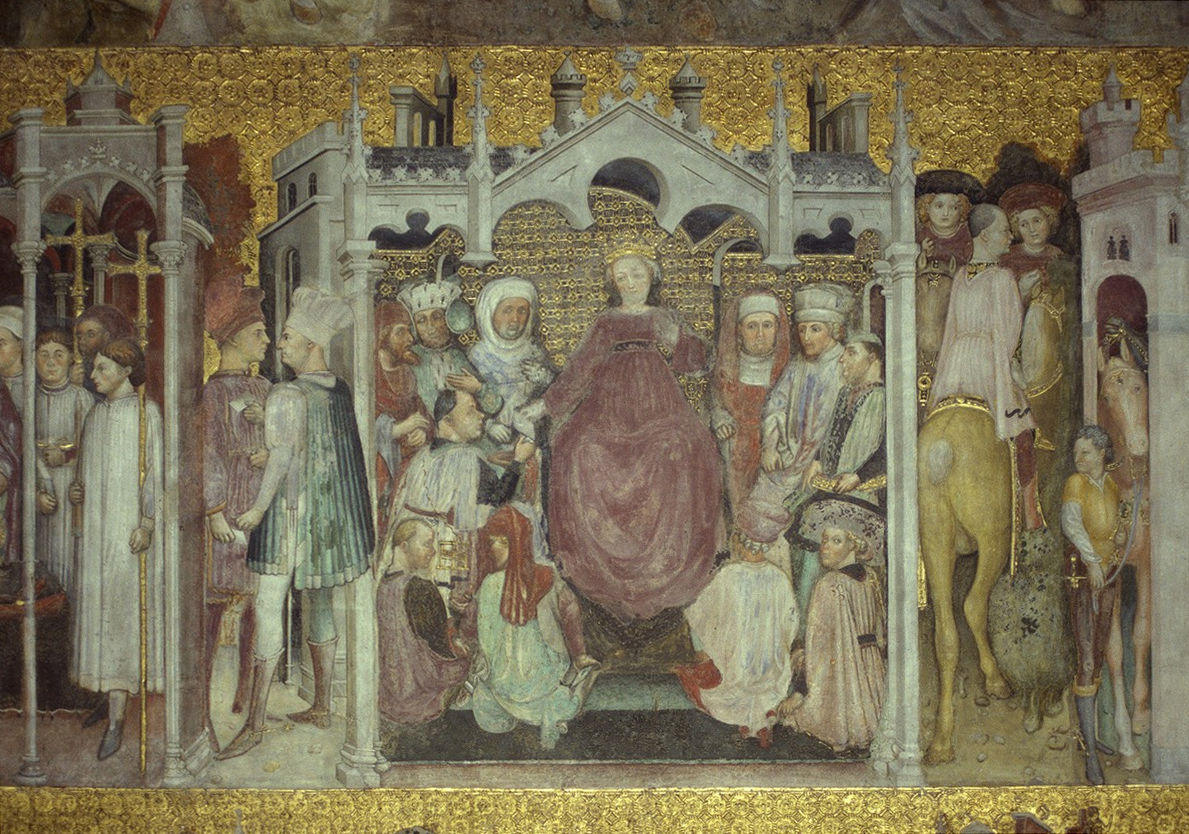
FIGURA 97 – Teodolinda in Trono in uno dei pannelli della sua Cappella, confermante la solenne importanza della propria incoronazione a Regina Consorte dei Longobardi (foto-rielaborazione di Corrado Gavinelli del 2022)
Ma le immagini dipinte comprendono anche le più varie particolarità socio-esistenziali dell’epoca, minuziosamente descritte nei personaggi e negli oggetti, nei vestiti e nelle suppellettili, nel paesaggio e nelle costruzioni, in un fitto repertorio rappresentativo di stupenda precisione e bellezza.
La effigie di Teodolinda negli affreschi della sua Cappella
E’ però nelle molteplici raffigurazioni dei personaggi ritratti negli affreschi sopra considerati, riportati fisionomicamente negli aspetti variegati delle caratterizzazioni realistiche degli individui dell’epoca, che si ritrova la più alta proprietà di rappresentazione delle pitture zavattariane, eseguita nelle singole parvenze individuali esteriori e caratteriali, con ampia diversificazione soggettiva.
E particolarmente è nella figura femminile e muliebre della stessa Teodolinda che risalta la significativa qualità espressiva di quelle immagini, in una successione visuale del suo corpo, e del suo viso in particolare, differentemente mostrata con specifica identità circostanziale (di non molto diversificata ma sensibilmente percepibile) nelle più varie situazioni, e posizioni, e atteggiamenti della donna.
Nella spaesata incertezza dell’ingresso in Verona per lo sposalizio con Autari [Figura 98], nella assorta emozione durante il matrimonio [Figure 99 e 100], nella meditabonda concentrazione per la gravità del proprio nuovo ruolo di responsabilità quale regina [Figura 101], e nella composta reverenza verso le autorità della propria fede religiosa [Figura 102].
 Figura 98
Figura 98

 Figure 100 e 101
Figure 100 e 101 
FIGURE 98-102 – Alcune delle varie espressioni del viso di Teodolinda nei diversi episodi dei dipinti zavattariani: all’ingresso degli sposi (con Autari) in Verona [sopra], nel secondo matrimonio della regina longobarda con Agilulfo (immagine piena e dettaglio del viso) [sotto e in basso], nel particolare della ricerca per il luogo dove costruire la propria cappella palatina [più sotto], e nell’incontro con il Papa Gregorio Magno [più in basso]

E comunque nella sua interiore riflessione meditativa, pacata e avveduta, per i propri nuovi còmpiti ricevuti di sovrana [Figura 103], che spesso ne rimandano l’effigie ad una sorta di spiritualizzata Madonna di laica interpretazione.

FIGURA 103 – Il viso assorto di Teodolinda durante la sua Incorazione (si veda la Figura 97), ritratta nell’aspetto trionfante di una Madonna laica
Tutte riproposizioni diverse, che compongono tuttavia un antologico repertorio delle sembianze di questo straordinario personaggio, come in tanti ritratti diffusi ed evocativi, che adesso mi accingerò ad analizzare nelle rappresentazioni secolari più vari di artisti noti o più anonimi.
La immagine fisica di Teodolinda nella variegata rappresentazione artistica delle epoche
Oltre a questa fitta campionatura omogenea di figurazioni teodolindiche nel suo Ciclo della Storia della propria Vita sostanzialmente di riferimento monzese, una vera e propria ritrattistica storica della regina longobarda si ritrova nelle più secolarmente diversificate sue immagini proposte nelle varie epoche storiche.
E tra le numerose raffigurazioni della regina longobarda, non mancano interessanti esemplari di proposizione del suo possibile, e idealizzato, aspetto fisico.
Perché della vera sua figura fisionomica, non essendoci pervenuti ritratti originali delle proprie fattezze, non si possono stabilire possibili sembianze con certezza accettabili; e gli artisti di ogni epoca hanno dovuto preoccuparsi di rappresentarne le apparenze esteriori in forma ideale, con parecchie immagini di personale interpretazione.
A cominciare proprio dal suo presunto primo ritratto arcaico (Testa di Donna) eseguito ancòra con la regina longobarda in vita, realizzato da un anonimo scultore longobardo nel 624-27 proprio negli ultimi anni di esistenza di Teodolinda (che muore nel 628), e conformato nella stereotipica plasmazione morfologica delle statue alto-medievali di corrispondenza celtica, che allora si presentavano molto simili tra loro e poco soggettivamente differenziate [Figura 104]; per giungere poi a maggiormente definite, ma sempre inventive ovviamente, immagini di maggiore precisazione fisionomica.

FIGURA 104 – Il primo (presunto) ritratto arcaico di Teodolinda (Testa di Donna) realizzato da un anonimo scultore longobardo nel 624-27, eseguito ancòra con la regina longobarda in vita, proprio negli ultimi anni della sua esistenza (la sovrana muore nel 628), conformato nella stereotipica plasmazione fisionomica delle statue alto-medievali di provenienza celtica, che allora si presentavano molto simili tra loro e poco soggettivamente differenziate (immagine riportata nel 2017 da Ruggero Forti e Denise Zanini sul sito telematico Thais, “dedicato interamente all’arte”)
Tra cui – nelle effigi di una certa vetustà epocale – si ritrova l’affresco del 1309-11 della cosiddetta Messa di San Michele di sconosciuto pittore riminese, una volta esistente nella chiesa michelina a Monza ma adesso (essendo quell’organismo ecclesiale andato distrutto nel 1921-22) trasferita al Museo di Monza, mostrante una Teodolinda auspicata santa con la sacra aureola intorno al capo [Figure 105 e 106].
 Figura 105
Figura 105

FIGURE 105 e 106 – Pittore Riminese Ignoto, Messa con Cristo, la Vergine e Santi, 1309-11 (affresco conosciuto più sinteticamente come Messa di San Michele): particolare con Teodolinda [sopra] e la opera intera [sotto]. La regina è stata raffigurata con una aureola, poiché a quell’epoca non poche persone auspicavano la beatitudine della sovrana longobarda (però mai concessa dalle autorità cattolico-vaticane). Questo lavoro dipinto su una parete nella chiesa michelina in Monza (che è stata alla sua epoca un importante edificio sacro ritenuto anche esso risalente ai Longobardi) è stato trasportato nel Museo e Tesoro del Duomo monzese alla demolizione del tempio nel 1921
E poi abbiamo il ritratto del 1319/20-45 scolpito da un altrettanto artista medievale ignoto nel bassorilievo della Lunetta del Portale nel Duomo di Monza, raffigurante il Battesimo di Cristo da parte di San Giovanni il profeta, e comprendente la regina longobarda mentre riceve il Tesoro e la Corona Ferrea [Figure 107 (e 74].

FIGURA 107 – Il ritratto teodolindiano (dettaglio) scolpito nella Lunetta del Portale del Duomo di Monza (si veda la Figura 74), lavoro effettuato tra 1319/20 e 1345 da un ignoto lapicida collaboratore dello scultore Matteo Da Campione, architetto trecentesco della basilica monzese (foto di Corrado Gavinelli del 2022)
E quindi, col Quattrocento, si ritrova la nota xilografia a colori del 1492 (Theudelinda regia) prodotta per le Cronache di Norimberga scritte dal fisico tedesco Hartmann Schedel (umanista e storico, e cartografo, che è stato uno dei primi autori ad utilizzare la tecnica della stampa) e pubblicate l’anno dopo [Figura 108].

FIGURA 108 – La regina Teodolinda in una xilografia a colori (Theudelinda regia) di Michael Wolgemut del 1492, stampata nelle sopra citate Cronache di Norimberga del 1493 (si vedano le Figure 25 e 26)
E procedendo nei secoli, nel Cinquecento si possiede la grande formella tridimensionale nella facciata del duomo monzese (Theodolda Regina) con la statua della sovrana monzese scolpita nel 1508-10 da un autore rinascimentale sconosciuto [Figure 109], …

FIGURA 109 – Studio Aquadrio, Teodolinda nella formella del Duomo di Monza, 2010. La scultura nel tondo della facciata della basilica monzese, alla base del rosone, è opera (Theodolda Regina) di un autore rinascimentale sconosciuto scolpita nel 1508-10
… sùbito cronologicamente seguìta dalla miniatura a colori (Teodolinda Regina dei Longobardi) non del 1490 e dipinta per un testo di Litania fiammingo, bensì attuata per un simile Libro di Ore Sforzesco nel 1517-20 dall’artista lombardo (al servizio di Ludovico il Moro) Giovanni Pietro Da Birago [Figura 110].

FIGURA 110 – Giovanni Pietro Da Birago, Teodolinda Regina dei Longobardi, 1517-20. Dettaglio figurativo di una pagina miniata a colori eseguita non nel 1490 per un testo di Litania fiammingo come in alcuni casi viene riportato, bensì un ventennio dopo per un simile Libro di Ore Sforzesco ad opera dell’artista lombardo, che era al servizio di Ludovico il Moro
E dopo, nel Seicento, è stata realizzata la didascalica acquaforte al bulino del 1614 del già incemtrato incisore di Anversa Raphael Sadeler (Teodolinda Regina Boia dei Longobardi) commentata quale “Ritratto a figura intera di tre quarti a destra della figlia del duca bavarese Garibaldo I, in piedi accanto al marito, il re longobardo Authari, mentre contempla un dipinto della Santa Trinità con la quale dimostra l’arianesimo come eresia”) [Figura 111].

FIGURA 111 – Raphael Sadeler, Teodolinda Regina Boia dei Longobardi, 1614. La sovrana longobarda è ritratta mentre “spiega” al marito Agilulfo, davanti ad una immagine sacra raffigurante la triade cattolica del Padre (il vetusto Creatore dell’Universo), del Figlio (il Cristo con la Croce del proprio martirio), e dello Spirto Santo (in forma di colomba), la condizione eretica del credo di Ario. I Boii, come precedentemente accennato, erano un popolo celtico della Età del Ferro variamente stanziati nella antica Boemia e poi migrati in Gallia (dove li si ritrova ai tempi della conquista di Caio Giulio Cesare) e quindi anche in Lombardia; il cui ramo teodolindico proveniva dalla Pannonia nella regione del Lago Balaton della attuale Ungheria
Ed infine ci sono pervenute le rappresentazioni ottocentesche – più epocalmente delineate secondo il gusto formale del periodo – dell’artista romantico genovese già variamente citato Girolamo Scotto (Teodolinda – Regina dei Longobardi, del 1839-40) [Figura 112] …
 Figura 112
Figura 112
FIGURA 112 – Girolamo Scotto, Teodolinda – Regina dei Longobardi, 1839-40. Ritratto idealizzato della giovane regina longobarda, interpretata da uno degli artisti (di Genova) del Neoclassicismo italiano specializzatosi in immagini di personaggi storici importanti (si vedano le Figure 121 e 122)
nonchè degli scultori italiani già ricordati Luigi Secchi (cremonese) ed Antonio Carminati (bergamasco-milanese) esecutori di un volumetrico ritratto teodolindico del 1890-91 plasmato in un modello prepratorio per una statua della sovrana longobarda (mai eseguita) durante i restauri beltramiani alla basilica di Monza [Figure 113 e 114].

FIGURE 113 e 114 – Il ritratto, ache esso idealizzato, della Regina Teodolinda che mostra il modello della Facciata del Duomo di Monza (nel particolare del volto [sopra] e nell’opera intera [sotto]) eseguito quale plastico preparatorio per una statua della sovrana monzese (mai eseguita) nel 1890-91 dagli scultori italiani Luigi Secchi (cremonese) ed Antonio Carminati (bergamasco-milanese) in occasione dei sopra citati restauri di Luca Beltrami alla basilica di Monza (si vedano le Figure 58 e 59)

Senza considerare poi le più stravaganti versioni recenti di età contemporanea, tra cui la fumettistica Teodolinda, come Fiona Prigioniera nella Torre del Castello disegnata per il cartone animato disneyano del 2001 dal caratterista Tom Hester con la supervisione del suo Direttore Artisctico Steve Pilcher, entrambi statunitensi [Figura 115], e le tantissime rappresentazioni viventi, in costume medievale, delle Teodolinde diverse performate variamente dal 1985 da giovani cittadine monzese prescelte per le ricostruzioni storiche effettuate a Monza durante le differenti e annuali Sagre di San Giovanni (il Battista) [Figura 116].

FIGURA 115 – Tom Hester, Teodolinda, come Fiona Prigioniera nella Torre del Castello, 2001. Il disegno è stato effettuato dal fumettista statunitense (con la supervisione del Direttore Artistico disneyano Steve Pilcher, suo connazionale) per il cartone animato Shreck uscito nel 2001 (foto di Corrado Gavinelli del 2022)

FIGURA 116 – La figura vivente di Teodolinda nella versione del 2017 (foto di autore anonimo) eseguita tra le innumerevoli rappresentazioni dal vero, in costume medievale, performate variamente dal 1985 a Monza, scegliendo una abitante monzese per interpretare la figura della sovrana longobarda, per le ricostruzioni storiche effettuate durante le diverse e annuali Sagre di San Giovanni (il Battista)
TEODOLINDA PRIGIONIERA A BELLINZAGO (NOVARESE)?
E dopo questa lunga, ma necessaria e determinante analisi per la conoscenza storica delle vicende esistenziali della regina longobarda e della sua indole personale, è possibile addentrarsi più specificamente nelle cause e ragioni della storia bellinzaghese di cui narra la leggenda del suo imprigionamento in un castello del paese o dei suoi immediati dintorni, che – con poche parole essenziali e in un laconico racconto sintetico – gli anziani di Bellinzago Novarese hanno tramandato ancòra di recente agli ultimi loro discendenti.
Stupisce però che di tale vicissitudine sfuggano particolari e sviluppi, e che ne sia rimasto solamente un ricordo debole di genericità episodica, senza dettagli, e mancanti di ulteriori accertamenti storici e territoriali; dei quali occorre trattare, per cercare di individuarne le matrici narrative, e ritrovarne una possibile attestazione, anche soltanto di memoria perduta.
Innanzitutto occorre riconoscere, per i riscontri eventualmente teodolindici, che – come è noto – della località denominata Bellinzago esistono, in Italia, due siti geografici (quella novarese e in Piemonte, ed un’altra lombarda) di cui però nella seconda non si ritrova riferimento teodolindico alcuno [Figure 117 e 118]; ed inoltre si deve riscontrare …

FIGURE 117 e 118 – La posizione delle due Bellinzago (Novarese e Lombarda: segnate dai pallini blu, rispettivamente a sinistra e a destra) nella Carta Geografica politico-stradale della Italia Settentrionale disegnata da un topografo anonimo della Agenzia Cartografica Tutto Città (senza data) [sopra]; e la localizzazione del solo sito bellinzaghese nella Provincia di Novara (nel pallino anche esso blu) ripresa dalla Carta del Piemonte Valle d’Aosta elaborata (nel 1968 da un esecutore anonimo sotto la direzione del grafico novarese Achille Soldani) dalla Redazione Geografica dell’Istituto Geografico De Agostini di Novara pubblicata nel 1973 sull’Atlante Mondiale curato dagli italiani Umberto Bonapace e Giuseppe Motta, rinomati cartografi e pubblicisti deagostiniani [sotto] (elaborazioni grafiche e foto di Corrado Gavinelli del 2022)
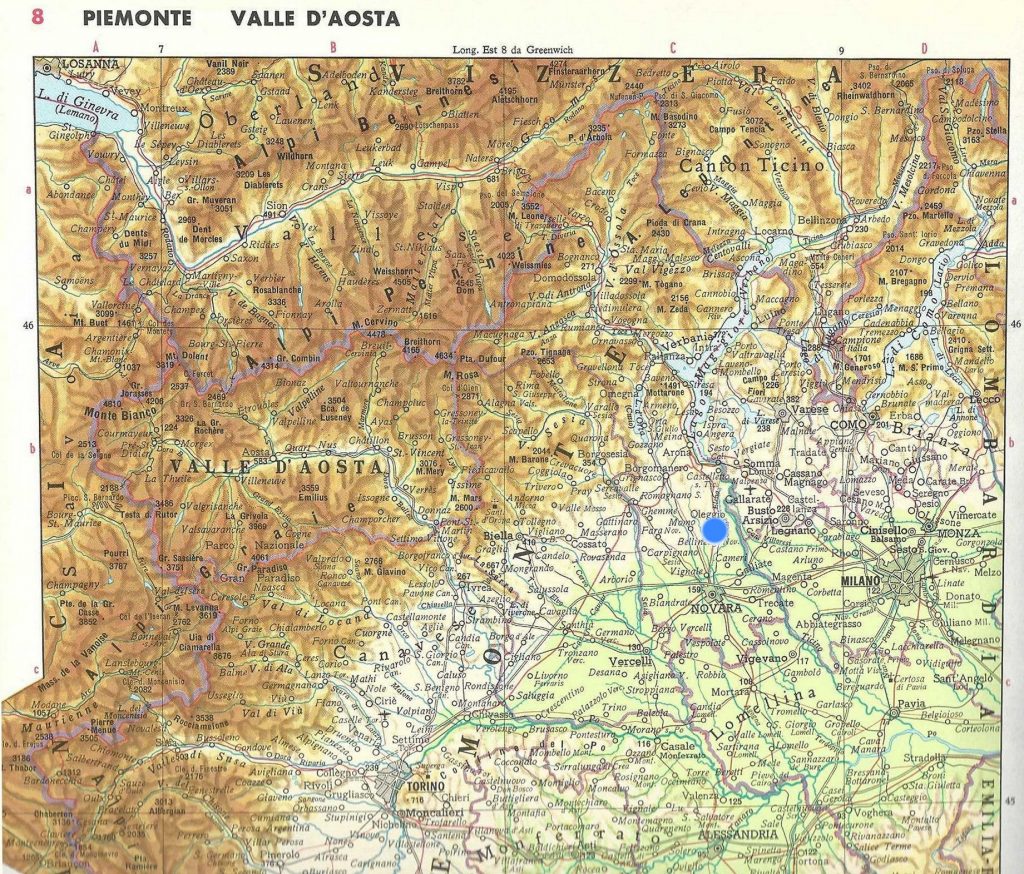
… che proprio al di sopra al confine settentrionale di Bellinzago-novarese, si ritrova la cittadina di Oleggio [Figura 119] di cui il noto storico medievalista locale (di Novara) Giancarlo Andenna (Professore di Storia Medievale alla Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano) ha lasciato nel 2009 una significativa indicazione di esplicita appartenenza storica, di inequivocabile attestazione (“Olegium qui dicitur Langobardorum”), rintracciandone una sua prima testimonianza scritta in un documento del 973 quale luogo di vecchia attinenza longobarda.
 Figura 119
Figura 119
FIGURA 119 – Bellinzago Novarese nella sua vicinanza alla longobarda Oleggio (4 chilometri di distanza soltanto) [elaborazione grafica del 2022 di Corrado Gavinelli dalla mappa del 2019 della Provincia di Novara di Autore Anonimo della Collezione Immagini PNG]
La dizione verso il luogo di Oleggio nella frase latina è perentoriamente assertiva nei confronti della appartenenza di questo luogo ai domìni dei Longobardi in zona; ed anzi appare quasi in una affermazione di suprema importanza: alla quale anche la vicinissima Bellinzago doveva quindi contestualmente partecipare.
Ma particolarmente, alcuni rinvenimenti archeologici ritrovati a Oleggio sotto la attuale Chiesa di San Michele al Cimitero hanno restituito i muri di fondamenta di una elementare aula ecclesiale databile al 605-608, di inequivocabile epocalità teodolindica (nel periodo di suo insediamento quale Regina Consorte del Regno Longobardico del Re Agilulfo proprio secondo marito).
Questa attestazione dataria stabilisce almeno un chiaro elemento di possibile riferimento epocale alla ritenuta presenza della regina monzese a Bellinzago, borgo immediatamente confinario con la longobarda Oleggio.
Nelle cui memorie e tradizioni e leggende (e fatti storici) però non viene fatto accenno ad alcuna vicenda riguardante la sovrana longobarda, e tanto meno di un suo soggiorno coatto.
Ma perché, allora proprio a Bellinzago la regina sarebbe stata incarcerata?
Questa ipotesi peregrina, e considerabile assurda, è specificamente l’oggetto della mia indagine che mi accingo adesso ad affrontare con puntigliosa ricognizione nei meandri degli avvenimenti longobardi, per vedere di trarne un plausibile risultato di riconoscibilità effettuale.
Resta comunque il fatto che la posizione geografica di Bellinzago Novarese non si trova propriamente sulle medesime direttrici dei luoghi fondamentali (Monza, Milano, Torino, e Bobbio) di costruttività religiosa scelti da Teodolinda per i suoi itinerari di fondazioni ecclesiali e monastiche, o riguardanti gli sviluppi di vicende politiche che la coinvolgevano per qualunque sosta durante i suoi viaggi o per presunti propri ripari (con anche per eventuali imprigionamenti leggendari, se vogliamo) in manieri castellanei, attraversanti – orizzontalmente e in verticale – la pianura padana lombardo-piemontese [Figura 120]; ma ugualmente non se ne può trascurare un effettivo riferimento, essendo il tragittto verso Oleggio (e a Bellinzago) anche il più comodo e breve per la direzione torinese.

FIGURA 120 – I luoghi teodolindici di impresa costruttiva della Regina longobarda (Monza, Torino, Bobbio: in rosso nella mappa) nella ricostruzione localizzativa di Corrado Gavinelli del 2022 impostata sulla già riportata topografia della Italia Settentrionale disegnata da autore anonimo della Agenzia cartografica Tutto Città (senza data), con anche i siti di eventuale passaggio e sosta (Bellinzago e Santhià a settentrione, e Pavia, Spinetta di Marengo, ed Asti a meridione: tutti segnati in blu). Si può notare come geograficamente la posizione di Bellinzago risulti, sebbene alquanto decentrata rispetto agli itinerari più consueti, il punto di congiunzione e chiusura adatto, nell’esagono dei siti di sosta entro il triangolo dei luoghi di attività costruttiva teodolindici, sul percorso da Monza-Milano a Santhià-Torino. Ed è riscontrabile inoltre come tutti questi siti si compongano in una chiusa e compatta area lombardo-piemontese di frequentazione intercollegata
E dunque non può neppure venire escluso – per i grandi misteri imperscrutabili della Storia – che un passaggio, o una fermata di riposo, a Bellinzago (che si trovava presso, se non attaccata, alla longobardissima Oleggio) nell’itinerario da Monza a Torino possa essere avvenuto, e magari anche nelle leggendarie circostanze drammatiche di cattura e prigionia: di cui adesso esaminerò i dati e valuterò le conclusioni.
La ribellione degli Ariani
Una possibile – ma non unica, perché altre simili circostanze potrebbero essersi presentate – situazione in cui la regina longobarda avrebbe potuto essere fermata e arrestata ed imprigionata durante un suo percorso itinerante da Monza a Torino (allorchè si recava nella capitale piemontese per assistere alla realizzazione della chiesa di San Giovanni Battista da lei patrocinata e fatta erigere), è nel fatidico periodo di torbido scontro, pariteticamente religioso e dinastico, avvenuto tra il 625 e il 626 all’interno delle manovre politiche per il comando e il governo del regno longobardo, dove tutto non procedeva pacatamente, ma si svolgeva con discordie famigliari di potere anche sostenute e truci.
Causate soprattutto dalla resistenza di gruppi di duchi lombardi e piemontesi che non volevano rinunciare alla loro tradizione ariana, e non aderire quindi al Cristianesimo papale come invece era nella volontà eminente di Teodolinda; che – in accordo con il Papa Onorio I, ma sotto la influenza teologico-diplomatica di Pietro Di Paolo, consigliere latino teodolindico – da quando soprattutto divenne Reggente (nel 622) di Adaloaldo, proprio figlio minorenne erede al trono di Agilulfo (morto nel 616), intendeva imporre con autoritaria decisione il nuovo credo cattolico a tutti i suoi sudditi.
E quando Adaloaldo, nel 624, divenne maggiorenne e fu incoronato Re (e sostenuto tanto dal Vaticano quanto dalla Chiesa bizantina ortodossa) scoppiò la rivolta dei duchi ariani longobardi – che vedevano in quella situazione anche un pericolo di perdita del loro potere autonomo, congiuntamente a sottostanti pretese di successione al trono – comandati dal cognato Arioaldo (marito della sorella adaoaldina Gundeperga, figlia di Teodolinda e Agilulfo: di cui ho parzialmente accennato più sopra), il famigerato Duca di Torino da cui venne conclusa – dopo due anni di conflitti e scontri – la vicenda della Rivolta degli Ariani, con la detronizzazione del re in carica e l’assunzione del comando longobardico(e dell’Arianesimo) nel 626 da parte arioaldina [Figura 121].
 Figure 121 e 122
Figure 121 e 122 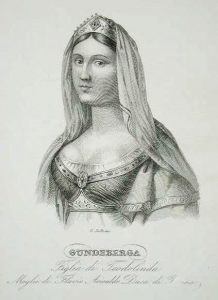
FIGURE 121 e 122 – Girolamo Scotto, Flavio Arioaldo – Duca di Torino – Sesto Re dei Longobardi, 1839-40 [sopra, a sinistra], e Gundeberga – Figlia di Teodolinda – Moglie di Flavio Arioaldo Duca di Torino, 1839-40. Il ritratto arioaldino è la effigie idealizzata del monarca longobardo, sul trono dal 626 al 636, prima Duca di Torino e poi anche Re d’Italia, genero del proprio predecessore Agilulfo; mentre la figura femminile è la sua sposa, che condivise con lui il trono dei Longobardi dal 626 al 636, e poi anche fino al 652 (quando la donna morì) con il re successore Rotari da lei sposato in seconde nozze. Nel biennio 627-629 questa regina – come precedentamente ho narrato – venne imprigionata per presunte accuse di tradimento e congiura verso il proprio sovrano (si veda la Figura 12), ma poi fu riabilitata per non avere commesso reato alcuno
Può essere quindi, in questa concitata vicenda di lotte e conflitti, che Teodolinda potrebbe essere stata catturata durante un suo viaggio da Monza per Torino – sul tragitto decentrato e più breve tendente ad Oleggio – nei pressi di Bellinzago Novarese ed ivi imprigionata (sebbene non ne provengano notizie accertate dalle cronache storiche): anche perché questo suo fatto viene a coincidere (e pertanto confuso nel ricordo delle narrazioni epiche) con la vicenda della propria parente Gundeperga (sua figlia), sposa di Arioaldo: la quale (essendo donna “pia e religiosa come sua madre Teodelinda”: così la descrive nei suoi Annali, compilati tra il 658 ed il 660, Fredegario, cronista e storico dei Franchi di origine burgunda) [Figura 122] il nuovo sovrano nominò sùbito Regina, ma poi – come precedentemente ho riferito – la fece rinchiudere (nel castello di Lomello, e per ben 2 anni, dal 1627 al 1629) per una sospetta – rivelatasi poi calunniosa e non vera – congiura che la nuova sovrana avrebbe intentato contro di lui in combutta con il Duca di Toscana Tasone (che non è l’omonimo del Friuli di cui ho riferito prima a proposito del Castello di Domòfole: come si può riscontrare, gli intrecci imprevedibili delle leggende si rincorrono incredibilmente e si mescolano tra loro più del pensabile) [Figura 123 e 124].

FIGURA 123 [sopra]– Raphael Soderer, Gundeberga Regina Boia dei Longobardi, 1618. Il commento alla incisione riporta la erronea informazione secondo cui “Gundeperga, accusata ingiustamente, guarda fuori dalla finestra della prigione la morte di Arioaldo per punizione divina”: conclusione inventata, perché non soltanto quando la sovrana venne scarcerata il proprio marito Arioaldo restò in vita per 6 anni, ma il suo decesso non fu opera della freccia accidentale (pertanto considerata divina) che gli trapassò il torace, bensì avvenne naturalmente (o magari causata da un solito avvelenamento strategico, come sovente avveniva allora)
FIGURA 124 [sotto] – Veduta odierna del Castello di Lomello dove Gundeperga venne imprigionata (in una immagine della Agenzia Solaxart del 2013 di fotografo anonimo). Il maniero attuale è stato voluto da Gian Galeazzo Visconti (primo Duca di Milano e detto Conte di Virtù dal nome della località francese di Vertus nella Champagne, che ricevette come titolo portatogli in dote dalla prima moglie Isabella di Valois) che nel 1381 incaricò l’ingegnere Giacomo Albarelli di costruirlo (la torre e il fossato sono però più tarde, del 1450). Delle pre-esistenze longobarde tuttavia non rimane alcuna traccia fisica

Una trama di tradimento da cui Arioaldo la dovette prosciogliere, rimettendo in libertà la moglie e rielevandola al trono come propria consorte, nonché nel rango di collaboratrice al proprio piano di riforme, e soprattutto mediatrice garante del non totalmente risolto equilibrio religioso tra Ariani e Cattolici.
una vicissitdine avversa che purtroppo alla malcapitata Gundeperga (ma questo fatto oscilla anche esso tra realtà e leggenda) capitò anche nel proprio secondo matrimonio regale, avvenuto nel 636 con il Duca di Brescia Rotari (il famoso sovrano dell’Editto che porta il suo nome: atto giuridico scritto, che raccoglieva le leggi longobarde prima tramandate oralmente), il quale la relegò, in pratica pigioniera, in alcune stanze del Castello di Pavia (città nel frattempo divenuta capitale longobardica già con il predecessore Arioaldo) non per cause di particolare tradimento effettive ma per motivi di semplice precauzione religiosa, tale da rendere immuni da interferenze religioso-politiche pericolose, essendo – anche in questo caso – la donna una tenace cattolica, ed il monarca suo marito sempre convinto ariano.
Indipendentemente dalla convulsa ma breve (e però sintomatica di un persistente conflitto tra concezioni di fede diverse all’interno del regno longobardo non compatto, mai definitivamente concluse e sempre ritornanti) fase di contrasto tra i monarchi lombardi e i nobili tribali all’epoca aldoaldiana, sicuramente – nonostante le indubbie buone intenzioni di governo teodolindiche nel periodo più autoritario di Agilulfo – la politica di gestione interna sostenuta dai re dei Longobardi è piuttosto stata di accordo, accomodamento e di non aggressione interna: addirittura Autari si prodigò per lo sviluppo socio-statale del proprio popolo, allo scopo di condurlo – da un coacervo non unitario di tribù tra loro in contrasto per la egemonia politica – ad un insieme societario maggiormente coeso, di riferimento ad una stirpe omogenea, per la cui affermazione emblematica egli addirittura si attribuì il nomignolo romano di Flavio (un titolo riconoscitivo che assunsero anche i suoi successori), riprendendo una tradizione introdotta dai suoi predecessori Odoacre e Teodorico il Grande, in modo da sancire anche una più ampia legittimità al potere longobardo sulla totalità della popolazione italica, in larga maggioranza di discendenza latina, con netto rimando referenziale alla eredità storica dell’Impero Romano di Occidente (ed in dichiarata opposizione al dominio ravennate-bizantino).
E dunque le sommosse e gli scontenti post-agilulfici e aldoaldini portano lecitamente a credere che fossero la conseguenza reattiva della esagerata politica di comando, autoritaria e impositiva, adottata da Teodolinda verso le vecchie tradizioni longobardiche, soprattutto ariane, a favore delle proprie nuove concezioni religiose rivolte al Cristianesimo (che le concedevano una opportuna alleanza con le forze di potere in Italia): e che non potevano scongiurare dunque quella leggendaria condizione di imprigionamento a lei riferita, cui la tradizione bellinzaghese misteriosamente fa riferimento, come ad una lontana eco di rivalsa di quell’epoca.
Quale Castello di Bellinzago?
A lato di queste vicende politico-religiose effettivamente successe oppure rese enfaticamente leggendarie, nel caso della eventuale prigionia bellinzaghese di Teodolinda si tratta di verificare in quale maniero castellaneo la regina longobarda sarebbe stata rinchiusa.
Perché Bellinzago, nella sua storia, ha posseduto vari edifici, o luoghi, con la denominazione di castello (rifugio all’interno del vecchio castro abitato, autonoma dimora signorile esterna sulla collina, o costruzione isolata di fortificazione nell’immediato intorno territoriale del borgo) [Figura 125].

FIGURA 125 – Corrado Gavinelli, I Tre Castelli di Bellinzago Novarese, 2022. Localizzati (con pallini bianchi) sulla mappa teresiana del 1723 (Foglio 3 di Belinzago-), da sinistra in alto sono segnalati i siti del Castello Superiore (sulla collina occidentale), il Ricetto (nell’abitato), ed il Castellaccio (alla immediata periferia esterna anche essa occidentale)
E conviene però sùbito chiarire che si tratta di organismi tutti di esecuzione storica post-longobardica, o che comunque nelle loro vestigia precedenti non si rivela nulla di databale a prima dell’anno Mille.
Aggiungendo inoltre che comunque di longobardità bellinzaghese mai si ritrova espressamente nei documenti, e che notizie certe di attestazione longobarda si hanno unicamente per Oleggio, come già osservato, e per la Badia di Dulzago; e per altro relative al periodo teodolindico e poco successivo, di cui ha trattato sempre l’Andenna sul suo saggio in ‘Uomini e Terra’ del 1898 più volte ricordato. E tali carte testimonianti concernono specificamente in “una permuta tra il vescovo di Novara, Daghiberto, ed Ildeprando di Caltignaga” (località appartenente alla pieve dulzaghese) “realizzata tra il 527 ed il 940” e riferita “alle proprietà ad Isarno”, confermata anche in “un documento del 958”; ma particolarmente affermate nella “situazione documentata per Dulzago nel 990”, riguardante un proprietario terriero locale, un certo “Angesizo detto anche Anizo” che “dichiara di vivere secondo la legge longobarda e di abitare in loco Dulciaco”: una affermazione che chiarisce come intorno a Bellinzago la modalità giuridiche dei Longobardi fossero attive e seguìte.
Il Castello sulla collina (cosiddetto Superiore)
Il più noto, e documentato, edificio castellare completo e indipendente dalla topografia dell’abitato bellinzaghese si trova lievemente distaccato dal borgo residenziale, e sulla propinqua collina occidentale [Figura 126].

FIGURA 126 – Mappa in Trabucchi Milanesi (foto di Corrado Gavinelli del 2014) tracciata dal misuratore bellinzaghese Giuseppe Vandoni nel 1725, riprendendola dalla cartografia catastale teresiana disegnata nel 1722 ed aggiornata (“corretta”) un anno dopo (si vedano anche le Figure 125 e 130). I resti dell’antico Castello si riconoscono chiaramente nella parte occidentale della mappatura, appena fuori dal borgo di conformazione ancòra medievale
La sua storia però risale a non prima del Mille, come si ritrova nella scrittura di assegnazione terrriera (riportata dal già pluri-citato storico novarese Giancarlo Andenna nel libro di interventi plurimi ‘Uomini e Terra’, nel suo saggio su Gli uomini, e l’alternanza della sorte) rilasciata nel “1141” dall’Imperatore Corrado III Hohenstaufen al Conte Guido di Biandrate, padrone di molti terreni locali, in cui il paese di “Brenzago” viene riconosciuto come uno dei “numerosi castelli e villaggi del Novarese”. E pertanto dunque la sua candidatura a luogo di incarcerazione teodolindica è del tutto da escludere.
Delle vicende di questo Castello Superiore (chiamato così perché posto in cima alla altura collinare vicino al borgo abitato) è interessante ripercorrere i fatti importanti, che per essenzialità riassuntiva riporto nella sintesi che ho pubblicato, sempre su ‘Frontiere’, in un altro mio saggio del 2022 di argomento bellinzaghese a proposito di Bellinzago nel Novarese, la antica colonia romana di Bellicio: “Il distrutto Castello di Bellinzago, che si trovava sulla immediata collina appena dopo l’abitato occidentale, sùbito oltre la strada conducente alla Badia di Dulzago (e più di recente anche alla Stazione Ferroviaria)” e specificamente alla vicina località di Alzate, ci è stata attestata “nella immagine storica tramandata dai rilievi settecenteschi: dalla topografia bellinzaghese del geometra misuratore […] Giuseppe Vandoni del 1725 […], e nel rilevamento più tardo (di 25 anni dopo) dei possedimenti terrieri (e della parte residenziale) effettuato dall’altrettanto ricordato geometra-agrimensore suo omonimo, Francesco (L’Anno 1750. Si E Fatta la Misura, e Disegno de Beni Uniti al Castello di Bellinzago del Sig.r Giuseppe Ant.o Florio. Di Romagnano)” [Figura 127], da cui …

FIGURA 127 [sopra]– Francesco Vandoni, L’Anno 1750. Si E Fatta la Misura, e Disegno de Beni Uniti al Castello di Bellinzago del Sig.r Giuseppe Ant.o Florio. Di Romagnano. Contrariamente a quanto si può ricavare dal titolo della mappa, il rilevamento del castello bellinzaghese non è opera floriana, ma – come si legge in una indicazione esplicita alla fine delle didascalie del foglio – “Fatta da Fran.co Vandone – Agrimensore approvato dalla Città di Novara”. Tuttavia, in un piccolo cartiglio apposto nell’angolo sinistro in basso della stessa cartografia, viene riferito che “Il Disegno” (probabilmente però solamente le figurazioni paesistiche e di prospettiva, facenti da corollario alla planimetria) è stato “fatto da Me F.co Fl.rio” (ovvero da un non bene identificato Francesco Florio, forse parente del committente dell’opera) [foto di Giacomo Musetta del 2021]
… si può ricavare “il dettaglio della planimetria del maniero nel suo impianto di caseggiato spazial-edilizio” [Figura 128] “nonché nel particolare del proprio specifico aspetto esteriore” [Figura 129].
 Figura 128
Figura 128
FIGURE 128 e 129 – Dettaglio della Planimetria del Castello bellinzaghese [sopra] e Particolare dell’aspetto fisico del maniero [sotto] , ripresi dalla mappa precedente (alla Figura 127: entrambe foto di Corrado Gavinelli del 2022)
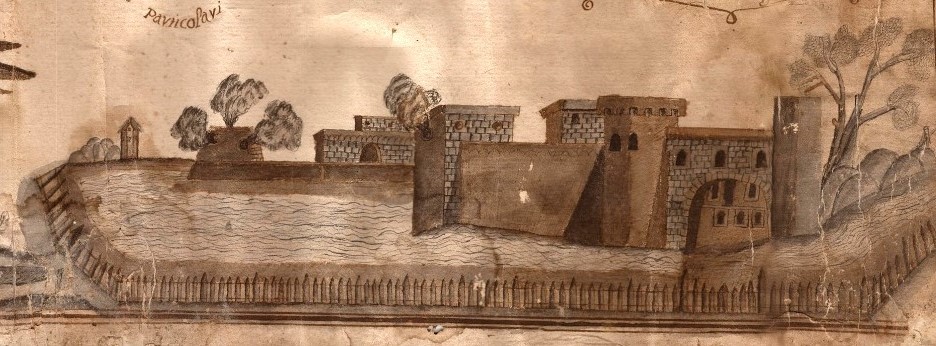
Del castello esiste inoltre una cartografia teresiana (quella del catasto fatto disegnare dalla Regina austriaca Maria Teresa nel 1722-23), nella quale è altrettanto visibile il perimetro del maniero nella sua genericamente rettangolare chiusura perimetrale, di cui però non si riesce a capire la consistenza muraria (se appartenente alle difese esterne o riferita ai soli caseggiati abitativi interni, che non altrimenti risulta più decisamente distinguibile nella analoga mappatura vandoniana effettuata nel 1725) [Figure 130 e 131].

FIGURE 130 e 131 – I rilevamenti teresiani del 1722 aggiornati al 1723 riportati nel Foglio 9. Di Belinzago- (parte superiore) [sopra] e quelli vandoniani del 1725 (particolare della Figura 125) [sotto] mostrano una medesima situazione edilizia del Castello ma leggermente differente nel perimetro difensivo (disegnato in grigio; che magari può anche riferirsi al fossato) dei caseggiati interni di residenza e di servizio (foto di Corrado Gavinelli del 2022)
 Figura 131
Figura 131
Di tutto il complesso edilizio del castello oggi non resta più nulla, se non (e di ciò però sussistono riserve di effettivo riferimento certo) nella immagine di un “unico torrione salvatosi dalle demolizioni del 1822”, che però potrebbe costituire un semplice Colombarone (ripostiglio contadino di attrezzi e materiali vari con piccionaia, sovente usata in campagna) indipendente dal maniero antico, magari anche costruito nell’Ottocento, ed estraneo all’edificio castellare (anche se, su una sua parete, si può vedere ancòra adesso un deteriorato affresco, però riconoscibilmente di epoca quattro-cinquecentesca, che farebbe risalire la costruzione al periodo storico – visconteo – del Castello bellinzaghese) [Figura 132].

FIGURA 132 – Di tutto il complesso edilizio del Castello – che è stato distrutto nel primo ventennio dell’Ottocento – esisterebbe in pratica una sola presenza costruita rimasta (ma di ciò però sussistono serie riserve della sua effettiva attestazione certa) – nella immagine di un “unico torrione salvatosi dalle demolizioni del 1822” (Torre del Castello di Bellinzago Sec. XV, foto di Autore Anonimo e senza data): che però, ad osservare dalla sua attuale consistenza non proprio di tipologia difensiva bensì di attinenza rurale (a meno che si tratti di una posteriore trasformazione agraria) potrebbe costituire un semplice Colombarone (ripostiglio contadino di attrezzi e materiali vari con piccionaia sovrastante, sovente usata in campagna) magari anche costruito nell’Ottocento, ed estraneo all’edificio castellare (sebbene, su una parete di tale edificio, si possa vedere ancòra un deteriorato affresco raffigurante la Madonna con il Bambino, riconoscibilmente di epoca quattro-cinquecentesca – che farebbe risalire la sua costruzione al periodo storico del rifacimento castellàneo attuato da Anchise Visconti, avvenuto tra 1529 e 1545 – che poteva appartenere ad una vecchia muratura compatta, poi trasformata, nella parte superiore, in una configurazione edilizia a tipico reticolo mattonale: entro cui si svolgeva la raccolta vinicola e la sua prima trasformazione produttiva)
Concludendo la storia documentata del maniero collinare da me elaborata sempre su ‘Uomini e Terra’, “Un Castello di Bellinzago […] si ritrova indicato come ricostruito soltanto nel 1397 […] ed è lo stesso di cui nel Cinquecento risulta notizia di essere in possesso, e quale abitazione, dei Visconti di Aragona spagnoli: che appartenne poi a vari altri signori, e che nel Settecento (1735) passò ai Florio di Romagnano” prima citati, “restandovi di loro proprietà fino all’abbattimento dell’edificio per ordine degli ultimi suoi tenutari, i Demarchi, nell’anno 1822. Con maggiore precisione si sa comunque dai documenti esistenti che il maniero castellàneo nel 1529 è stato ricomposto dal suo nuovo proprietario, e residente, Anchise Visconti, Capitano d’Arme degli Sforza poi governatore di Novara, e che nel 1545 appare nominato quale possedimento di Ippolito Sforza Del Mayno, feudatario di referenza milanese, e dichiarato espressamente ‘castello superiore’ […]. Nel 1822, quando venne sostanzialmente demolito”, della sua antica storia si persero le tracce tanto fisiche (tranne che per ancòra rimasti cunicoli sotterranei quasi impraticabili, che si dice costituissero un condotto collegato al lontano castello di Cavagliano, irrimediabilmente sbarrati da detriti di cedimento del terreno) quanto oggettive, finendo “per costituire unicamente una memoria caratteristica dei Bellinzaghesi (perfino fantasiosa: perché è stato infatti lo sfondo di un romanzo storico, La Marchesina di Bellinzago pubblicato nel 1881, dello scrittore ossolano – perché il padre, bellinzaghese, era medico condotto a Premia nell’Ossola – Carlo Calcaterra, esimio letterato specializzato negli studi petrarcheschi, e Professore di Letteratura Ialiana in due Università, la Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Ateneo di Bologna)”.
Il Ricetto medievale dentro il borgo
Il maniero sulla collina – chiamato Castello Superiore non soltanto per la sua posizione eminente di posizionamento dall’alto, ma anche per distinguerlo dall’altro documentato incastellamento situato all’interno del borgo abitato di cui meno si conosce – è però stato individuato, ancòra dall’Andenna citato (che ne ha ripreso le indicazioni dalle Consegnazioni trecentesche) in un “Castello di Bellinzago, esistente già nel Millecento ma al centro del paese” e che “nel 1360 venne raso al suolo dalle truppe di Galeazzo II Visconti Co-Signore di Milano” (e molto probabilmente insieme all’intero borgo bellinzaghese, brutalmente devastato).
Si tratterebbe (seguendo sempre i riporti andenniani, questa volta rilasciati nel suo saggio sul citato libro Uomini e Terre e con una fotografia del 1988 esplicitamente titolata Bellinzago – Particolare di costruzioni sul perimetro del castello usato da ultimo rifugio di protezione dalle invasioni nemiche) [Figura 133] di un Ricetto situato all’interno del paese, realizzato …

FIGURA 133 – Autore ignoto (ma forse Giancarlo Andenna), Bellinzago – Particolare di costruzioni sul perimetro del castello, senza data (magari però del 1988). La fotografia riprende una parte (sulla Via Ardizio) del quadrilatero del Ricetto medievale bellinzaghese situato all’interno dei caseggiati abitativi del borgo (si veda la Figura 137)
… non con una esplicita sua architettura difensiva caratteristica di questo genere di edifici difensivi, ma con lo stesso criterio costruttivo-protettivo degli isolati abitativi dei rifugi dei Ricetti, di cui in Piemonte si hanno diversi esempi tipici, e particolarmente nelle località biellesi di Magnano e Candelo, che posseggono i due modelli più significativi di insediamento compatto entro un normale luogo abitato [Figure 134 e 135].

FIGURE 134 e 135 – I due più caratteristici esempi piemontesi (entrambi nella zona del Biellese) di ricetti medievali: nel borgo di Magnano (di cui si può notare la composizione toponomastica e muraria molto simile a quella di Bellinzago – si veda la Figura 125 – in una foto di Enrico Engelmann, Magnano – Strada Principale del Ricetto, 2017) [sopra] ed in quello di Candelo (in una istantanea di Paolo Barosso – Ricetto di Candelo – del 2020) [sotto]

E quello bellinzaghese si trovava proprio al centro del vecchio borgo medievale, nella posizione toponomastica attuale coincidente (essendo la strada della foto la “attuale Via Paolo Ardizio”, come mi ha confermato in uno scambio epistolare nel 2022 il già ricordato collega bellinzaghese Musetta: che devo sempre ringraziare per le sue precise notizie documentarie e referenze cartografiche) al lotto “da inquadrarsi nel quadrilatero all’interno delle vie Gramsci, Paolo Ardizio, Don Minzioni, Matteotti che corrisponde all’incirca a un ettaro, che è la superfice media dei ricetti nel nostro territorio” [Figure 136 e 137].

FIGURE 136 e 137 – Il quadrilatero sghembo delle vie Ardizio, Gramsci, Matteotti, e Don Minzioni (corrispondente all’isolato romano deformato in epoca medievale sulla castramentazione ortogonale di Roma antica) della grandezza – come epistolarmente mi ha confermato lo storico bellinzaghese Giacomo Musetta nel 2022 – pari “all’incirca a un ettaro che è la superfice media dei ricetti nel nostro territorio”): riportato nella topografia teresiana bellinzaghese del 1723 (particolare della Parte Superiore della mappatura catastale – ricavata dal Foglio 9. Di Belinzago: si veda la Figura 129 – nella sua conformazione borghiva e confrontata al Castello cosiddetto Superiore situato sul crinale collinare occidentale: foto di Corrado Gavinelli del 2022) [sopra], e nella situazione attuale (dettaglio della mappa del Comune di Bellinzago Novarese del 2022 di autore anonimo: foto di Corrado Gavinelli del 2022) [sotto]
 Figura 137
Figura 137
E’ qua che la popolazione di Bellinzago correva a rifugiarsi per proteggersi disperata dalla capitolazione delle altre difese. “Perché dal Trecento” – come sempre ho riferito nel mio saggio nel periodico telematico ‘Frontiere’ prima riportato, al paragrafo su Le fortificazioni medievali del paese – “i documenti storici riportano – sebbene con ambigua comprensione attestativa – della presenza, a Bellinzago” (come ho riferito sopra) “di due castelli: quello chiamato, con dizione antica proveniente dall’impianto romano, castro (che dovrebbe corrispondere all’intero paese, o ad una sua particolare parte fortilizia)” più interna (corrispondente al tradizionale Ricetto) “ed il più specifico castello superiore, attinente al maniero collinare dei Visconti aragonesi (e dei Del Mayno, e di altri)”. E risulta anche che – secondo quanto sempre racconta l’Andenna citato – la “comunità” bellinzaghese “aveva circondato l’intero abitato” (come era in uso già nei paesi pievani all’inizio del Medioevo, tra i secoli Novecento e Mille: e di cui il caso della altrettanto piemontese cittadina di Pinerolo, sotto le Alpi Cozie, dà una identica testimonianza fattuale tipica) “con un fossato, protetto anche da una fractam maiorem, o spessa siepe di rovi e biancospini acuminati intricati tra loro”: di cui non rimangono ovviamente tracce fisiche (se non vagamente nello scavo canalicolo successivo del cosiddetto fossalone ancòra esistente nell’Ottocento ed ai primi del Novecento, ripreso da diverse cartoline [Figura 138] “e passante davanti alla Chiesa periferica di San Clemente, allora ancòra fuori dall’abitato”: la quale, nelle Consignationes del 1347 viene significativamente indicata “posta all’oriente dell’antico castro […] dove si dice in Baraggia ovvero in Brea” e lungo la “Strada novarese”, ossia il percorso medievale sostitutivo della ormai disusata Via Maggiore di epoca imperiale romana – che ho altrimenti descritta nel mio saggio sulla Bellinzago di Belicio anche esso apparso su ‘Frontiere’ nel 2022 – e leggermente più addentrata nel territorio orientale) [Figura 139].

FIGURA 138 [sopra] – Dettaglio (di rielaborazione tecnica di Corrado Gavinelli del 2022) di una foto di autore ignoto del 1931 mostrante la copertura del Fossalone (canale scoperto di raccolta dei liquami e rifiuti domestici del paese) di Bellinzago che passava davanti alla parrocchiale di San Clemente (allora da poco restaurata dall’architetto novarese Giovanni Lazanio, tra 1928 e 1930) conservante ancòra la cunetta dello scolo delle acque sporche della strada prospiciente (la odierna Via Gramsci); ed il più lontano, davanti al sagrato, punt d’la gesa (ponticello della chiesa, segnalato dai due nuovi piloncini in sasso) che sovrappassava il fosso prima lasciato (come si dice) ‘a cielo aperto’
FIGURA 139 [sotto] – Particolare (foto di Corrado Gavinelli del 2022) della mappa vandoniana di Bellinzago del 1725 (ruotata su un lato per metterla nella stessa posizione della precedente fotografia della Chiesa di San Clemente – alla Figura 138 – indicata con la lettera A) mostrante la corrispondenza del Fossalone (che costeggiava la strada esterna del paese proveniente dalla chiesetta di San Grato, segnata con B) col canale di scolo della via perpendicolare di fronte all’edificio ecclesiastico: in cui si riconosce la ancòra vuota parte agraria oltre il perimetro urbano orientale dietro alla chiesa di San Clemente, che 4 secoli prima era molto più incolto e gerbido, all’interno di una estesa baraggia che andava fino al Ticino

Una condizione di speciale “recinzione difensiva” che “si può pertanto immaginare (anche osservando la più tarda permanenza di un analogo sistema protettivo attuato tipicamente per il castello settecentesco – con pali, fossato, e mura [Figura 140] – quale secolare proseguimento aggiornato della pratica legionaria di Roma attivata per le colonie e i castri di stazionamento urbano) composta cioè da un fosso più esterno (ottenuto dal vallo di scavo) eventualmente allagabile, da un declivio protetto con rami e sterpaglia – chiamati tecnicamente cervi per il loro aspetto di articolate fronde cornute – che rendevano più difficile l’arrampicamento, ma anche difeso con pali appuntiti, prima della più convenzionale chiusura di fortificazione composta da una robusta palizzata inizialmente, sostituita poi con opere in muratura” [Figure 141-143].

FIGURA 140 [sopra] – Particolare (foto di Corrado Gavinelli del 2022) della mappa del Castello di Bellinzago (si vedano le Figure 127 e 129) mostrante il sistema più elementare tipico della medievalità difensiva (con palizzata lignea, fossato allagato, e mura in pietra), lontanamente ripreso dalle opere fortificate di Roma antica (si vedano le Figure 141-143)
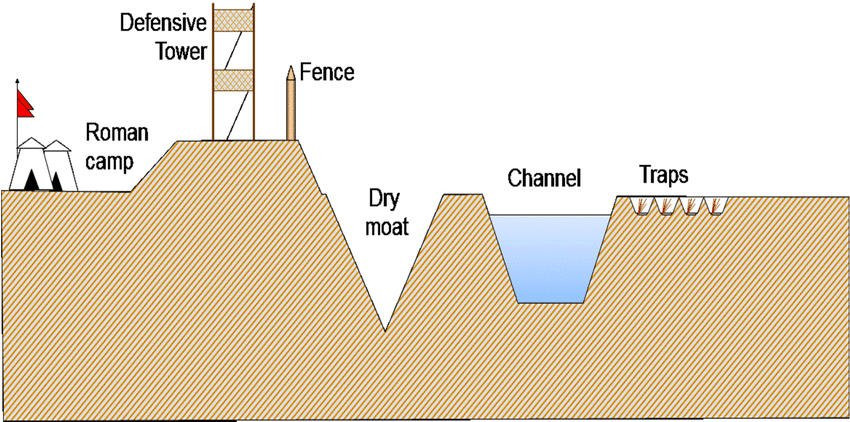
FIGURE 141-143 – Il sistema di fortificazione romano-antica, quasi invariatamente proseguito dalla epoca repubblicana fino alla tarda imperialità (e ripresa con varianti tecniche nel Medioevo): nella fortificazione di Caio Giulio Cesare all’assedio della città gallica di Alesia del 52 avanti Cristo (nella ricostruzione di Renato Drusiani – Schema delle fortificazioni del Campo Romano ad Alesia – del 2021, basata sulla descrizione desunta dal Settimo Libro della Guerra Gallica redatto dal condottiero romano tra 58 e 50) [sopra]; nel particolare del disegno ricostruttivo del 2008 – Le opere di assedio di Cesare ad Alesia (52 a.C.) – di autore anomino che si firma con lo pseudonimo Cristiano (in cui sono evidenziati i cosiddetti cervi: ramificazioni vegetali di rami e sterpi) [sotto]; e nel Dettaglio di un Tratto del Vallo Antonino (1 Fosso, 2 Arpioni di legno, 3 Berma – una piattaforma come un argine per contenere i cedimenti di terreno –, 4 Bastione o Vallo, 5 Parete frontale in pali lignei) di illustratore altrettanto ignoto ma pubblicato nel 2018 dallo storico australiano, e geometra misuratore di Parramatta vicino a Sydney, John Francis Brock (da non confondere con l’omonimo presidente statunitense della Coca-Cola) nel quale meglio si vedono i cornuti rami collocati a protezione dalla scalata del pendìo del bastione [in basso]. Per la cronaca, il muro antoniniano (lungo 60 chilometri) è stato costruito in soli 2 anni (nel 142-144) per ordine dell’imperatore Antonino Pio, all’estremo confine settentrionale della Scozia oltre la linea territoriale tra Glasgow ed Edimburgo, congiungendo le località opposte di Old Kirkpatrick e Bridgeness tra i fiumi Clyde e Forth: quasi un centinaio di anni dopo le difese alesiane, che in tutto misuravano 36 chilometri, e sono state invece finite in un solo mese e mezzo

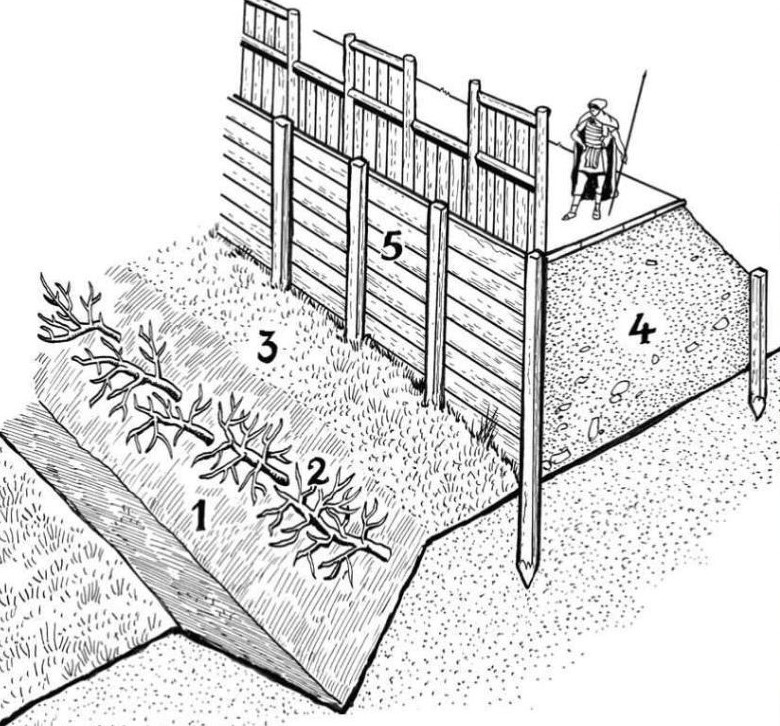
Ma anche per questo sito castellaneo, anche esso piuttosto avanti rispetto alla più tarda epoca longobarda (e comunque privo di ogni plausibile condizione di sicura ed isolata detenzione, specialmente turrita), resta senza possibilità oggettiva di avere potuto ospitare la regina imprigionata.
Il Castellaccio
Resta però ancòra, per il territorio bellinzaghese esterno all’abitato (ma abbastanza vicino, ache questo, al suo perimetro residenziale), la vecchia presenza di un altro edificio castellare minore, meno noto e in condizioni di pessima rovina già da presto, alla fine del Cinquecento, e poi per tutto il Seicento e fino all’Ottocento, ed ormai adesso totalmente scomparso: il cosiddetto Castellaccio, situato nella parte sud-occidentale di Bellinzago presso la vecchia Chiesa di San Materno (pure essa purtroppo distrutta; e della quale rimangono soltanto pochi resti di fondamenta documentate da una foto scattata dallo storico bellinzaghese mio omonimo Gian Michele Gavinelli) [Figura 144] e rintracciabile soltanto, ormai, in una …
 Figura 144
Figura 144
FIGURA 144 – Un esempio di tipica muratura medievale in ciottoli di fiume disposti a spina di pesce con corsi alternati di mattoni, in una Parete trecentesca del Castello di Cavagliano (foto di Corrado Gavinelli del 2022) morfologicamente e costruttivamente corrispondente alla muratura della Chiesa di San Materno (e quindi anche del propinquo Castellaccio) a Bellinzago (a cui per altro il maniero cavaglianese appartiene quale frazione meridionale). Già nella seconda metà del Duecento viene citato il Castello di Cavagliano nell’aspetto che si riconosce ancòra adesso (perché in origine la sua conformazione era totalmente diversa, e consistente in pratica in una sorta di Ricetto, di cui non si conosce tuttavia l’immagine storica, in possesso a “due coniugi di origine longobarda” che nel 1151 ne vendettero un magazzino “ad un prete di nome Bongioanni”), come possedimento dei conti di Biandrate; e nel 1324 lo si ritrova riferito al ricco e potente personaggio Paolo II Caccia (di provenienza da Romagnano, località del Novarese sul fiume Sesia). Qualche decennio dopo il maniero viene nominato anche nel manoscritto del cronista novarese Pietro Azario stilato in latino nel 1362-64. AVVERTENZA: QUESTA IMMAGINE NON RIPORTA I RESTI DELL’ANTICO BASAMENTO ECCLESIALE SANMATERNICO BELLINZAGHESE (IL CUI REPERIMENTO MI HA DATO SERIE DIFFICOLTA’ DI RINTRACCIAMENTO DELLA SPECIFICA FOTO SCATTATA DA GIAN MICHELE GAVINELLI, DI CUI SONO ANCòRA IN FASE DI SUA RICERCA: E CHE PROVVEDERO’ A SOSTITUIRE QUANDO NE AVRO’ RITROVATO L’ORIGINALE) BENSI’ COSTITUISCE SOLTANTO UN ESEMPIO SIMILE DEL GENERE DI SISTEMA COSTRUTTIVO UTILIZZATO ALL’EPOCA PER LE COSTRUZIONI EDILI
… generica localizzazione topografica nella mappatura del Catasto Teresiano del 1722 aggiornata all’anno successivo (sul lotto segnato 963) ma non più riportata – perché ormai andata del tutto demolita – nella cosiddetta Mappa Rabbini (rilevatura cartografica in tale modo chiamata dal cognome del suo delineatore, il geometra misuratore Antonio, nominato – nel 1853 dal Presidente del Consiglio del Regno Sardo-Piemontese Camillo Benso Conte di Cavour – alla direzione generale del Catasto presso il Ministero delle Finanze) disegnata nel 1866 [Figure 145 e 146].

Figure 145-146 – La posizione del Castellaccio di Bellinzago nei pressi della Chiesetta di San Materno (che era molto probabilmente la cappella del fortilizio) fuori dall’abitato bellinzaghese nella mappa teresiana del 1723 (si veda la Figura 130) ai Numeri 963 (l’edificio ecclesiale) e 964 (il fortilizio) [sopra], ed in quella del rilievo catastale di Bellinzago del geometra piemontese Antonio Rabbini del 1866 (ai corrispondenti Numeri 2630 e 2631, segnati con pallino bianco) [sotto]
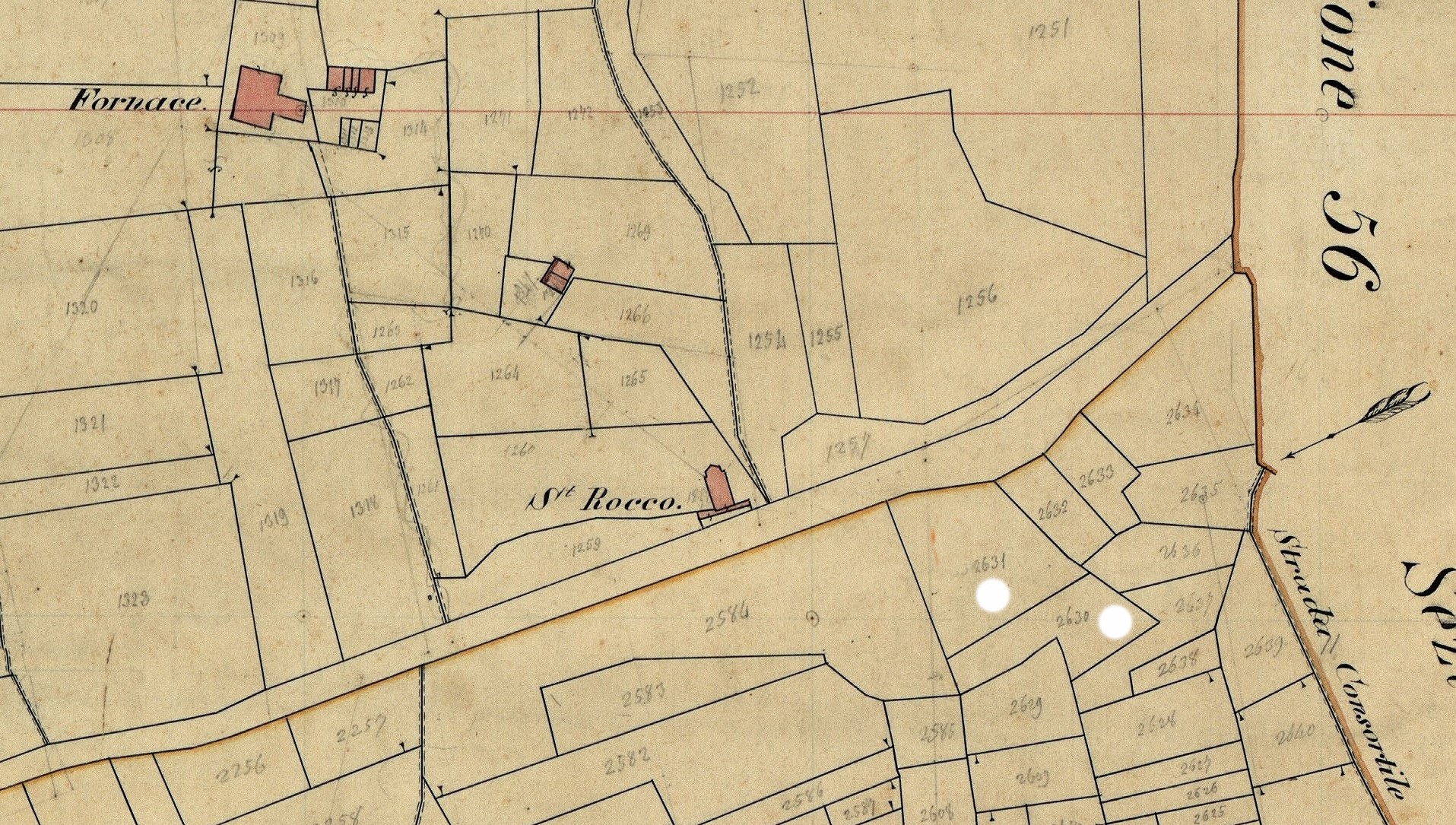
Ed infatti in questa ultima cartografia ogni fisica esistenza del passato storico appare ormai totalmente cancellata [Figure 147 e 148].

FIGURE 147-148 – La posizione antica del Castellaccio di San Materno (pallino blu) nella topografia odierna (riportata sulla mappatura bellinzaghese di autore anonimo di Digiland – Bellinzago – Mappa – senza data: riproposizione di Corrado Gavinelli del 2022) [sopra] presso al rimasto Oratorio di San Rocco (pallino rosso). L’edificio ecclesiastico maternesco nella catastazione tersiana (al Lotto 963: si veda la Figura 145) risulta ancòra esistente (in quanto demolito dopo, nel 1847) mentre il maniero suo vicino non compare (perchè probabilmente costruito sullo stesso appezzamento di terreno di cui la chiesetta era parte quale elemento di culto religioso interno; oppure, secondo una congettura musettiana espressami epistolarmente nel 2022, edificato nella vicina particella agraria: “I ricordi orali lo volevano sulla collina nella mappa teresiana presso s. Materno […] presumibilmente sul mapp. 964”) poiché precedentemente distrutto. Gli stessi lotti nella cartografia rabbiniana – come poco sopra indicato: si veda la Figura 146) si trovano (contrassegnati con pallini bianchi) al “n° 2630” (la chiesa) e al propinquo 2631 (il castelletto) lungo la nuova strada per Alzate conducente alla Stazione Ferroviaria: proprio di fronte (leggermente spostata di sghembo verso il paese, sulla destra nella mappa, oltre la Strada Comunale) all’Oratorio di San Rocco, opera quattro-cinquecentesca riplasmata, su una preesistenza romanica, al massimo nel Trecento [sotto].

E la conclusione è – secondo quanto proviene sempre dalle indagini musettane – che “Possiamo solo pensare che il muraglione nei pressi di S. Materno […] in ciotoli di fiume possa essere la sola traccia dell’antica fortezza di cui parlano le vecchie leggende”: poiché la chiesetta è stata costruita nel tardo Cinquecento, e quanto si intravvede ancòra appartiene al basamento dell’edificio ecclesiastico ormai già distrutto: certamente più antico, non soltanto a giudicare dalla modalità costruttiva utilizzata, di caratteristica edilizia medievale tra Millecento e Millequattrocento (e nello specifico trecentesca: e di cui si possiede un paritetico esempio costruttivo locale nelle citate pareti del Vicino Castello di Cavagliano) [Figura 144] e però proseguita – nelle località non urbanizzate di provincia – fino a tutto il Cinquecento; ma riconoscibile anche per la sua non sopravvivenza alla costruzione castellare (che non può comunque risalire ad epoca inferiore, e tanto meno al periodo longobardico).
Conclusione che per altro viene confermata anche da un altro breve saggio del già citato Don Francesco Marchi pubblicato sul ‘Bollettino Storico della Provincia di Novara’ sempre del 1992 con il titolo San Materno, in cui egli dichiara che “Lontano dal paese sulla sommità del colle ai limiti della parrocchia di Bellinzago sorgeva nel 1585 la chiesa campestre di San Materno […]. Il Vescovo Speciano” (che ebbe la carica episcopale di Novara dal 1584 al 1591) “notò che era tenuta in modo indecente” e che la trascurata sua incuria aveva aumentato “il deperimento dell’edificio” in una pietosa condizione per cui “la chiesa minacciava di cadere da tutte le parti” ed era perfino difficile “raggiungerla essendo circondata da rovi. Uguali osservazioni registrava nel 1618 il cardinal Taverna e pertanto l’edificio era lentamente destinato a scomparire”. Come fatalmente poi infatti avvenne nel trascorrere degli anni, ma anche per le trasformazioni giuridiche d’uso “con l’età napoleonica e la nuova proprietà delle terre” (sebbene altre notizie ne riportano la demolizione al 1847, in epoca post-napoleonica e dopo-Restaurazione).
Non potendo, infine, escludere che peraltro Castellaccio e San Materno fossero, nei tempi antichi, entrambi parte di un unico fortilizio bellinzaghese decentrato, di cui la chiesa san-maternica costituiva la cappella interna, non possedendo immagine alcuna del suo aspetto fisico, si può immaginae che la consistenza morfologica del vecchio Castellaccio bellinzaghese possa riportasi all’elementare composizione semplicissima del citato castello di Domofole in Valtellina [Figura 149], anche esso storico riferimento eodolindico, di leggenda e storia.
 Figura 149
Figura 149
FIGURA 149 – Per avere una analoga idea della consistenza morfologica del Castellaccio bellinzaghese nella sua entità di maniero difensivo (con caseggiati interni) e chiesa di culto (San Materno), ci si può genericamente riferire alla situazione – adesso in ruderi – del già considerato Castello di Domòfole in Valtellina (foto con drone di Davide Galloni del 2020; si veda anche la Figura 21), che si presenta nella composizione castellanea più elementare [in basso]
Ed anche comunque per questo ultimo possibile riferimento bellinzaghese al luogo di imprigionamento della Regina Teodolinda, non si può minimamente giungere a credere ad una qualunque sua frequentazione da parte della donna longobarda, persona vissuta quasi un millennio prima.
Una vera disdetta, questa, di non potere accertare la autenticità della leggenda bellinzaghese di Teodolinda, e lasciarla alla sua fantasiosa invenzione di non si sa quale favolistico narratore nostro predecessore o antenato. Al quale dobbiamo però riconoscere il merito di avere dato ai Bellinzaghesi una mitica opportunità storica, improbabile nei fatti ma possibile nella immaginazione (che ad ognuno potrà concedere di vedersi la bella regina dietro le sbarre di una malinconica prigione su una torre dimenticata) [Figura 150].
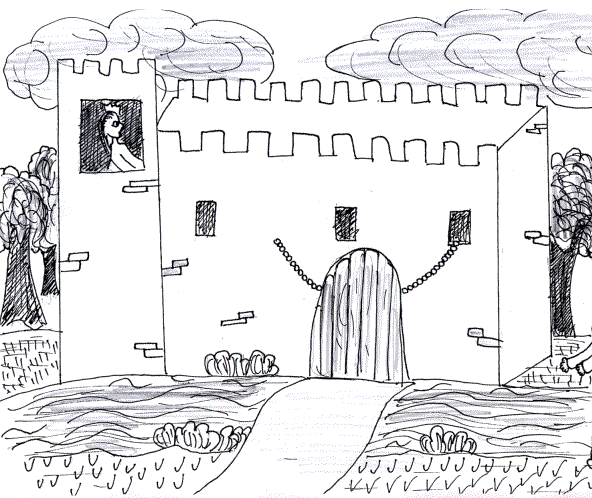
FIGURA 150 – La infantile rappresentazione della stereotipata Principessa nella torre prigioniera, come immaginata Regina Teodolinda nel Castellaccio, in un odierno disegno (non datato) della bambina veneta Gioia Berto, studentessa di Scuola Elementare
E però una storia che in conclusione, può avere una giustificazione nel fatto che la fazione novarese anti-teodolindica, approfittando di un viaggio padano della regina con sosta ritenuta sicura nel Castello oleggese, riconosciuto borgo dei Longobardi (“qui dicitur Langobardorum” di andenniano riporto), la abbia intercettata e temporaneamente rinchiusa in un fortilizio ignoto non distante, a Bellinzago, liberandola poi in circostanze altrettanto sconosciute per riscatto o conclusione delle ostilità interne alle faide di potere logobardiche. Ciò che farebbe risalire l’episodio, comunque, al 626 dopo Cristo.
LE TORRI TEODOLINDICHE
Non solo di presunti castelli e torri di prigionia narrano le leggende su Teodolinda, ma nella storiografia (non sempre anche essa vera) longobarda (e, come sempre, anche successiva) esistono varie presenze di edifici turriti attribuiti alla regina monzese o soltanto a lei riferiti per diretta appartenenza o per traslato epocale.
Gli edifici longobardi a torre rimasti in Piemonte
Sebbene non molte, e disperse nei loro territori di appartenenza con nessun riferimento reciproco, le torri teodilindiche si ritrovano abbastanza lontane dalla Lombardia, e piuttosto concentrate nella zona piemontese dell’Alessandrino, e di Santhià [Figura 151].

FIGURA 151 – Corrado Gavinelli, Le posizioni delle rimanenti torri teodolindiche (vere o falsamente attribuite) della tradizione padana, estese sul territorio lombardo-piemontese dalla bassa Valtellina alla città torinese, 2022 (da destra a sinistra e dall’alto in basso: in rosso, Domòfole, Monza, Bellinzago Novarese, Santhià, Lomello, Spinetta di Marengo, Bobbio; e in blu, Asti e Torino: mappatura effettuata sulla già citata Carta della Italia Settentrionale di Tutto Città)
La torre più tipica – e autentica questa volta – cui fare riferimento è quella a Monza rimasta come unica testimoniananza (e parziale: perché decurtata della propria altezza e variamente modificata) dell’antico Palazzo Reale longobardo, che adesso (come ho mostrato più sopra) si trova inserita nello stretto vano esterno a ridosso della Cappella di Teodolinda [Figura 152].

FIGURA 152 – L’aspetto odierno, rimasto dalle demolizioni trecentesche, della Torre Longobarda all’esterno del Duomo di Monza, incastrata contro il poligono absidale esterno della Cappella di Teodolinda (da una foto di Alberto Mos del 2011, con raddrizzamento prospettico di Corrado Gavinelli del 2022: si vedano le Figure da 76 a 78 e da 79 a 81)
Il suo volume parallelepipedico e la propria sagoma compatta si mostrano piuttosto simili alla altra Torre di Teodolinda presente a Spinetta (presso Alessandria, non lontana dal Castello e nell’antico borgo alto-medievale di Marengo) nel proprio stato attuale, datata (secondo lo storico locale Piero Archenti che ne ha scritto nel 2021 in un suo articolo – Sulla Torre di Teodolinda regna…l’incertezza – apparso su ‘CorriereAL’, il periodico telematico di Alessandria e Provincia) “fra l’VIII e il XIII secolo”; ma la cui iniziale esecuzione risale al 594-606 (e dunque risulta almeno di accertata epocalità longobarda, se non proprio esattamente teodolindica) [Figure 153 e 154].

FIGURE 153 e 154 – Le Torre Longobarda a Spinetta (presso Alessandria, non lontana dal Castello e nell’antico borgo alto-medievale di Marengo) in una foto recente (del 2018) di autore anonimo (Torre Longobarda di Teodolinda) [sopra] ed in una vecchia cartolina (Marengo – Antico Torre) di autore ignoto e senza data (ma forse del fotografo milanese Luigi Lombardi, e probabilmente del 1909) [sotto]; di cui lo storico locale Piero Archenti nel 2021, in un suo articolo (Sulla Torre di Teodolinda regna…l’incertezza) apparso su ‘CorriereAL’, il periodico telematico di Alessandria e Provincia, riferisce: “torre quadrata che risale […] ad un’epoca storica collocata fra l’VIII e il XIII secolo”, e che accertamenti archeologici rimandano ad una precedente costruzione sottostante del 594-606 di età inequivocabilmente longobardica, anche se non proprio esattamente teodolindica
 Figura 154
Figura 154
Ma differiscono nelle geometrie – elementare o composita – gli altri edifici turriti ritenuti, o tradizionalmente così chiamati, torri teodolindiche in altre località piemontesi: come è quella cilindrica di Santhià [Figura 155], che nel suo aspetto attuale evidenzia – per “i materiali impiegati nella sua costruzione e i suoi stessi caratteri strutturali”, attesta un compilatore anonimo del sito telematico SanthiàTurismo – denuncia una provenienza trecentesca che comunque “deriva dal rifacimento di una torre di avvistamento di epoca longobarda”.

FIGURA 155 – Mikki65, La Torre di Teodolina, 2009, senza data – Il torrione cilindrico di Santhià, nella sua situazione attuale è tuttavia un edificio trecentesco, come mostrano i materiali costruttivi utilizzati ed il proprio stesso caratteristico sistema edilizio
Sussiste poi in Monza una seconda Torre di Teodolinda, che in tale caso è solamente nominale, in quanto oltre ad essere stata costruita nel Milleduecento essa apparteneva agli elementi difensivi della città, divenuta poi una porta di transito delle merci provenienti dal Lambro da smistare sui mercati delle piazze urbane principali, e inglobata infine nel palazzo della famiglia Pessina che vi riscuoteva il dazio [Figura 156].

FIGURA 156 – Remulazz, Monza – Torre di Teodolinda, 2008. Anche questo torrione di ingresso urbano, risalente al Duecento, apparteneva in origine alla recinzione difensiva del borgo monzese, diventando poi la porta di transito delle merci provenienti dal Lambro condotte alle piazze principali di Monza per il mercato, integrandosi nel palazzo della famiglia Pessina che qui riscuoteva il dazio
Ed infine un ultimo edificio, ma non turrito bensì di utenza residenziale, di presunta pertinenza teodolindica, è il Palazzo Alcarini a Bobbio, che per tradizione popolare è ritenuto la dimora della regina Teodolinda: si tratta però di una affermazione falsa proveniente da una fantasiosa induzione localistica priva di ogni consistenza storica, che le stesse caratteristiche architettoniche della costruzione del resto propongono riferirsi al Trecento [Figura 157].

FIGURA 157 – Solaxart, Bobbio: Palazzo Alcarini o Casa di Teodolinda (XIX secolo), 2020. L’autore, nel titolo della sua foto, probabilmente voleva scrivere XIV secolo (quale è in effetti la data dell’edificio) sbagliando distrattamente la cifra nella trascrizione didascalica. Anche in tale caso la tradizione popolare attribuisce, ma erroneamente, tale caseggiato nobiliare bobbiese alla sovrana longobarda, che in questa località emiliana ha fatto realizzare la famosa Abbazia di San Colombano, che era il suo predicatore privilegiato, recandosi sul posto per scegliere il terreno da edificare (e talvolta – forse – per seguirne la esecuzione costruttiva
Anche perché la regina longobarda non ha mai frequentato il contesto bobbiese se non nella occasione della scelta del terreno dove erigere il Monastero e la Abbazia da lei donata a San Colombano (o per eventuali altri sopralluoghi di verifica dei lavori o di circostanziale incontro con il predicatore suo consigliere, non comunque di lunga durata).
Le Torri degli Zavattari
Negli affreschi del Ciclo della Storia della Regina Teodolinda già in precedenza variamente analizzati, gli Zavattari (o altrimenti il Troso di Giovanni Jacobi già sopra considerato, cui è probabile siano state affidate le parti di sfondo e non l’apparato delle figure umane ed animali delle scene a causa della sua specialità di prospettiva architettonica ed in elementi di paesaggio: ed infatti si scorgono abbastanza bene le diversità di esecuzione delle parti complementari negli affreschi, di ambiente e di decoro, più schematici e rozzi – ed anche di vedutismo irreale e metafisico – rispetto alla distensiva omogeneità espressiva, perfino realistica, dei soggetti viventi zavattarianamente rappresentati), hanno completato ogni loro episodio narrativo con immagini di vegetazione, di città, e di aspetti edilizi, in cui risaltano soprattutto gli elementi turriti.
Le torri nella Cappella sono davvero tante e diffuse, e di variegata forma esteriore, a conferma di quella fitta presenza costruita verticale che sensibilmente connotava città e castelli nel Medioevo; che forse non soltanto è finita per essere l’emblema difensivo della medievalità conflittuale in una epoca storica (quella quattrocentesca nella quale sono stati dipinti gli affreschi teodolincici) di scontri e conquiste, ma perché rappresentano anche gli elementi singolari della potenza politica dei signori e del loro rango sociale (come bene attesta la rivalità turrita realizzata nei loro torrioni di casa dalle famiglie importanti a San Gimignano) [Figure 158-159 e 160-161].
 Figura 158
Figura 158

FIGURE 158 e 159 – Taddeo Di Bartolo, San Gimignano Da Modena con il Modello della Città di San Gimignano, 1401-03: opera intera [sopra] e particolare del plastico del borgo turrito [sotto] (foto di Corrado Gavinelli del 2022): si vedano anche le figure 160 e 161)

FIGURE 160 e 161 – Due vedute sangimignanesi, in una incisione su legno dell’artista francese Alfred Louis Sargent, del 1877 (San Gimignano, ripresa da un disegno del pittore connazionale Philippe Benoist) [sopra], e in una veduta aerea del fotografo giapponese Kasa Fue, del 2021 (Vista su San Gimignano in Toscana) [sotto]

E come nel famoso affresco raffigurante Guidoriccio Da Fogliano all’Assedio di Montemassi dipinto nel 1328 dal noto pittore senese Simone Martini nella Sala del Consiglio del Palazzo Pubblico di Siena, mostrante i caratteristici borghi fortificati pullulanti di svettanti torri civiche all’interno delle loro mura difensive, una città dalle tante torri ugualmene si distingue quale espressione dominante del territorio [Figura 162] nei dipinti zavattariani: ed anche essa …

FIGURA 162 – Il famoso affresco raffigurante Guidoriccio Da Fogliano all’Assedio di Montemassi dipinto nel 1328 dal noto pittore senese Simone Martini nella Sala del Consiglio del Palazzo Pubblico di Siena, con i caratteristici borghi fortificati pullulanti di svettanti torri civiche al loro interno
… quale particolarissimo luogo urbano articolato, addensato di caseggiati a torre, emergente dal fondo di una scena della storia teodolindica monzese [Figura 163].

FIGURA 163 – Corrado Gavinelli, Com’era Monza nel 1444, 2022: particolare dell’affresco degli Zavattari nella Cappella di Teodolinda nel Duomo monzese
E altro essa non è che la città di Monza nella sua situazione quattrocentesca, il cui sicuro riconoscimento di autentificazione si risconta attestato dalla presenza della rossa (di mattoni non intonacati) Torre Longobarda dietro il Duomo, già allora in evidente rovina (a causa della parziale demolizione della sua altezza originale attuata nel 1394-95) [Figura 164].
 Figura 164
Figura 164
FIGURA 164 – Dettaglio del precedente dipinto con la Torre Longobarda (in rossso, segnalante la sua costruzione in rossi mattoni a vista) già diroccata (il suo abbassamento avvenne nel 1394-95) [foto di Corrado Gavinelli del 2022]
E di questa monzesità ulteriormente attestano altri dettagli dell’affresco, tanto nella configurazione topografica degli edifici circostanti al duomo, quanto nelle stesse facciate di alcuni di essi. Il fronte basilicale principalmente, che si mostra del tutto diverso da quello noto trecentesco, e con due portali anteriori sul genere di alcune chiese romaniche ed arcaiche (come quella, in Monza, del cosiddetto Pratum Parvum, vicina al Duomo, riportata nella ricosruzione monzese trecentesca del Merati in precedenza indicata) [Figure 165 (si veda la Figura 83) e 166-167]

FIGURE 165 e 166-67 –
La antica conformazione morfo-tipologica della basilica sanbattistina di Monza, riconoscibile nella sua presenza dietro al Duomo, storicamente retrocedente – se non proprio alla epopea della regina longobarda – nella sua possibile (così ricostruttivamente dipinta dal Troso negli affreschi zavattareschi) conformazione pre-trecentesca e post-teodolindica [sopra]. Questa raffigurazione di una basilica monzese arcaica mai iconograficamente conosciuta, dalla sembianza scarna e semplificata, con due identici portali semplici separati ed un rosone elementare, nonché un riconoscibile fregio ad archetti sotto il timpano dell’edificio, nell’affresco in questione riporta un altro esempio simile, di epoca due-trecentesca, quello della Chiesa del Pratum Parvum, ovvero del Piccolo Campo usato anticamente per spazio del mercato) [sotto]; che si ritrova anche attestato nella ricostruzione trecentesca di Monza eseguita nel 1831 dal citato Merati [in basso] (tutte foto di Corrado Gavinelli del 2022)
 Figura 166
Figura 166
 Figura 167
Figura 167
Una versione di duplice ingresso abbinato altrimenti visibile nella Facciata della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco di Assisi in Umbria costruita tra il 1228 ed il 1253 – [Figura 168] – che ancòra si può riscontrare adesso nella foto di Roland Nizet del 2013; e provenienti dalla vetusta tradizione separatoria dell’antichissimo uso ebraico della mechitza, divisione parietale fisica attuata nelle vecchie sinagoghe israelitiche.

FIGURA 168 – La approssimata rappresentazione zavattaresca di facciata a doppio ingresso accostato per le chiese monzesi prima del Trecento, si può più tipologicamente rinvenire nella sagomata definizione architettonica degli organismi ecclesiali di stile romanico, che possiede un referente iconografico maturo, piuttosto similare compositivamente, nella Facciata della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco di Assisi in Umbria (quale si può vedere nella foto di Roland Nizet del 2013) costruita tra il 1228 ed il 1253
Conformazione a doppio ingresso dunque, separato per uomini e donne, il cui tipo storico risale, nella sua forma matura pienamente romanica, alla millecentesca Abbazia di San Pietro a Moissac, nella Francia occitana, sopra Tolosa, del 1107-09 – che si evidenzia con una eccedente elaborazione decorativamente sontuosa – e si ritrova caratteristicamente ricomposta nei tre Portali gotici del fronte ecclesiale della Cattedrale di Nostra Signora a Parigi, edificati con singola continuità dal 1198 al 1230 [Figure 169 e 170].

FIGURE 169 e 170 – La conformazione doppia di portale di ingresso distinto ed accostato proviene, nella sua forma matura pienamente romanica, dalla millecentesca Abbazia di San Pietro a Moissac nella Francia Occitana presso Tolosa (la quale esteriormente si presenta però con una molto esuberante elaborazione scultorea), il cui Portone è stato realizzato nel 1112-13 (come egregiamente lo si percepisce nella foto del Portale di San Pietro a Moissac di Riccardo Alberto Quattrini del 2020) [sopra]; e la cui tradizione formale risale ai tempi remoti del Cristianesimo, prescrivente una “rigida simmetria mirata a tenere separati gli uomini dalle donne, nel rispetto della normativa dell’epoca” – secondo quanto risulta confermato in una scheda recente, del 2019 – del FAI (Fondo Ambiente Italiano) compilata dalla cronista e scrittrice italo-tedesca Christiane Bürklein (linguista e traduttrice di adozione genovese) a proposito della Chiesa ad Alessandria realizzata nel 1929-30 realizzata dal noto architetto piemontese Ignazio Gardella – con “due distinti ingressi” che “portano all’interno”, seguendo l’antichissimo uso ebraico della mechitza, divisione separatoria attuata nelle vecchie sinagoghe israelitiche. Una versione tipologica, quella moissachiana, di un complesso percorso successivo con ingressi ecclesiali bi-portali che nella Cattedrale di Nostra Signora a Parigi ha il suo pieno compimento nelle aperture del proprio maestoso fronte, con le tre successive porte duecentesche di Santa Anna (la più vecchia, del 1198-1204), della Vergine (1210-1220), e del Giudizio Universale (1220-30: questa ultima situata al centro nella foto del 2019 di un anonimo autore della piattaforma di rete telematica AlterVista riportante la parigina Facciata di Nostre-Dame) [sotto], tutte ovviamente meno sobrie della basilica francescana ma anche esse di abbondante plasmazione scultorea decorata

FIGURA 170 – I tre portoni frontali della Chiesa di Nostra Signora a Parigi, rispettivamente (da sinistra a destra) Santa Anna (la più vecchia, del 1198-1204), del Giudizio Universale (1220-30) e della Vergine (1210-1220)
A riprova tangibile che gli esecutori dell’aspetto più vecchio della basilica monzese nel dipinto zavattariano poco sopra riferito, hanno cercato di rifarsi non ad una anacronistica attualità quattrocentesca, ma ad una precedente immagine della chiesa, corrispondente ad una epoca passata e più cronologicamente storica (se non proprio esattamente di riferimento alla specifica età longobardica, almeno di poco dopo).
Ed in questa reinventata città monzese ampiamente fortificata pittoricamente, riportata alla propria epoca ed alle possibili esistenze trecentesche, anche essa comunque tipica per le variegate presenze turrite dalle forme a parallelpipedo o cilindriche ovunque diffuse anche nelle altre scene della Cappella di teodolinda, si possono riscontrare numerosi esemplari variegati [Figure 171-174]: proprio come nelle rimaste campionature longobarde, dislocate sul territorio piemontese precedentemente esaminate.
 Figura 171
Figura 171  Figura 172
Figura 172
FIGURE 171-174 – Alcune tipologie di varie torri tardo-gotiche, di genere squadrato con merlature e caditoie [sopra] e di forma cilindrica [sotto], eseguite negli affreschi per gli Zavattari da parte del Troso) nella Cappella teodolindica a Monza
 Figure 173 e 174
Figure 173 e 174 
CONCLUSIONE
E’ dunque così giunta alla fine questa mia escursione storico-indgatoria sulla verifica di una leggenda paesana molto scarna e sintetica, alquanto perentoria nella sua affermazione attestativa ma purtroppo debole e carente nella propria consistenza di sviluppo narrativo.
Teodolinda è stata un personaggio importante, e … leggendario; che ha eccitato la fantasia erratica di molti narratori anche a discapito della verità.
E come tante storie inventive, il suo lontano e smarrito ricordo epocale non ha mai mancato, anche di soppiatto e nelle circostanze perfino più impensabili, e al limite dell’assurdo, di uscire dalla oscurità delle epoche passate e pressocchè dimenticate, rimandando una propria eco di presenza storica: non sempre nitida e reale, ma di persistente suggestione.
Torre Pellice, Aprile-Luglio 2022
Corrado Gavinelli
FIGURA 175 –
Biografia professionale sintetica di Corrado Gavinelli
Corrado Gavinelli, nato a Gattinara (Vercelli) nel 1943, è Architetto, laureato alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano (Italia) nel 1970 (tesi con relatore Aldo Rossi).
In Emeritazione dal 2009 dalla Facoltà di Architettura dello stesso Politecnico milanese, in questo ateneo è stato (dal 1970 al 1975) Assistente Incaricato alla Cattedra di Storia e Stili della Architettura (di cui era titolare Paolo Portoghesi), diventandovi quindi Professore Incaricato di Storia dell’Architettura dallo stesso anno 1975.
E’ divenuto poi Professore Incaricato, per il medesimo insegnamento, nel 1984, e dall’anno successivo (1985) ha ricevuto anche la nomina per il Corso sperimentale di Storia dell’Architettura Contemporanea, di cui è stato poi confermaato titolare, dal 1998, come Professore Associato.
Inoltre è stato (dal 1996 al 2010) Professore Straniero (Gaikokujin Kyoshi) di Storia della Architettura alla Facoltà di Arte e Progettazione della Università di Tsukuba (Giappone), e – nella stessa nazione nipponica, e nel 2005 e 2009-10 – Professore Temporaneo alla Scuola delle Arti di Sapporo.
E’ stato anche, dal 1975 al 1989, Professore di Storia della Comunicazione Visiva all’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Urbino (Italia), e Lettore al CERN (Centro Europeo per la Ricerca Nucleare) di Ginevra (Svizzera).
Ha collaborato con le più importanti riviste di architettura italiane (e lavora ancòra per alcune di esse): tra cui Casabella, Domus, Modo, Controspazio, Spazio & Società, Costruire, Costruire in Laterizio, Chiesa Oggi – di cui è Membro del Comitato Scientifico –, L’Arca, OFX, Recuperare, Recupero & Conservazione, Ottagono, Design, Flare, HU, Nuova Finestra, Vetro, OfArch, DHD, D-Lux), nonché per i Periodici Telematici ‘Frontiere’ e ‘Thema’.
E’ Direttore della Collana ‘Architetti Contemporanei’ per la Jaca Book di Milano, e lo è stato della Collana di ‘Architettura e Arte’ per Alinea di Firenze.
Ha pubblicato numerosi libri (tra cui Novara e Antonelli, Archivio Storico, Novara, 1975; Città e Territorio in Cina, Laterza, Bari, 1976 (tradotto in spagnolo da Blume di Madrid nel 1979); L’Asilo Infantile De Medici, San Gaudenzio, Novara, 1976; Il Centro Storico di Oleggio, Mora, Novara, 1977; Piemonte e Valle d’Aosta, Pozza, Vicenza, 1981; Il Santuario Antonelliano a Boca, Del Forno, Maggiora, 1988; Ai Piedi dei Grattacieli, Meeting, Rimini, 1992; Storie di Modelli Esibitivi e Critici, Alinea, Firenze 1993; Architettura Contemporanea dal 1943 agli Anni Novanta, Jaca Book, Milano 1995 (tradotto in spagnolo da Libsa di Madrid nel 1999); 581 Architects in the World, Toto, Tokyo, 1995 (in giapponese); Milano. Professional Guide, Kikukawa, Tokyo, 1998 (in giapponese); Neue Moderne Architektur, Kohlhammer, Stoccarda, 1998; L’Architettura di Leonardo Ricci, Claudiana, Torino, 2001; Paolo Soleri. Itinerario di Architettura, Jaca Book, Milano, 2003; My Impressions on Seike, SSoA, Sapporo, 2005; Ar-chi-tec-tu-ra, Jaca Book, Milano 2009; Luoghi della Pace, Jaca Book, Milano, 2010.
Ha curato le Enciclopedie di ‘Architettura del XX Secolo’ per la Casa Editrice Jaca Book (argomenti su Moderno e Post-Moderno), e delle ‘Religioni’ per le Edizioni Paoline (Estetica Protestante: Arte e Architettura).
Ha tenuto numerose Conferenze, in tutto il mondo, sulle tematiche della Architettura, del Design, e dell’Arte Visiva.
Ha organizzato parecchie Mostre ed Esposizioni sugli argomenti dei propri interessi di ricerca, e nel 1988 ha progettato e realizzato la sistemazione e l’allestimento del Museo Antonelliano a Boca Novarese.
Ha partecipato, come Consulente Storico e Collaboratore Propositivo, a diversi progetti di intervento architettonico ed urbanistico per Concorsi in gruppi progettuali (i cui principali risultati vincitori sono stati: la Sede Piemontese del Parco del Ticino a Cameri, nel 1991 (con lo Studio Colbertaldo di Milano), parzialmente eseguita; la Risistemazione della Piazza Santa Anna a Bergamo, nel 1997-2000 (con lo Studio Russo di Bergamo), totalmente costruita; e il Nuovo Mobilificio Moretti a Piandimeleto nel 2007 (con lo Studio Tartaglia di Milano), non realizzato).
Nel 1985 è stato insignito della Medaglia di Riconoscimento UIA (Unione Internazionale degli Architetti) alla Biennale Mondiale di Architettura di Sofia, per la propria attività storico-critica.
Nell’àmbito delle attività di cultura locale nel Pinerolese (dove attualmente abita, a Torre Pellice) è stato Membro della Società Storica Pinerolese (SSP), del Centro di Studi e Museo di Arte Preistorica di Pinerolo (CeSMAP), e di Italia Nostra (Sezione Pinerolese). Inoltre, ha collaborato per il Settimanale ‘Eco del Chisone’ (Settore Architettonico-Urbanistico), e per il periodico ‘Vita Diocesana Pinerolese’ (Pagina della Cultura: argomenti di Storia e Architettura-Urbanistica-Paesaggio). E per Torre Pellice è stato Membro Esterno della Commissione Edilizia Comunale (Settore Paesaggistico).
Per l’àmbito progettuale territorial-paesistico si è particolarmente occupato della sistemazione giardinistica sull’area del Parco del Ticino a Cameri (Italia) nel 1990-91, e per una proposta (con incarico ufficiale di ricerca ed elaborazione propositiva) di Analisi e Risistemazione Giardinistica della Univesità di Tsukuba (Giappone) nel 2009-2010.
Ultimamente si è specializzato nella Ricerca Iconologica (Studio delle Immagini e loro Riconoscibilità e Interpretazioni).
Pubblicazione gratuita di libera circolazione Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito Qualsiasi richiesta ingiustificata verrà considerata un abuso e potrà essere segnalata alle autorità competenti